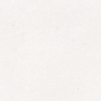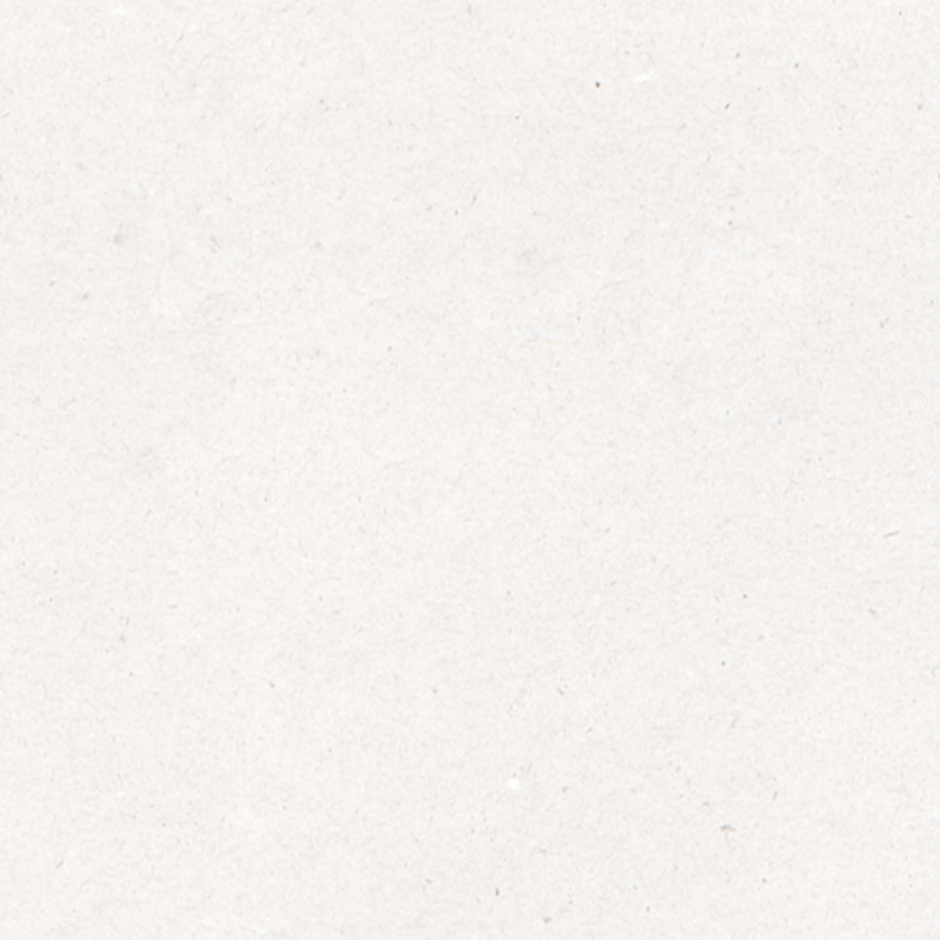Parte 6°
aspetti politici ed economici
dei paesi in via di sviluppo
EVOLUZIONE DEI REGIMI POLITICI
DEI PAESI DEL TERZO MONDO
Il colonialismo costituì in molti casi un mezzo di sfruttamento delle arretrate popolazioni indigene, tuttavia quando esso si affermò alla fine dell'Ottocento, i paesi afroasiatici non avevano una coscienza nazionale e pertanto per le popolazioni indigene era indifferente essere soggette ad una autorità locale, o al dominio di una potenza straniera. Solo negli anni compresi fra le due guerre, le classi colte dei paesi afroasiatici iniziarono a darsi organizzazioni politiche per il loro riscatto dal dominio europeo. Turchia, Iran, Cina, furono i primi paesi a intraprendere la via del nazionalismo, a contrastare la presenza degli europei e il loro eccessivo potere economico. Sia pure per un breve periodo di tempo, diversi sono stati i paesi del Terzo Mondo a subire le suggestioni del fascismo e del nazionalsocialismo; in America Latina, in Cina e nei paesi mediorientali vi sono state forze politiche che si richiamavano espressamente a tali programmi politici o che vedevano con interesse una vittoria dell'Asse. Tale fase storica si esaurì nel periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale, e altri movimenti politici fecero la loro comparsa nel periodo successivo.
Molti di questi movimenti politici anticolonialisti sorti negli anni successivi presero a ispirarsi - con sfumature diverse - a dottrine socialiste. Per alcuni il problema sociale era di importanza non minore rispetto a quello nazionale, per altri “La lotta nazionale «che affratella» il popolo, viene prima della lotta sociale la quale può produrre l'odio, l'egoismo e le divisioni interne” , come sostenuto da Nasser dopo la rivolta che rovesciò la monarchia in Egitto.
Diversi stati come l'India, il Costarica o lo Zambia, si sono dati una legislazione sociale senza sopprimere gli avversari politici e le libertà. Altri paesi invece, diedero vita, una volta ottenuta l'indipendenza, a regimi socialisti estremisti. Molti di tali regimi non hanno favorito in alcun modo la redistribuzione del reddito, né favorito l'azione dei sindacati per il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, l'opera principale di questi regimi è stato il controllo dell'economia da parte del potere centrale, l'impossessamento dei beni stranieri, e una politica di potenza nei confronti dei paesi vicini. Secondo lo studioso francese Lavroff “gli instauratori del partito unico [in Africa] avevano solo in teoria agitata un’ideologia nazionale mirante alla creazione di una società omogenea, senza classi e senza ingiustizie; in pratica la frattura e le distanze tra il livello di vita delle élites al potere e le condizioni di vita del resto della popolazione (formata non solo dai salariati e dai contadini ma anche dalle élite della nuova generazione) si andavano sempre più accentuando” . Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, i paesi socialisti afroasiatici sono paesi dove la collettivizzazione delle imprese e delle terre non andava a favore della società, né esisteva una legislazione a favore delle categorie più deboli, o interventi per rendere più vivibili gli squallidi insediamenti abitativi ai margini delle grandi città. In tali paesi la burocrazia, dato l'elevato livello di corruzione, costituiva il nuovo ceto privilegiato. Secondo Ernesto Galli della Loggia nei paesi del Terzo Mondo “L'accesso agli impieghi pubblici - accesso politicamente controllato - è così divenuto il momento principale di una vasta e rilevantissima promozione di status, spesso, peraltro, collegata alle regole dell'ordine tradizionale incarnate dall'affiliazione parentale e dal rango della nascita... Nonostante i precetti egualitari divulgati dal partito unico, lo stile di vita di questa nuova classe presenta un tale carattere elitario ed un così clamoroso gusto acquisitivo da renderla in tutto simile ad una vera e propria oligarchia” .
I regimi nazionalisti e socialisti si sono invece fortemente impegnati nel campo della politica estera dando vita ad un vasto insieme di micro-imperialismi, da quello cinese, a quello giavanese e vietnamita, che nei confronti delle minoranze interne e dei paesi vicini hanno espresso una politica aggressiva tesa a creare una egemonia nella regione.
I paesi socialisti moderati come la Tanzania di Nyerere, l'India di Nehru, il Senegal di Senghor, si collocavano ad un livello decisamente superiore rispetto ai precedenti regimi per quanto riguardava il rispetto dei diritti umani. Anche in questi paesi la certezza del diritto costituiva spesso qualcosa di precario, la democrazia era decisamente limitata, tuttavia il potere risultava più diffuso, e il cittadino se a volte non poteva prendere posizione contro il governo, godeva comunque di un livello di libertà senz'altro superiore a quella dei paesi comunisti, o retti da governi nazionalisti radicali. La presenza dello stato è ovunque notevole, tuttavia non pretende di gestire la vita personale dell'individuo, la società è meno militarizzata, e ciò influisce positivamente anche sul piano economico.
Altri paesi infine, come il Kenia, la Costa d'Avorio, la Malaysia, hanno scelto invece di darsi una economia di mercato e una politica di apertura nei confronti dei paesi industrializzati; tali paesi hanno compiuto passi limitati verso la strada della democrazia, tuttavia è innegabile un migliore livello economico e un più diffuso benessere.
E' di fondamentale importanza nel lavoro dello storico confrontare le dottrine politiche espresse nei documenti e negli atti ufficiali con i comportamenti reali tenuti dai governi. In molti casi nei paesi del Terzo Mondo si è assistito ad una divergenza notevole fra le due componenti, e così governi che avevano aderito formalmente alle dottrine democratiche e approvato la Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo o i principi della Conferenza di Bandung si sono abbandonati ad efferatezze contro il proprio popolo, i paesi vicini e le minoranze etniche che ricordavano in maniera evidente i peggiori regimi del nostro secolo.
La grande maggioranza dei governi nel mondo sviluppato e nel Terzo Mondo si limitava con metodi democratici ovvero con quelli autoritari, a dare un certo assetto alla società con l'introduzione di nuove leggi e regole; esisteva invece un ristretto numero di regimi che non si limitava a modificare le abitudini degli individui ma intendeva anche modificare la loro personalità rendendoli passivi strumenti del potere; questo è quanto accaduto in Cina con la Rivoluzione Culturale, in Indocina con i governi comunisti affermatisi dopo il 1975, e in altri paesi dove i comunisti raggiunsero il potere in quegli anni.
Negli anni passati diversi movimenti comunisti del Terzo Mondo hanno attirato le simpatie di giovani ed intellettuali occidentali, che ritenevano questi gruppi politici, e i regimi a cui diedero vita, un sensibile progresso rispetto al comunismo “burocratico” affermatosi in Unione Sovietica. Molti di questi movimenti hanno invece gestito il potere con metodi autoritari, e hanno dato luogo a numerosi episodi di violenza che non trovavano giustificazioni adeguate. Paesi come l'India o l'Egitto, che presentavano problemi economici e politici gravi, non hanno conosciuto né il lavoro coatto né i campi di concentramento che hanno caratterizzato invece i regimi di ispirazione marxista nel continente asiatico.
I movimenti comunisti in Asia, come a Cuba, hanno trovato come loro terreno ideale la società contadina più che quella urbana, e ciò ha avuto molte conseguenze, fra le quali quella di non disporre di quadri qualificati, di mostrare una forma di repulsione per il mondo della cultura, unita nel vecchio continente, ad una chiusura verso qualsiasi fenomeno straniero. Il comunismo in questi paesi non ha contribuito allo sviluppo della democrazia (da questo punto di vista si è avuta anzi una autentica regressione), né allo sviluppo economico e al miglioramento delle condizioni delle masse rurali, sacrificate in molti casi alle esigenze belliche e industriali. La sottomissione della cultura al potere politico non ha favorito lo sviluppo di una coscienza civile, ha impedito il progresso della nazione, e quel riscatto dei popoli che è stato l'obbiettivo almeno proclamato di molti movimenti di liberazione. In Asia in particolare, il comunismo ha governato attraverso il terrore, non limitandosi ad eliminare l'opposizione, ma imponendo anche l'indottrinamento, il lavoro forzato, il sistema della delazione, e modelli di comportamento che riguardavano la vita privata delle persone. Infine si è avuto nei regimi comunisti del Terzo Mondo il culto della personalità e la tendenza al fanatismo ideologico, che nella Corea e nel Vietnam, ha presentato aspetti patologici, oltre ad una tendenza al puritanesimo dei costumi, fenomeno scarsamente messo in rilievo nel passato.
Nel 1951 la crisi anglo-iraniana segnò l'inizio di un periodo di controversie fra paesi industrializzati e paesi poveri, su questioni che riguardavano soprattutto le compagnie straniere nel Terzo Mondo. Molti governi afroasiatici e latino americani agirono con arbitrarietà, e in numerosi casi non riconobbero nemmeno il diritto dei paesi ricchi all'indennizzo di quanto sottratto. Il conflitto, che aprì numerose gravi crisi come quella di Suez, e il contrasto fra USA e Cuba nei primi anni '60, apportò scarsi benefici ai paesi autori delle violazioni, che privi di quadri qualificati non seppero gestire le imprese nazionalizzate.
La realtà storica ci porta a considerare che paesi industrializzati e paesi produttori di materie prime sono in un certo senso “condannati” alla cooperazione, ed è difficile immaginare una restrizione degli scambi fra le due categorie di nazioni; certamente i paesi in via di sviluppo hanno diritto di associarsi e respingere accordi economici ritenuti iniqui, ma non anche di ricorrere all'uso della forza come è avvenuto in molti casi negli anni precedenti, azioni che del resto se hanno danneggiato i paesi ricchi, non hanno favorito i paesi autori di tali operazioni.
Secondo alcuni gli aiuti economici e gli scambi commerciali fra le potenze del mondo industrializzato e i paesi in via di sviluppo costituiscono una sorta di interferenza di questi nella vita politica dei secondi. Ragioni economiche obbiettive fanno ritenere che non esistano alternative a questa situazione, non disponendo i paesi produttori di materie prime di tecnologie e di strutture economiche adeguate per la commercializzazione dei loro prodotti, e si deve tener presente inoltre che il capitale straniero spesso non ha molto modo di influenzare le scelte di stati con caratteristiche totalitarie. I trattati commerciali, anche a carattere strettamente economico comportano sempre un impatto politico e una qualche forma di legame, ma ciò non consente di parlare di per sé di sottomissione di una parte all'altra né di neo-colonialismo come alcuni nel passato hanno fatto. In alcuni casi situazioni oggettive, quali la maggiore compattezza del mondo industrializzato rispetto a quello dei paesi in via di sviluppo (numericamente anche superiori ai primi) ha potuto consentire migliori condizioni per i paesi ricchi, ma non dobbiamo dimenticare l'opera dei cartelli produttori di materie prime, che in molti casi hanno costretto la controparte in situazioni difficili. Infine dobbiamo ricordare che mentre una parte rilevante dei rapporti economici fra le nazioni occidentali e i paesi in via di sviluppo avveniva e avviene attraverso istituzioni internazionali, quali la BIRS e il FMI, i paesi del blocco comunista preferivano i rapporti commerciali bilaterali dove maggiormente avevano modo di far sentire il peso della loro potenza economica.
Secondo i teorici del neocolonialismo, o come si preferisce oggi, del “terzomondismo”, molte crisi avvenute in diverse parti del mondo che hanno visto etnie minori in contrasto con il governo centrale, come nel caso del Congo e della Nigeria in Africa, o dell’Indonesia in Asia, sono state in qualche modo fomentate dalle potenze ex colonizzatrici, che intendevano indebolire le nuove nazioni emergenti. In realtà gli antagonismi erano in molti casi di origine remota e molte popolazioni “minori” ritenevano preferibile il legame con le nazioni europee alle vessazioni dei nuovi governi. Negli anni della guerra fredda gli Stati Uniti e i paesi del blocco occidentale sono stati attenti a selezionare gli aiuti, e ad evitare che favorissero governi estremisti e filosovietici. In molti casi comunque, governi socialisti riformisti hanno potuto godere di buone relazioni con il mondo sviluppato. Le Filippine di Magsaysay, il Venezuela di Betancourt, e la Bolivia di Estenssoro, hanno ottenuto ampio sostegno dagli Stati Uniti, i quali ritenevano la risoluzione dei problemi sociali potesse evitare la degenerazione politica di quei paesi e il loro ingresso nell’orbita sovietica.
Gli Stati Uniti in particolare, si sono impegnati notevolmente nel sostegno alle economie dei paesi in via di sviluppo. Alla fine degli anni Settanta gli aiuti economici a questi paesi ammontava a 90 miliardi di dollari, cifra notevolmente superiore ai 13 miliardi di dollari del Piano Marshall. Tuttavia secondo Nixon “La maggior parte di essi è andata sprecata. I risultati generali sono stati deludenti in modo particolar-mente drammatico in riferimento a quelli ottenuti in Europa e in Giappone con somme molto inferiori” .
Fra il 1963 e il 1968 si ebbero ben 64 colpi di stato in Africa, un dato allarmante che la dice lunga sui problemi di assesto politico di quella terra. Nel corso degli anni Settanta la metà degli stati africani era governata da giunte militari e buona parte dei rimanenti stati da regimi comunque totalitari. Oggi l'intero continente appare decisamente più stabile, ma si tratta di un maggiore equilibrio fra oligarchie di potere e non di un miglioramento sulla strada del progresso e di una maggiore democrazia. Analogamente anche l'Asia e l'America Latina godono di una situazione politica migliore che nel passato, tuttavia ciò non ha contribuito a portare questi paesi fuori dalla stagnazione economica, fattore che insieme alla esplosione demografica potrà produrre in un futuro non lontano una situazione di grave tensione.
politiche economiche dei paesi in via di sviluppo
In Birmania, Indonesia, Algeria e Ghana, l'avvento di regimi anticolonialisti è coinciso con un sensibile peggioramento della situazione economica dei rispettivi stati, mentre nella maggior parte delle altre nazioni afroasiatiche si è comunque avuta una situazione di grave stagnazione economica. Le popolazioni locali tuttavia hanno mostrato di preferire il deterioramento economico alla “sudditanza” verso il mondo progredito. Il successo riportato da alcuni leaders che hanno sensibilmente peggiorato le condizioni economiche del paese come, Sukarno o Khomeini, fa ritenere che le aspirazioni delle società del Terzo Mondo fossero profondamente diverse da quelle dei nostri paesi, e che il desiderio di grandezza della nazione avesse la precedenza su quello della diffusione del benessere. Secondo lo studioso francese Lacouture la storia del Terzo Mondo è legata alla presenza di leader carismatici, i cui gesti o la cui semplice presenza era in grado di suscitare adesioni emotive fra le masse. Questi personaggi, legati per lo più a singoli episodi, (è il caso di Nasser con la nazionalizzazione del Canale), non furono in grado di garantire una corretta gestione del potere, ma sapevano sviluppare fra la popolazione un senso di identificazione con il “capo” che appagava i bisogni dei più. Gli statisti moderati che hanno cercato di lavorare più per la pace che per le guerre, come Nehru, Bourghiba e Sadat, sotto molti punti di vista svolsero un ruolo decisamente più positivo dei numerosi leader che hanno dato vita a continue agitazioni, tuttavia in alcuni casi hanno ottenuto minori consensi.
Al di là delle affermazioni di principio molti regimi hanno anteposto finalità di potere o di grandezza al miglioramento dell'economia e delle condizioni delle masse popolari. Rispetto a decenni fa la maggior parte dei paesi del Terzo Mondo dispongono di capitali e hanno migliore accesso alle tecnologie moderne, ma questa situazione non ha favorito il decollo economico di questi paesi. Il problema del Terzo Mondo oggi, non è quello del sottosviluppo, ma quello di uno sviluppo gestito in maniera arbitraria e con finalità non sempre chiare. In molti paesi del Terzo Mondo si è fatto molto poco o nulla per arrivare ad una maggiore redistribuzione del reddito, fattore che avrebbe influito positivamente su tutto il sistema economico di quei paesi, né per destinare le risorse dello stato a favore della parte più povera della società. Mentre nel ventennio 1950-1970 il mondo occidentale conosceva uno sviluppo che non aveva eguali nei periodi precedenti della storia, l'India di Nehru e la Cina di Mao non erano in grado di uscire dal sottosviluppo e le popolazioni dei due paesi al termine di quel periodo si trovavano in condizioni economiche non diverse da quelle iniziali. Isolamento economico, corruzione e dissipazione dei fondi pubblici per progetti di dubbia utilità, avevano impedito il miglioramento economico dei due colossi asiatici. Le analogie fra le due nazioni, che costituiscono due modelli diversi e contrapposti per il mondo asiatico, comunque finiscono qui; all'India veniva risparmiata la pratica dei campi di rieducazione e del lavoro forzato e, sia pure con quei limiti che sono soliti ai paesi del Terzo Mondo, veniva avviata alla democrazia e ad una convivenza fra gruppi etnici e religiosi radicalmente diversa da quella cinese, dove le minoranze erano oggetto di numerose vessazioni.
In queste pagine abbiamo visto come molti regimi terzomondisti presentino caratteristiche comuni: scarsa propensione alla democrazia e al rispetto del diritto, ambizioni politiche smodate che si traducevano in elevate spese militari, disinteresse per le gravissime condizioni in cui vive la maggioranza della popolazione, politiche economiche orientate verso un maggiore controllo politico delle strutture produttive che verso lo sviluppo e la redistribuzione del reddito. Queste considerazioni ci consentono di affermare che il problema del sottosviluppo che interessa la maggioranza della popolazione del pianeta costituisce un problema più politico che strettamente economico.
Nei paesi ricchi di risorse naturali come i paesi dell'OPEC, l'Angola o lo Zaire, la ricchezza non circola, si concentra nelle mani di ristrette categorie privilegiate, non favorisce gli investimenti produttivi, né eleva il tenore di vita e i consumi della popolazione, impedendo in tale maniera un incremento della domanda sul mercato necessaria come stimolo al decollo economico. Paesi poveri di risorse e paesi ricchi di preziose materie prime presentano più o meno gli stessi indici di sottosviluppo, di analfabetismo, eccetera. A chiunque abbia visitato i paesi asiatici e africani non può sfuggire la forte sperequazione dei redditi e la sostanziale assenza di un ceto medio; accanto a enormi masse di diseredati che vivono nella totale indigenza, vi sono un certo numero di facoltosi il cui livello di benessere è in molti casi superiore a quello dei nostri paesi. Da molti decenni è noto in Occidente che un eccesso della offerta sulla domanda non produce un progresso economico, e se i salari sono eccessivamente bassi i consumi non possono “tirare” l'economia. Nonostante le affermazioni di socialismo di molti paesi del Terzo Mondo tale problema non è mai stato realmente affrontato. Legato al problema della redistribuzione del reddito è sicuramente quello delle libertà sindacali, che anche quando sono garantite non riescono a incidere nella vita del paese. In India, uno dei paesi più liberali del continente asiatico, le associazioni sindacali non disponevano di fondi di sciopero, e secondo Mishra “Non è difficile immaginare con quanta facilità i datori di lavoro riescano a richiamare nei ranghi i dissenzienti affamati. L'unica forza delle Unioni è quella, invero non commestibile, della crociata morale. Alcune di quelle meglio conosciute, ed organizzate in genere dai comunisti, vengono crudamente usate per un più largo gioco politico e non sempre si trovano dalla parte del povero lavoratore, che come sempre paga per tutti”. Le statistiche non sono spesso molto attendibili nel Terzo Mondo, ma anche considerando una certa approssimazione, risultano comunque significative. Quasi inesistente è nei paesi in via di sviluppo la legislazione sociale, e la spesa per la previdenza rappresenta una cifra del tutto insignificante. Negli anni Ottanta il Pakistan deteneva una spesa sociale intorno allo 0,5% del PIL, e persino nell’India socialista essa non superava l’1,5%. Nei paesi dell’America Latina la percentuale appariva più alta e si collocava intorno al 3-5%, cifra comunque notevolmente al di sotto di quella dei paesi europei che in quegli anni raggiungeva il 25-30% del reddito nazionale.
Anche l'ex presidente costaricano Oscar Arias, premio Nobel per la pace, riteneva che la crescita del PIL non equivalesse alla diffusione del benessere; in un suo scritto sosteneva infatti che: “La crescita economica è la condizione necessaria ma non sufficiente per lo sviluppo della società: per essere di aiuto ai poveri lo sviluppo deve arrivare a loro. Spesso invece il povero si trova nelle condizioni che gli impediscono di contribuire alla crescita economica nazionale o di partecipare ai suoi benefici”.
Chi ha avuto occasione di viaggiare nei paesi afroasiatici non avrà potuto non notare i segni della miseria che colpisce la popolazione. Le città del Terzo Mondo si compongono di alcuni ristretti quartieri prestigiosi, di centri commerciali non troppo diversi da quelli dei nostri paesi, ma spesso non lontano da questi si ammassano gruppi di abitazioni misere, strade in cattive condizioni, fogne a cielo aperto che attraversano zone densamente abitate. In molti quartieri di più antica costruzione la situazione igienica raggiunge livelli patologici, e l’aria per i numerosi rifiuti organici sembra irrespirabile. Non manca invece la presenza di polizia e militari, ed anzi facilmente ci si rende conto che gli appartenenti alle forze armate rappresentano una percentuale molto elevata della popolazione. Nelle città indiane molta gente dorme per le strade o in ricoveri di fortuna, e non è certamente difficile vedere in queste persone i segni della denutrizione e della malattia. Al tempo stesso dappertutto si vedono i segni di una ricchezza male distribuita, di differenze sociali notevoli, di uno stato di apatia e rassegnazione sconosciuto fra i paesi progrediti. Certamente fra le cause del mancato decollo dei paesi del Terzo Mondo rientrano anche fattori culturali; la mentalità di molte popolazioni afroasiatiche infatti, sebbene diverse fra loro è portata ad un atteggiamento di fatalismo verso la vita e a ritenere che chi nasce nelle ristrettezze deve accettare vessazioni di tutti i tipi. Un grande conoscitore dell’Africa, il giornalista italiano Corrado Gianturco, scriveva nella conclusione del suo Rivoluzione Congolese che per l’africano “Bianco o Negro, il padrone è sempre uguale: bontà sua se lo lascia vivere. Ma un padrone che si rispetti deve comportarsi e agire come tale; punire, imprigionare, uccidere se necessario. Il padrone che trema e che tentenna non merita obbedienza: è un impostore, un falso idolo da abbattere, frantumare, calpestare nella polvere”.
Oltre alle guerre, alla iniqua redistribuzione del reddito, alla cultura delle popolazioni afroasiatiche, lontana da quella mentalità imprenditoriale che nei nostri paesi ha consentito il decollo economico industriale, un'altra causa del mancato sviluppo dei paesi del Terzo Mondo è da ricercarsi nelle scelte economiche messe in atto da diversi governi. Alcuni paesi hanno ritenuto di investire i capitali propri e quelli ottenuti dalle organizzazioni internazionali non in opere di miglioramento fondiario, ma in ambiziosi programmi di industrializzazione alcuni dei quali esplicitamente finalizzati al potenziamento dell'apparato bellico. La produzione dell'acciaio a livello locale in Cina, i progetti faraonici del Ghana, gli investimenti nel campo della siderurgia a detrimento dell'agricoltura in India, non potevano condurre che al peggioramento delle condizioni di vita dei popoli asiatici. Uno dei principi basilari dell'economia sostiene che una impresa commerciale o un gruppo umano deve concentrare le sue attività nel settore nel quale dispone di migliori risorse materiali e umane, e scambiare le eccedenze con altri prodotti di cui necessitano. Molti governi del Terzo Mondo hanno invece intrapreso una politica di chiusura commerciale e inseguito progetti ambiziosi anche in campo industriale, settore nel quale non avevano alcuna possibilità di affermarsi, e deliberatamente hanno anteposto finalità di grandezza al corretto sviluppo economico del paese.
Anche un grande studioso di problemi del Terzo Mondo come l'indiano Ashis Nandy riteneva che: “Le politiche dette di sviluppo, di modernizzazione, così come sono avviate dalle classi dirigenti del Terzo Mondo, si limitano a distruggere la nostra cultura senza sostituirla con la prosperità” e che molti governi dei paesi in via di sviluppo avessero confuso la potenza nazionale con lo sviluppo, applicando pedissequamente dottrine economiche che hanno avuto il risultato di “proletarizzare i contadini” e distruggere le attività artigianali tradizionali. In altri termini la politica di sviluppo deve essere attuata con realismo, attraverso interventi in quei settori dove i singoli paesi hanno maggiore possibilità a seconda delle caratteristiche geografiche e umane.
Secondo alcuni autori, cattolici e marxisti soprattutto, la causa del malessere di questi paesi è da ricercarsi nell'organizzazione mondiale del capitalismo, si dimentica però che anche in quei paesi che si sono isolati dal “circuito” mondiale le condizioni economiche non sono diverse da quelle dei paesi che accettano le regole economiche internazionali. Molti governi hanno ritenuto di favorire lo sviluppo del paese attraverso l'introduzione di una politica autarchica e restrizioni all'accesso dei capitali stranieri, politica che ha invece prodotto un pessimo sfruttamento delle risorse nazionali. Se da una parte le grandi società commerciali europee e americane hanno potuto contare sulla loro potenza per ottenere condizioni più vantaggiose, dall'altra anche i cartelli dei paesi produttori di materie prime, come l'OPEC, hanno messo in difficoltà i paesi industrializzati. Uno sguardo alla storia delle multinazionali, compresa quella delle sette sorelle, forse la più grande concentrazione economica esistente nel passato, che controllava nel 1950 il 75% della produzione petrolifera, metterà in luce che gli spazi e i poteri delle grandi comnpagnie si sono ridotti nel corso del tempo.
Abbiamo visto nelle pagine precedenti che la politica dei governi socialisti nel Terzo Mondo si è incentrata su due provvedimenti principali: riforma agraria e nazionalizzazioni. La riforma agraria dovrebbe avere come fine due obbiettivi principali: migliorare l'utilizzazione delle terre, e quindi accrescere la produzione agro-alimentare, e favorire una migliore distribuzione delle ricchezze fra le popolazioni. Nei paesi del Terzo Mondo non si è avuta la formazione di una vasta categoria di piccoli proprietari ma la gestione delle terre da parte dello stato, attraverso il sistema delle cooperative, spesso accompagnato da un generale malcontento popolare e quasi mai da un incremento della produzione agricola. Nel Vietnam la distribuzione delle terre ha costituito un provvedimento utile per colpire l’opposizione; nei paesi arabi ha favorito soprattutto la classe dei burocrati, mentre in altri paesi, come in Indonesia, Pakistan e Perù ha provocato proteste popolari. Le nazionalizzazioni nel campo industriale, sia di proprietà straniere, che di proprietà di famiglie locali, hanno seguito più o meno gli stessi criteri dando vita ad una forma di capitalismo di stato; le gravi carenze di quadri tecnici e la diffusa corruzione infine, hanno completato il quadro economico.
Il problema demografico è destinato ad avere sempre più rilievo nella realtà dei paesi in via di sviluppo, e presenta un duplice aspetto: nelle regioni aride l'aumento della popolazione ha costretto gli allevatori, nomadi o sedentari, ad estendere le terre destinate a pascolo provocando un più veloce impoverimento di aree dal punto di vista ecologico fragili. In altre regioni come a Giava, il sovraffollamento delle campagne è stato la causa di una vasta serie di fenomeni sociali e naturali che hanno prodotto un peggioramento delle condizioni di vita delle popolazioni. Connesso al problema demografico è quello dei massicci spostamenti di popolazioni dalle zone agricole a quelle urbane, o per meglio dire verso le grandi concentrazioni urbane. Il Terzo Mondo sembra sempre più destinato al primato in fatto di megalopoli, che in paesi industrializzati potrebbe essere forse considerato sintomo di prosperità, ma che in quei paesi rappresentano invece una grande fonte di malessere. In questi paesi a vocazione agricola le grandi città non presentano grandi attività industriali, commerciali, finanziarie che possano garantire una vasta occupazione, e ciò ha prodotto il triste fenomeno delle favelas e delle bidonvilles, che rappresentano forse uno dei peggiori esempi di degradazione umana. In Perù la capitale Lima con i suoi sei milioni di abitanti (metà dei quali si stima dediti ad attività illecite, contrabbando, furti, prostituzione, recupero della spazzatura) ospita quasi un terzo della intera popolazione del paese, e la stessa situazione si ha in Argentina con Buenos Aires, o in Egitto con il Cairo. Il problema demografico, destinato a divenire il problema numero uno dei paesi poveri, è sicuramente di difficile soluzione, secondo Oscar Arias i mezzi per risolvere la terribile questione “Non sono necessariamente a livello di nazione, ma di ambito regionale o mondiale. Così per esempio, se un paese intende diminuire il suo tasso di crescita demografico, e nella regione a cui appartiene non avviene la medesima politica, presto quel paese comincerà a subire nel suo territorio la pressione della eccessiva popolazione dell'area circonvicina”, come è avvenuto in anni recenti in diverse parti del mondo.
Per lungo tempo i paesi del Terzo Mondo sono vissuti di una economia di sostentamento in cui le popolazioni vivevano di quei prodotti che essi stessi producevano, in tempi più recenti grazie anche ai capitali delle organizzazioni internazionali per lo sviluppo, l'economia di mercato è decisamente più diffusa, tuttavia le innovazioni hanno talvolta creato dei danni. In molti paesi la monocoltura non si è inserita nel contesto sociale e ambientale di quei paesi. In Africa negli anni Sessanta sono state introdotte delle razze di bovini di qualità superiori a quelle autoctone, tuttavia meno resistenti alle malattie tropicali; mentre molti paesi sono venuti a dipendere dalla produzione di un solo prodotto nel campo commerciale. Negli anni Ottanta le esportazioni del Ghana risultavano costituite per il 74% dal cacao, quelle del Senegal per il 57% dalle arachidi, e quelle della Nigeria per l'85% dal petrolio; conseguenza di tale situazione è la forte instabilità economica di questi paesi, esposti alla fluttuazioni del mercato e degli eventi climatici. Un'altra conseguenza notevole di questo scorretto sviluppo, è data dai danni alle risorse ambientali che talvolta sono risultati superiori ai benefici ricavati. La eccessiva pressione demografica e l’allevamento estensivo hanno provocato il fenomeno della desertificazione. Tipico esempio di tale situazione è stata la carestia nel Sahel, la regione a sud del Sahara, prodotta sia da cause naturali che dall’eccessivo aumento della popolazione, evento che ha provocato alla fine degli anni Settanta la morte di oltre centomila persone. In altri casi si è avuto l’eccessivo sfruttamento delle grandi foreste. I terreni tropicali denudati dalla copertura arborea per la produzione di legname o per fare posto a nuove colture, sono soggetti all'erosione delle piogge torrenziali e alla laterizzazione un fenomeno chimico che rende i terreni privi di vita e inservibili. Le terribili alluvioni di cui è stato soggetto il Bangla Desh in anni recenti, risultavano causati dall'impoverimento delle foreste del versante meridionale himalayano.
In conclusione l'esperienza di questi ultimi decenni ha dimostrato che nel Terzo Mondo (come del resto ovunque) dittatura e violenza non possono contribuire allo sviluppo economico e civile dei paesi arretrati, e che le istanze economiche non possono precedere quelle politiche. Se è vero che la miseria non può favorire lo sviluppo delle istituzioni democratiche, e anche vero che un regime autoritario costituisce un freno al miglioramento delle condizioni economiche di quei paesi poveri che costituiscono la maggioranza del pianeta, e che in questi ultimi decenni hanno dimostrato sfortunatamente scarsi progressi.
Mussolini, il leader del socialismo rivoluzionario di Luciano Atticciati (anno 2001)
Un carattere impetuoso ed un certo disprezzo per l’idea di democrazia caratterizzava già la prima parte della vita politica del futuro statista
Storia del Partito Comunista Italiano di Luciano Atticciati (marzo 2013)
Il grande Partito della Sinistra italiana non brillò per autonomia e originalità, si caratterizzò invece per il suo rigido dogmatismo e per il forte senso di disciplina
Il Biennio Rosso di Luciano Atticciati (maggio 2010)
La violenza fu uno degli elementi determinanti delle scelte politiche del nostro paese nel periodo successivo alla Grande Guerra, ad essa presero parte non solo fascisti e socialisti, ma gruppi diversi, ostili per ragioni diverse all’idea di democrazia
Il Biennio Rosso in Italia e il mito sovietico di Luciano Atticciati (luglio 2010)
Dopo la Rivoluzione d'Ottobre, i movimenti politici della Sinistra italiana progettarono la fondazione di uno Stato sul modello sovietico
Il Biennio Rosso e la nascita del fascismo di Luciano Atticciati (agosto 2006)
Secondo Gaetano Salvemini le violenze scatenate dai socialisti massimalisti nel 1919-20 furono la causa del sorgere del fascismo
La violenza politica in Italia attraverso gli scritti di Benito Mussolini di Luciano Atticciati (anno 2002)
Il difficile periodo del primo dopoguerra, fra scontro sociale ed estremismo politico
La guerra del fascismo contro la mafia di Simone Valtorta (maggio 2014)
Nel 1925, Benito Mussolini decise di estirpare in modo totale e definitivo la mafia dalla Sicilia. E ne affidò il compito ad un uomo non gradito al Regime, ma di sicure capacità: Cesare Mori, il «Prefetto di Ferro»