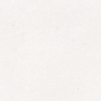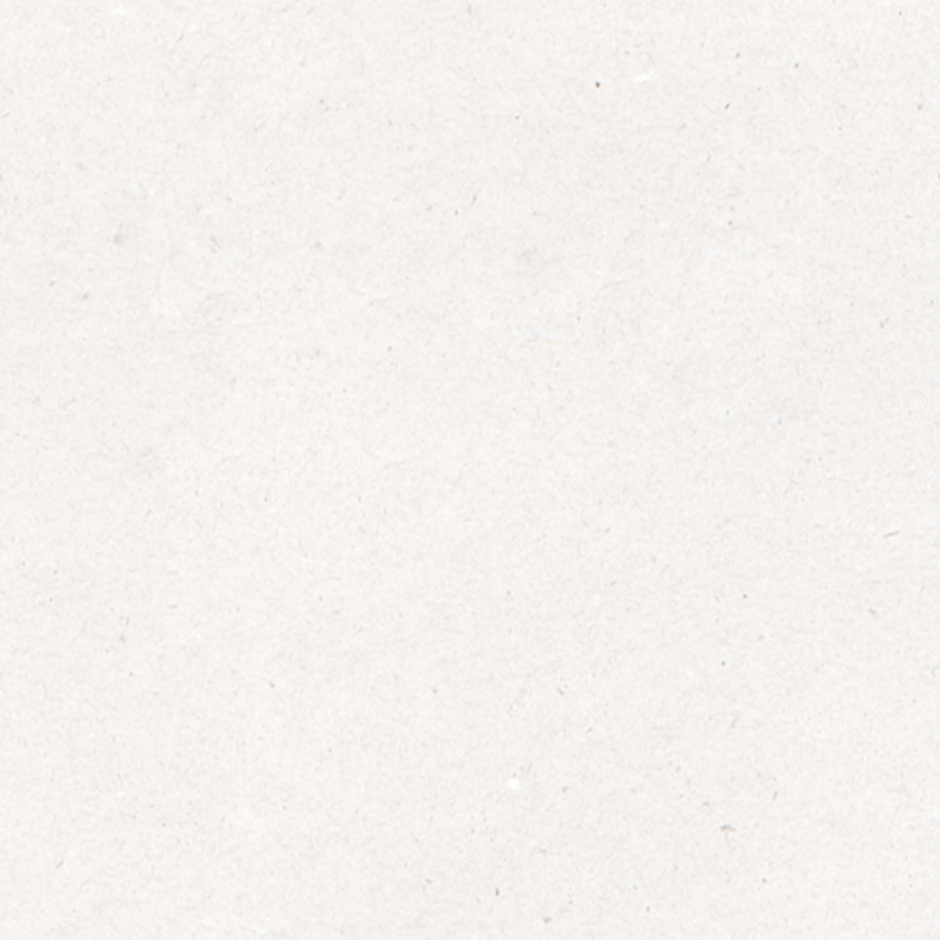parte 3°
la decolonizzazione dell'Africa
sub-sahariana
Negli anni Sessanta si ebbe l'esplosione del problema del Terzo Mondo, molti ritenevano che la causa del mancato decollo economico dei paesi in via di sviluppo fosse da ricercare nella politica dei paesi progrediti e nell'organizzazione del commercio internazionale. Nacque così nel 1964 l'UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo) con il compito di provvedere alla stabilizzazione dei prezzi delle materie prime e di accordare delle facilitazioni doganali ai prodotti dei paesi del Terzo Mondo, anche in deroga ai principi di libero mercato e di parità fra le nazioni. L'iniziativa costituiva una novità rispetto alle precedenti forme di aiuto del mondo avanzato ai paesi poveri, che negli anni precedenti era avvenuto attraverso l'apertura di crediti e l'invio di tecnologie, e tendeva a privilegiare il peso delle giovani nazioni afroasiatiche all'interno della comunità internazionale. Nello stesso anno venne firmata la Convenzione di Yaoundé fra la Comunità Europea e i paesi africani che prevedeva analogamente una serie di facilitazioni ai prodotti dei paesi tropicali.
Le iniziative da parte dei paesi emergenti risultavano abbastanza numerose. Nel 1961 si ebbe per iniziativa della Jugoslavia (e in minor misura di Egitto e India) la prima conferenza dei paesi non allineati. Sebbene il gruppo di paesi rappresentasse una forza determinante all’interno dell’Assemblea Generale dell’ONU, non ebbe un grande rilievo politico. Negli anni successivi tuttavia le interessanti iniziative nel campo della cooperazione fra paesi industrializzati e paesi poveri vennero seriamente alterate da alcune prese di posizioni che crearono un clima di ostilità fra il mondo avanzato e quello più povero. Successivamente al rialzo del prezzo del petrolio deciso dai paesi dell'OPEC, diversi governi latino americani e afroasiatici iniziarono a reclamare il diritto alla nazionalizzazione di beni e aziende straniere senza negoziazione con le controparti, e la facoltà di stabilire arbitrariamente l'indennizzo da riconoscere. Tali principi vennero portati avanti con particolare vigore dal presidente algerino Boumedienne, che in un intervento all'Assemblea Generale dell'ONU dell'aprile 1974 sostenne che “La presa di possesso da parte dei paesi in via di sviluppo delle proprie risorse naturali comporta innanzitutto la nazionalizzazione dello sfruttamento di tali risorse e il controllo dei meccanismi che regolano la fissazione dei loro prezzi” . Quanto sostenuto dal leader arabo venne ripreso nella successiva Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati, approvata nello stesso anno con il voto contrario dei paesi occidentali; in essa si stabiliva che qualora l'indennizzo dei beni stranieri creasse delle controversie, queste sarebbero state risolte unilateralmente dagli organi giudiziari del paese che aveva proceduto all'esproprio, e che i paesi occidentali avrebbero dovuto accordare “un sistema di preferenze tariffarie generalizzate non reciproche e non discriminatorie” verso i paesi produttori di materie prime, infine si stabiliva un rapporto di preferenza fra paesi socialisti e paesi in via di sviluppo nel campo della cooperazione economica e politica.
L'Africa sub-sahariana fu l'ultima regione ad essere interessata dall'attività di movimenti indipendentistici e ad ottenere l'affrancamento dal dominio coloniale. Come nelle altre regioni il processo di decolonizzazione ebbe caratteristiche diverse a seconda della potenza colonizzatrice, e tale fattore si fece sentire anche nel diverso sviluppo fra nazioni anglofone e francofone.
La massima parte dei paesi ottenne l'indipendenza fra il 1958 e il 1961; con alcune eccezioni tale processo, sebbene a volte affrettato, non diede luogo a violenze come in altre regioni. Non appena raggiunta l'indipendenza i nuovi stati organizzarono degli incontri internazionali per il conseguimento di una maggiore integrazione del continente, che diversamente dalle aspettative ebbero scarso successo e diedero vita a due gruppi di paesi antagonistici. Da una parte il gruppo di Casablanca comprendente a fianco del conservatore Marocco, i paesi rivoluzionari: Egitto, Ghana, Guinea, Mali e il governo provvisorio algerino, sostenitori della linea “dura” verso le potenze europee, e dall'altra il gruppo di Monrovia più moderato, comprendente un numero ben maggiore di stati. Nel '63 i due gruppi di stati raggiunsero su iniziativa dell'imperatore Haile Selassiè un compromesso, e diedero vita all'Organizzazione per l'Unità Africana che tuttavia negli anni successivi risultò paralizzata dagli interessi contrastanti dei diversi governi. Più fortuna ebbe invece l'organizzazione degli stati africani francofoni (che negli anni successivi ebbe diverse denominazioni), tuttavia anche in questa non mancarono contrasti di vario genere.
Il massimo sostenitore del panafricanismo fu il leader ghanese Nkrumah. Come il panarabismo di Nasser non prevedeva una integrazione fra gli stati su basi paritarie. I nuovi stati africani compirono ben pochi passi nel campo della cooperazione, e furono caratterizzati per lungo tempo da lotte e dispute territoriali, aggravate dalla incongruità dei confini politici degli stati. Gli stati africani risentirono gravemente dei contrasti etnici, e del contrasto fra la parte più evoluta della società e quella tribale, che ha spesso subito vessazioni da parte del potere politico centrale. La crisi considerata più grave si ebbe nell'ex Congo belga, ma altrettanto gravi furono quelle della Nigeria, della Guinea, e nel Corno d'Africa.
L'Africa centro meridionale fu caratterizzata dalla completa assenza di regimi democratici, e gli stessi leaders africani più illustri negarono la possibilità di una democrazia in quella regione; tuttavia possiamo distinguere fra regimi totalitari dispotici, come il Ghana di Nkrumah e la Guinea di Sekou Tourè, e regimi dove era ammesso un certo grado di tolleranza come il Senegal di Senghor, lo Zambia di Kaunda e la Tanzania di Nyerere. Alcuni stati come l'Uganda, la Repubblica Centraficana, il Sudan e il Burundi, infine si rivelarono del tutto incapaci di darsi delle istituzioni valide, e si affermò come endemica la guerra fra tribù e gruppi etnici diversi.
Un altro elemento che ha contribuito a creare tensioni politiche nelle nazioni afroasiatiche affrancatesi dal colonialismo è dato dal fatto che queste costituiscono una sorta di nazioni artificiali comprendenti popoli diversi che non avevano legami fra loro. Molte di queste nazioni comprendono popolazioni che parlano lingue diverse e professano religioni contrastanti che hanno dato luogo a gravi conflitti. Alcuni dei movimenti secessionisti sorti negli anni Cinquanta e Sessanta sono stati ritenuti tuttavia come emanazione di potenze straniere che avevano interesse ad indebolire alcuni governi terzomondisti particolarmente intransigenti.
Secondo la descrizione dell'Africa del giornalista e storico inglese Paul Johnson, a parte il Costa d'Avorio, il Kenya e la Nigeria (in seguito alla scoperta del petrolio), le condizioni di vita del continente peggiorarono notevolmente nei decenni successivi alla decolonizzazione. Nei settori delle comunicazioni e in quello sanitario si registrarono dei regressi che sommati ai gravi problemi ambientali: desertificazione, deforestazione, eccessivo incremento demografico, hanno causato uno stato di stagnazione economica esteso a tutto il continente.
Molti paesi africani negli anni Sessanta seguirono la strada del controllo statale dell’economia, attraverso la nazionalizzazione delle imprese, straniere e locali, e la collettivizzazione agricola. Tale strada portò alla corruzione e al dissesto economico. Per fare fronte a tale situazione, e a quella del debito pubblico, negli anni Ottanta molti paesi furono costretti a rivedere la loro politica economica. Con il sostegno del Fondo Monetario Internazionale si ebbe un ritorno alle privatizzazioni economiche, all’abbandono di alcuni progetti dispendiosi, ma anche a misure economiche restrittive che peggiorarono le condizioni di vita delle popolazioni. In Sierra Leone e in Niger si ebbero in quel periodo manifestazioni di protesta a causa di tale politica, che in mancanza di una reale democrazia non ha migliorato la situazione.
I LEADERS DELL'AFRICA OCCIDENTALE
L'Africa occidentale che si affaccia sul Golfo di Guinea, regione relativamente più popolosa rispetto al resto del continente nero, fu quella dove si ebbero i più attivi movimenti anticolonialisti, ed una serie di crisi che destarono l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale.
Il Ghana, uno dei paesi relativamente più evoluti economicamente e politicamente, fu il primo paese dell'Africa subsahariana a raggiungere l'indipendenza, attraverso un processo di riforme graduali.
Ottenuta la piena sovranità nel 1957, il paese conobbe una involuzione a carattere autoritario, attraverso la repressione dell'opposizione, l'emanazione di leggi che prevedevano la detenzione fino a cinque anni senza processo, e l'allontanamento dei giudici non graditi dal governo centrale. Anche le autonomie locali e i poteri tradizionalmente riconosciuti alle tribù vennero aboliti e concentrati nelle mani di funzionari di nomina governativa, con grave danno per le popolazioni che vivevano nelle regioni interne del paese. Nello stesso anno dell'indipendenza venne introdotto un sistema elettorale che prevedeva l'attribuzione di tutti i seggi parlamentari al partito che avesse ottenuto la maggioranza. Tale sistema introdotto successivamente anche in altri stati, consentì l'affermazione di un regime totalitario. L'artefice del nuovo stato africano, Kwame Nkurumah, eliminò in breve tempo gli avversari ed ex alleati politici, concentrò tutti i poteri dello stato nella sua persona, e divenne oggetto di un culto della personalità che fondeva elementi religiosi e principi marxisti. Negli anni successivi il leader africano, che si fece insignire del titolo di Osagiefo (= redentore), fece erigere numerosi monumenti alla sua persona, e si diede ad un lusso sfrenato, dissipando fra l'altro una parte delle non floride finanze dello stato.
Mentre Nehru o Nasser venivano esaltati come grandi personaggi, il leader africano al pari di Kim il Sung in Corea, si propose come qualcosa al di sopra degli altri esseri umani, toccando livelli patologici che influirono negativamente sulla vita del paese. Parlando dei leader dei nuovi paesi africani, di cui Nkrumah rappresentava uno degli esempi più significativi, il presidente zambiano Kaunda ha sostenuto una sua personale tesi: “So bene che molti dirigenti dei nuovi stati africani sono stati aspramente criticati per aver dato alla propria immagine dopo l'indipendenza proporzioni sovrumane. Da qui derivano le accuse di fascismo o di messianismo. Sono critiche però che non tengono abbastanza conto della funzione del capo per salvaguardare l'unità nazionale. Spesso il capo è il solo punto fermo di una società in rapida e tumultuosa trasformazione. Non si può negare comunque che l'esaltazione del capo comporti dei rischi. E' necessaria una forte fibra morale per non lasciarsi corrompere da un eccesso di potere e la sua politica deve essere tanto razionale da convincere anche l'ultimo cittadino che non agisce per fini esclusivi del potere ma al servizio della nazione” . Lo stesso Kaunda ha infatti dimostrato con la sua azione di governo che è possibile dirigere nazioni anche eterogenee dal punto di vista etnico-culturale senza degenerare nell'autoritarismo.
Sul piano economico l'esperimento di Nkrumah si risolse in un fallimento e provocò la formazione di una vasta opposizione popolare nel paese. Vennero realizzati dei grandi complessi industriali inservibili, nazionalizzate numerose industrie e le piantagioni di cacao, di cui il paese era stato il maggiore produttore mondiale, ed imposte una serie di restrizioni al commercio che risultarono fatali all'economia. Il governo amante delle grandi realizzazioni, progettò la costruzione di una imponente diga sul fiume Volta; il progetto, risultato dispendioso, venne portato a termine negli anni successivi, ma la difficile situazione economica ne ha impedito la piena utilizzazione, e non ha potuto impedire il consistente calo della produzione agricola e alimentare del paese.
Il leader africano prima di essere rovesciato nel 1966 da un colpo di stato militare legò il suo nome ad alcune importanti iniziative nel campo della politica estera con la creazione di una confederazione con la Guinea (anch'essa retta da un regime marxista), la sottoscrizione di un accordo con la Cina Popolare, e soprattutto con il progetto per l'unità africana, che sebbene sia stato oggetto di alcune conferenze internazionali non ha trovato alcuna attuazione. Il momento di maggiore popolarità internazionale venne raggiunto nell'aprile del 1958 con l'organizzazione della conferenza di Accra dove venne posto l'obbiettivo di superare la contrapposizione del mondo in due blocchi, combattere il colonialismo e il razzismo, fornire appoggio ai movimenti indipendentistici antifrancesi dell'Algeria e dell'Africa occidentale, ma come molte altre iniziative non superò la fase dei semplici propositi.
La Guinea, anch'essa relativamente ricca di risorse naturali, conobbe uno sviluppo non diverso da quello del vicino Ghana. Il paese raggiunse l'indipendenza nel 1958 sotto la guida del leader politico Sekou Tourè, il quale cercò di instaurare nel paese un regime marxista particolarmente rigido, diverso dai governi ispirati al “socialismo africano” diffusi nel resto del continente. L'estremismo di questo governo portò il paese alla rottura delle relazioni diplomatiche con la Francia (accusata di complotto contro il presidente), ad uno stato di tensione con gli altri paesi dell'area francofona e con lo stesso regime progressista senegalese di Senghor. Il paese nonostante il suo isolamento ottenne degli aiuti dagli Stati Uniti e soprattutto dalla Cina che non alleviarono comunque la difficile situazione economica del paese.
Nel corso degli anni Sessanta le popolazioni non appartenenti al gruppo di potere dominante furono oggetto di dure repressioni (si contarono un numero incredibile di prigionieri politici, di internati nei campi di concentramento e circa due milioni di profughi in un paese che contava cinque milioni di abitanti), vennero eliminati numerosi ex compagni politici di Tourè, e istituita una milizia popolare per far fronte ai numerosi complotti politici (o ritenuti tali) contro la sicurezza del paese.
L'economia della Guinea nonostante le sue notevoli risorse ha conosciuto una involuzione non inferiore a quella del vicino Ghana. L'aspra contesa con la Francia determinò la fuga della maggior parte dei cittadini francesi lasciando il paese sguarnito di quadri e di tecnici. Vennero nazionalizzate le banche e le attività commerciali, e riorganizzata l'agricoltura con la collettivizzazione delle terre. Come nella Cina comunista a cui il regime si ispirava, vennero creati comitati di villaggio e fatto largo ricorso alla mobilitazione delle masse, istituzioni attraverso le quali il governo centrale del paese attuava il suo sistema di controllo sulla collettività. Solo il settore minerario sfuggì al controllo dello stato e i diritti delle società straniere in questo settore vennero sostanzialmente rispettate, per impedire il disastro economico del paese.
Nel 1970 la Guinea subì una grave violazione da parte di mercenari guidati da ufficiali bianchi che cercarono di eliminare le basi dei movimenti guerriglieri della Guinea Portoghese, azione che avrebbe potuto avere più gravi conseguenze e implicazioni internazionali. In seguito forse a questo episodio, il regime di Conacry pur mantenendo intatte le sue strutture dittatoriali, ricercò un compromesso con i paesi vicini e riprese le relazioni con il governo francese. Il governo comunista non poté comunque sopravvivere alla morte del suo leader nel 1984, e di lì a poco venne sostituito da un regime militare che comunque si rese anch'esso responsabile di gravi atti contro le minoranze etniche e non garantì la pacificazione del paese.
Anche il Mali, che per un breve periodo di tempo costituì una sorta di federazione con la Guinea, ha conosciuto un sistema di pianificazione economica e collettivizzazione delle terre che ha prodotto come maggiore risultato un calo nella produzione del miglio, alimento base della popolazione, l'ostilità dei nomadi Tuareg e dei capi tradizionali mussulmani. Tale politica economica produsse inoltre una notevole inflazione, che ha provocato un netto peggioramento della situazione economica del paese.
Il Costa d'Avorio ha avuto uno sviluppo profondamente diverso da quello delle altre due nazioni precedenti. Sebbene il paese non abbia conosciuto una evoluzione in senso democratico, e non siano mancate nel corso degli anni le proteste popolari, il piccolo stato africano ha goduto di una situazione migliore degli altri paesi della regione, ed rimasto relativamente immune da violenze e instabilità politica.
Houphouet-Boigny, capo dello stato da quando il paese raggiunse l'indipendenza nel 1960, ha saputo curare buoni rapporti con i paesi occidentali e con gli altri stati dell'Africa francofona portando il paese ad un relativo benessere. Nonostante le limitate risorse naturali, la politica moderata e rispettosa della legalità ha consentito l'afflusso di notevoli capitali stranieri. Lo sviluppo economico ha creato tuttavia alcuni nuovi problemi, quali l'eccessiva immigrazione e la concentrazione urbana della capitale Abidjan, la città che detiene il record forse mondiale in fatto di crescita urbana; il paese comunque presenta delle caratteristiche di modernità che ne fanno un paese decisamente diverso da quello degli altri stati africani vicini.
Un destino in parte diverso da quello degli altri stati africani ha caratterizzato il Senegal diretto da Leopold Senghor, personaggio che per livello culturale risultava decisamente superiore agli altri grandi leader africani. Al di là delle scelte politiche del paese africano, Senghor ha dato un contributo notevole per l'affermazione di una “coscienza africana”. Secondo il poeta della negritudine il compito del nuovo stato africano era quello di integrare “i valori morali, se non religiosi, con i contributi politici ed economici delle due grandi rivoluzioni [borghese e marxista]”. Fondamentale a questo riguardo è secondo Senghor il rapporto fra europei e africani: “Non si tratta di inferiorità, così come non si tratta di superiorità né di antagonismo, si tratta di feconda diversità” , politica che può costituire motivo di arricchimento per tutto il genere umano.
Il leader africano riconosceva che il colonialismo europeo era stato un fenomeno non del tutto deprecabile e che “situato nel suo contesto è stato nient'altro che un male necessario, una necessità storica dalla quale deve scaturire il bene” . Secondo una corrente di pensiero moderata infatti, il colonialismo in Africa aveva portato a episodi di sfruttamento con un certo impoverimento materiale e spirituale delle popolazioni africane, tuttavia aveva contribuito all'unificazione del continente attraverso l'adozione delle lingue europee e lo sviluppo delle comunicazioni.
La scelta di Senghor nel campo politico era tutta a favore del socialismo democratico e umanitario e contro il comunismo che “umilia la dignità dell'uomo e opprime la libertà, sicché quella dittatura del proletariato, che nel pensiero di Marx avrebbe dovuto essere transitoria, ha finito per essere permanente dittatura di Stato e di Partito” . Il socialismo africano del leader senegalese si richiamava infatti a diverse fonti che andavano dai pensatori europei dell'Ottocento, al cristianesimo e alle antiche tradizioni comunitarie tribali, in un particolare e originale sincretismo.
Gli ideali del grande statista africano avevano portato a ricercare una più vasta integrazione con gli altri stati africani, privilegiando comunque l'unione dei paesi francofoni, e opponendosi ai disegni estremistici panafricani di Nkrumah. Tuttavia nonostante queste premesse il Senegal non ha conosciuto una democrazia, diversi oppositori politici sono stati incarcerati, e il sindacato costretto al silenzio, situazione che ha provocato nel corso degli anni diverse proteste popolari e studentesche.
Nel campo economico il Senegal ha favorito l'afflusso nel paese degli investimenti stranieri e perseguito una politica di buoni rapporti con la Francia, tuttavia ciò non ha impedito il sorgere di alcuni gravi problemi come quello della monocoltura e la eccessiva dipendenza dell'economia del paese dalla produzione di arachidi che costituiscono quasi la metà delle esportazioni. Il cooperativismo e la socializzazione nel settore agricolo ha dato risultati non brillanti e ha risentito anche dei gravi problemi dell'apparato statale che con i suoi 35.000 funzionari costituiva in rapporto alla popolazione una delle maggiori burocrazie del continente.
Negli anni immediatamente successivi alla decolonizzazione si ebbero due grandi crisi che sfociarono in guerre etniche nel Congo e nella Nigeria, le cui conseguenze sono state notevoli in tutto il continente africano.
Al momento dell'indipendenza il Congo si presentava come un paese decisamente arretrato, dove solo poche decine di persone su una popolazione di 15 milioni di abitanti avevano potuto accedere agli studi superiori . Due erano le maggiori organizzazioni politiche del paese, l'Abako, associazione dell'etnia bakongo che faceva capo a Kasavubu, favorevole al federalismo e al rispetto delle tradizionali autorità tribali e il Movimento Nazionale Congolese di Lumumba, che raccoglieva consensi in più etnie, più evoluto e favorevole ad una soluzione unitaria. Anche l'MNC comunque per un certo periodo di tempo era favorevole ad una soluzione moderata. In un suo discorso del marzo 1958 Lumumba sostenne che: “Gli scopi del MNC sono i seguenti: unire tutti i congolesi, senza distinzione di tribù, di razza, di sesso, di classe, per realizzare e consolidare l'unità politica del Congo; preparare i congolesi alla vita politica e alla direzione del paese; conquistare l'indipendenza e dare vita ad uno stato democratico e moderno, fondato sulla libertà, la giustizia, la pace sociale e il benessere di tutti i cittadini. Ponendosi questi obbiettivi, il MNC fonda la propria azione sulla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sulla Carta delle Nazioni Unite, che riconosce a tutti i popoli del mondo - compreso il nostro - il diritto di amministrarsi e governarsi da sé” . Successivamente il leader africano prese posizione più netta-mente contro il sistema delle “chefferies”, le autorità tradizionali delle varie popolazioni congolesi, provocando una scissione all'interno del movimento guidata da Kalonji, che diede vita ad una formazione politica autonoma nel Kasai.
Nel suo discorso per la proclamazione dell'indipendenza del paese, Lumumba pur auspicando una futura amicizia con il Belgio - “da pari a pari” - tracciò un quadro poco felice della dominazione coloniale belga nel paese: “Come dimenticare... Noi che abbiamo conosciuto il lavoro spossante in cambio di salari che non ci permette-vano placare la nostra fame, di vestire e abitare con dignità, di allevare i nostri bambini come esseri a noi cari? Noi che abbiamo conosciuto le ironie, gli insulti, le frustate, che dovevamo subire dalla mattina alla sera, perché eravamo «negri»? Chi dimenticherà che al negro si dava del tu, non come a un amico, perché l'onorevole lei era riservato ai soli bianchi?... Noi che abbiamo visto che la legge non era mai la stessa, ma diversa per i bianchi e per i negri, accomodante per i primi, crudele e disumana per i secondi?... Noi che abbiamo visto nelle città case stupende per i bianchi e capanne cadenti per i negri, che sappiamo come un negro non potesse entrare nei cinema, nei ristoranti, nei negozi riservati agli europei” .
Nelle settimane successive alla proclamazione dell'indipendenza in Congo si ebbero una serie di violenze che provocarono la fuga in massa degli europei residenti. Il Belgio inviò un contingente militare per difendere i concittadini, ma di fronte alla presa di posizione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (e quindi anche degli Stati Uniti, che tennero nelle vicende un comportamento diverso da quello dei paesi europei), fu costretto a ritirarle. Nel sud del paese le province del Kasai e del Katanga, la regione più importante per risorse minerarie, si proclamarono indipendenti e si opposero all'ingresso delle forze armate del governo centrale. In particolare il distacco del Katanga, ad opera del Conakat di Tshombè e di gruppi di mercenari, impensierì il partito di governo il quale vedeva, non senza ragione, l'intervento dei paesi europei teso a porre sotto il proprio controllo le grandi miniere di diamanti di quella regione.
Di fronte alla disgregazione dello stato Lumumba chiese l'intervento dell'ONU, ma l'azione dei caschi blu non venne considerata soddisfacente in quanto finalizzata a frenare le violenze più che a reprimere le spinte secessionistiche del paese. Pertanto il capo dell'MNC richiese l'intervento dei paesi africani rivoluzionari, Egitto, Ghana, Guinea, e dell'Unione Sovietica che non tardò a inviare i suoi “tecnici” nel paese. A seguito di quella che appariva come una svolta autoritaria nel paese il presidente della repubblica Kasavubu con l'appoggio del capo delle forze armate Mobutu, che in precedenza era stato esponente del partito lumumbista, destituì Lumumba. L'ex presidente del consiglio si rifugiò nella sua roccaforte a Stanleyville dove rinunciando ai suoi ideali unitaristi cercò di contrapporre un suo esercito al nuovo governo centrale.
Lo scontro fra le diverse componenti etniche del paese ebbe gravissime conseguenze. Lumumba venne arrestato, consegnato ai seguaci di Tshombé ed ucciso, mentre alcuni mesi più tardi lo stesso segretario generale dell'ONU Hammarskjöld, che si era impegnato in una difficile opera di pace, trovò la morte in un misterioso incidente aereo mentre percorreva lo sfortunato paese.
Nel '63 Tshombè e Gizenga, il successore Lumumba, dovettero arrendersi, ma non molto tempo dopo si ebbe una nuova rivolta capeggiata da Pierre Mulele sostenuta dal Congo Brazzaville e della Cina Popolare. La rivolta, alla quale per un breve periodo prese parte anche l'ex capo guerrigliero cubano Che Guevara, non aveva un programma politico definito e diede luogo a gravi violenze, come il sequestro dei cittadini bianchi a Stanleyville, che provocarono un nuovo intervento dei paracadutisti belgi. Kasavubu richiamò al potere il suo ex nemico Tshombé, ma non molto tempo dopo il generale Mobutu con un nuovo colpo di stato assunse i pieni poteri. Negli anni successivi, il paese pacificato ha conosciuto una rapida africanizza-zione (anche sul piano culturale con la rivalutazione della figura di Lumumba) e la nazionalizzazione, avvenuta comunque in accordo con i governi europei, delle sue riserve minerarie. Negli anni Settanta si ebbero nuovi fenomeni di guerriglia nel Katanga sostenuti dal governo angolano, repressi senza difficoltà dall'intervento di truppe marocchine e francesi. Le ingenti risorse minerarie del paese non hanno comunque contribuito allo sviluppo della nazione, e sono state utilizzate con grande discrezione dal presidente Mobutu che divenne uno dei personaggi più potenti e ricchi del continente africano. Secondo le affermazioni dello stesso ex segretario di stato americano Cyrus Vance, Mobutu si era impossessato nel corso degli anni della maggior parte delle riserve della banca centrale dello Zaire, e diversi uomini di governo risultavano implicati nell'esportazione illegale di oro e cobalto. Nel 1990 si sono avuti proteste studentesche sostenute anche dalla chiesa cattolica represse con violenza dalle autorità, e disordini di vario tipo che hanno provocato una situazione di instabilità e di nuovi contrasti etnici. La situazione è stata in parte superata con l'allargamento del governo ad altri gruppi politici senza comunque realizzare una autentica democratizzazione della vita politica del paese.
Anche il vicino Congo Brazzaville è stato teatro di drammatici avvenimenti. Ottenuta l'indipendenza nel 1960 sotto la guida dell'abate Youlou, nel 1963 il governo dell'ex colonia francese venne rovesciato da gruppi politici legati ad etnie diverse da quella del capo di stato. Negli anni successivi il paese diede sostegno a diversi movimenti guerriglieri africani, nazionalizzò numerose imprese e si trovò schierato a favore del blocco comunista. Nel 1968 un colpo di stato militare insediò una giunta militare su posizioni non meno estremistiche. L'instabilità politica e una gestione poco responsabile del potere ha portato il paese, non privo di risorse, verso una situazione economica gravissima e ad un debito con l'estero di notevole entità.
Nelle vicende dell'Africa occidentale molto rilievo ha assunto la Nigeria che con i suoi 85 milioni di abitanti costituisce di gran lunga il paese più popoloso dell'Africa nera. Il paese raggiunse l'indipendenza nel 1960 come repubblica federale, ma sette anni dopo fu teatro di una disastrosa guerra fra la più evoluta popolazione degli Ibo del Biafra, e gli Haussa della zona settentrionale del paese. Data l'importanza del paese per le sue riserve di petrolio, la guerra suscitò gli interessi delle grandi potenze: la Francia gollista parteggiò per i secessionisti biafrani, mentre l'Unione Sovietica e l'Organizzazione per l'Unità Africana prese le parti del governo di Lagos. Lo scontro produsse una gravissima carestia che provocò la morte di due milioni di persone e destò notevole emozione in tutto il mondo. Negli anni successivi il paese ha conosciuto un migliore destino, tuttavia non sono mancate agitazioni duramente represse dal governo militare. I problemi connessi all'immigrazione e all'eccessiva concentrazione urbana hanno determinato una notevole instabilità politica del paese.
I paesi minori della regione hanno conosciuto un analogo destino. Molti sono i paesi cha hanno seguito la strada delle nazionalizzazioni e della pianificazione economica come il Benin (Dahomey) e il Burkina Faso (Alto Volta), e altrettanto numerosi sono i paesi come il Camerun e la Sierra Leone, che hanno conosciuto scontri fra gruppi etnici e religiosi. La poco conosciuta Repubblica Centrafricana ha avuto il suo momento di popolarità, intorno agli anni Settanta quando il generale Bokassa, già presidente a vita, si fece nominare nel 1977 imperatore. La dissipazione di fondi dello stato per la realizzazione di opere simbolo di potere, e l'uccisione di oppositori politici divenne la regola di governo fino a quando, con l'appoggio delle truppe francesi, vennero restituiti i poteri al precedente presidente Dako che riportò una relativa normalità nel paese.
L'AFRICA ORIENTALE E ANGLOFONA
L'Africa orientale e anglofona ha conosciuto governi più moderati e conservatori (almeno secondo il significato che si è soliti attribuire a questo termine) rispetto a quelli dell'Africa occidentale francofona. Tuttavia nelle sue regioni più arretrate i conflitti etnici hanno assunto proporzioni notevoli, più volte degenerati in episodi gravissimi di violenza. Una significativa eccezione a questa situazione è rappresenta-ta dalla Tanzania che per un certo periodo di tempo ha sperimentato una originale “via africana al socialismo”, lontana comunque dagli eccessi di altri paesi.
Come negli altri paesi socialisti del continente vennero eliminati i poteri locali delle dinastie tribali, ma la caratteristica fondamentale del governo di Nyerere è stata la rivalutazione dell'agricoltura e della società rurale, rispetto all'industria e alla organizzazione urbana. Secondo i principi della Carta di Arusha del 1967 la Tanzania doveva procedere essenzialmente contando sulle sue forze e sul “capitale umano” anziché dipendere dagli aiuti dall'estero, e occorreva riorganizzare la società su un modello cooperativistico incentrato sui villaggi ujamaa (= famiglia), una forma di collettivizzazione che a differenza di altri paesi africani rispettava le usanze locali delle comunità. Per un certo periodo venne deciso il trasferimento forzato della popolazione contadina nelle zone incolte, ma il progetto venne presto abbandonato. Vennero nazionalizzate le terre, ma anche importanti settori dell'economia e del commercio. Tale politica portò, come lo stesso Nyerere riconobbe, alla formazione di una burocrazia inefficiente e corrotta. In una intervista del 1987 il Mwalimu (= il maestro) parlando del periodo precedente affermò: “Io credevo nelle nazionalizzazioni. Ma dal punto di vista del management non eravamo pronti. Non sapevamo come si gestisce un'industria. Perciò ecco, se dovessi rifarlo... L'industria del sisal [una fibra vegetale che costituiva la principale industria tessile del paese] non la nazionalizzerei” , analogamente in molti campi ritenne che si sarebbe potuto procedere con maggiore moderazione.
Anche Nyerere come molti altri leader riteneva che le riforme economiche dovessero precedere quelle politiche; “Fino a che la nostra battaglia contro la povertà, l'ignoranza e la malattia non sarà vinta” sostenne in un suo discorso durante la fase della mobilitazione delle masse, “non lasceremo che la nostra unità venga distrutta da codici di regole estranei” , e a tal proposito va riconosciuto al governo tanzaniota alcune realizzazioni significative nel campo sanitario e scolastico. Per un certo periodo sembrò che alcune innovazioni si ispirassero al modello cinese; vennero presi provvedimenti contro il vagabondaggio, l'ubriachezza e l'ozio, e creato una organizzazione che ricordava quella delle Guardie Rosse, tuttavia si mantenne rigorosamente lontano dagli eccessi di quel regime, e il numero di detenuti politici, risultò sempre particolarmente basso. Negli stessi anni venne decisa la creazione di una nuova capitale Dodoma, che come l’analogo progetto di Brasilia in America Latina, risultò dispendioso e venne successivamente abbandonato. Il paese ha goduto di una notevole stabilità interna decisamente superiore a quella di molti altri paesi africani, tuttavia la difficile situazione economica degli anni '73-'74, caratterizzata da un forte debito verso l'estero, ha portato il paese ad una politica più moderata, all'eliminazione di alcune istituzioni socialiste e all'accettazione di una parte notevole delle indicazioni del Fondo Monetario Internazionale.
La Tanzania ha seguito una politica estera particolarmente attiva, ispirata al panafricanismo, ricercando comunque la collaborazione sia dei paesi occidentali, sia di quelli comunisti e della Cina. Più difficili sono risultati i rapporti con i paesi vicini; dopo un tentativo fallito di federazione con l'Uganda e il Kenya, si ebbero notevoli attriti che diedero vita a reciproci sconfinamenti di truppe. La politica di solidarietà africana portò la Tanzania a costituire una importante base d'appoggio per i movimenti guerriglieri anticolonialisti che operavano in Rhodesia e nell'Africa portoghese.
La stabilità di governo e una politica moderata hanno consentito un relativo sviluppo del Kenya che con Yomo Keniatta ha saputo intraprendere una politica di equilibrio interno ed internazionale.
La nascita del paese fu invece caratterizzata da vicende più tumultuose; nel 1952 si ebbe la rivolta xenofoba dei Mau-Mau (appartenenti alla stessa etnia del presidente, i Kikuyu) che diede luogo a gravi violenze, e venne repressa dagli inglesi con 40.000 morti. La rivolta costituì l'unico caso di moto anticolonialista violento nell'Africa britannica ma fortunatamente non determinò gravi conseguenze sul futuro della nazione, che negli anni successivi ha saputo dimostrare notevole moderazione.
Anche nello stato keniota si è avuto un regime monopartitico, che tuttavia non ha impedito una certa tolleranza, turbata per un breve periodo solo dall'attività di un gruppo radicale, il Kenya People's Union e da contrasti per questioni territoriali con la Somalia e la Tanzania. Diversamente da altri paesi africani le proprietà di piantagioni agricole degli ex coloni sono state rispettate, e ciò ha consentito l'afflusso di capitali stranieri e lo sviluppo di diverse attività economiche.
La regione attorno al Lago Vittoria, considerata dagli inglesi come una delle più belle d'Africa, è stata teatro di drammatiche vicende. In Uganda il generale Idi Amin, un semianalfabeta dedito ai riti di stregoneria, instaurò negli anni Settanta con l'appoggio della Libia una feroce dittatura. Vennero uccisi numerosi oppositori politici e massacrate le tribù rivali - si parla di circa 300.000 morti in un breve periodo di tempo - ma i gravi atti di violenza di cui si è macchiato il dittatore non hanno impedito al governo di disporre del sostegno della maggioranza degli stati africani e di ottenere diversi riconoscimenti internazionali. La caduta del dittatore nel 1977 per opera dell'ex presidente Obote e dell'esercito tanzaniano, non ha riportato tuttavia la calma nel paese e negli anni successivi si ebbero nuovi massacri e saccheggi, che hanno isolato il paese dal resto del mondo.
I due piccoli ma popolosi stati del Ruanda e Burundi sono stati negli ultimi decenni teatro di sanguinose lotte fra la maggioranza Hutu e la minoranza Tutsi (Batutsi e Watussi) che in anni precedenti costituivano il gruppo etnico dominante. Nel '59 e nel '62 le due ex colonie belghe hanno conosciuto gravissimi scontri fra le due comunità che hanno causato la morte di migliaia di persone e la fuga di gran parte dei Tutsi dal Ruanda. Negli anni successivi si sono avuti nuovi scontri nel Burundi che hanno causato un numero elevatissimo di morti, e nel 1994 il conflitto ha assunto proporzioni più gravi da far pensare al genocidio della comunità Hutu in Ruanda.
Le vicende del Sudan, paese che per ragioni geografiche risulta molto legato all'Egitto, sono state caratterizzate dagli scontri fra le popolazioni del nord mussulmane e relativamente più progredite, e quelle del sud cristiane e animiste. Il contrasto ha dato origine a gravissimi episodi di violenza, e ha impedito il progresso economico del paese. In anni recenti si è avuta l'affermazione del partito islamico che ha dato vita ad un regime integralista nel paese particolarmente severo, e incapace di stabilire buone relazioni con i paesi avanzati.
Anche la grande isola del Madagascar ha conosciuto una difficile via per l’indipendenza. Nel 1947 dopo una serie di violenze contro i coloni, venne scatenata dalle autorità francesi una repressione che costò la vita a decine di migliaia di persone. Negli anni successivi alla decolonizzazione, il paese ha conosciuto una situazione economica relativamente tranquilla, sottoposto tuttavia ad una pesante dittatura. Negli anni Settanta in seguito ad un colpo di stato militare, la nazione africana ha proceduto sulla strada delle nazionalizzazioni economiche, e si è avvicinata alla Cina e successivamente all’Unione Sovietica.
L'Africa ex italiana ha costituito e costituisce una delle zone più arretrate e povere dell'intero continente, e il teatro di numerose dispute etnico-politiche. Nel corso degli anni Sessanta il governo dell'imperatore Haile Selassiè, capo politico e religioso della nazione, ha proceduto a limitate riforme che non hanno intaccato la struttura arretrata del paese e l'assoggettazione delle popolazioni contadine al potere feudale degli aristocratici locali. Si sono avute pertanto numerose proteste represse con brutalità dalla polizia segreta e la rivolta dell'Eritrea, paese formalmente indipendente, legato all'Etiopia da un trattato federale.
Nel 1974 una grave carestia nel paese ha portato ad un colpo di stato diretto da giovani ufficiali finalizzato non solo a rovesciare l'anziano e odiato imperatore, ma anche ad abolire i privilegi feudali e ad introdurre una serie di riforme politiche ed economiche. Dopo due anni caratterizzati da incertezze politiche e rivolte contro la collettivizzazione delle terre, il potere venne assunto dal colonnello Menghistu. La persecuzione negli anni successivi delle tribù ritenute ostili provocò la morte di migliaia di persone e circa un milione e mezzo di profughi che cercarono rifugio nei paesi vicini. Contemporaneamente si ebbe l'inasprimento della guerra con l'Eritrea e un nuovo conflitto con la Somalia per il possesso dell'Ogaden, una regione semidesertica abitata da popolazioni somale. Il sostegno sovietico al governo di Adis Abeba risultò determinante per l'andamento del conflitto, ma nel 1984 e nel 1987 si ebbero due nuove carestie che sconvolsero il paese e provocarono la morte di oltre due milioni di persone. Per fronteggiare la situazione il governo italiano stabilì l'invio di consistenti aiuti che tuttavia vennero utilizzati dal governo etiope più per neutralizzare l'azione delle popolazioni contrarie al regime che per prestare soccorso alla grande massa di profughi. La tragedia dello sfortunato paese ebbe termine nel 1991 quando il ritiro sovietico e l'estendersi della rivolta al Tigrai e ad altre parti del paese costrinse alla fuga il dittatore.
Anche la Somalia, sebbene costituisca uno dei rari esempi di paese africano omogeneo sul piano etnico e religioso, è stata teatro di drammatiche vicende. Nel '69 un colpo di stato militare portò al potere un regime marxista, che tentò di eliminare le autorità tradizionali locali e imporre delle forme di controllo sulle popolazioni nomadi. Dopo la sfortunata guerra dell'Ogaden si crearono nel nord e nel sud del paese movimenti di opposizione al governo del generale Siad Barre. L'unione di questi gruppi nell'estate del 1990 ha determinato la caduta del dittatore, tuttavia la degenerazione del conflitto nello scontro fra bande rivali ha prodotto una grave carestia nel paese e la fuga di centinaia di migliaia di somali nel nord del Kenya.
LA LOTTA AL COLONIALISMO
NELL'AFRICA AUSTRALE
Il problema della decolonizzazione ha assunto nell'Africa australe problemi maggiori che in altri paesi africani dove generalmente l'indipendenza è stata ottenuta attraverso negoziati fra i governi europei e i partiti locali di opposizione. Il governo portoghese e le comunità bianche dell'Africa ex britannica hanno opposto una strenua resistenza ai movimenti di liberazione, che ha provocato la reazione degli altri paesi africani e dell'Organizzazione per l'Unità Africana.
Il Nyasaland (oggi Malawi), la Rhodesia del nord (oggi Zambia) e la Rhodesia del sud (oggi Zimbabwe), per iniziativa britannica costituirono nel 1953 la Federazione dell'Africa centrale, ma di fronte all'opposizione dei gruppi politici neri, venne sciolta dieci anni dopo, e i tre paesi raggiunsero successivamente la piena indipendenza. Il ricco paese dello Zambia è stato quello dove maggiormente attivi sono stati i movimenti di opposizione, e attraverso la guida di un prestigioso leader politico, Kenneth Kaunda, venne raggiunta nel 1964 l'indipendenza del paese.
Nel 1968 il presidente Kaunda lanciava un interessante programma politico, la Carta di Mulungushi, per un socialismo democratico, africano e “umanista”, nella quale si affermava che: “Le nostre istituzioni devono essere tutte in funzione dell'interesse dell'uomo comune, e questo significa principalmente provvedere all'alimentazione, al vestiario e ad abitazioni decorose per tutto il popolo e non per pochi privilegiati soltanto”. Nel campo economico il leader politico si esprimeva per un sistema sostanzialmente equilibrato “Non penso che si abbia il diritto di soffocare l'iniziativa individuale, a meno che naturalmente non si continui a permettere, come si sta facendo tuttora, lo sfruttamento del nostro paese da parte dei capitali stranieri. Il fatto di esserci dichiarati in favore di un'economia mista è qualcosa di più di una semplice ammissione dell'iniziativa individuale; del resto non conosco alcun paese del mondo occidentale o del mondo orientale in cui non sia praticata in qualche misura un'economia di tipo misto... Ci sono molti esempi in Occidente e in Oriente di priorità data al settore dell'industria pesante, con il lancio di grossi progetti basati sui metodi di produzione più sofisticati e moderni senza porsi il problema di una scelta fra le alternative possibili... Più volte ho insistito perché lo sviluppo rurale cominci a livello di villaggio con le circa 450.000 aziende familiari che abbiamo” .
Il prestigioso leader africano dava vita ad un governo moderato che sebbene all'interno contasse una notevole presenza di uomini dell'etnia Bemba alla quale apparteneva Kaunda, ha saputo gestire il paese con notevole moderazione ed equilibrio. Il Partito dell'indipendenza nazionale sebbene costituiva il partito dominante nella vita politica del paese, ha comunque consentito la costituzione di movimenti politici alternativi, e ha dato vita ad un sistema politico tollerante. Il paese ha conosciuto dal punto di vista economico una situazione migliore a quella di altri paesi africani, tuttavia nei primi anni Settanta la caduta del prezzo del rame, che costituisce la principale risorsa del paese, e la politica di nazionalizzazione delle aziende straniere ha provocato una crisi economica che ha prodotto un rallentamento della crescita economica, alla quale il governo ha fatto fronte con una politica più liberista.
Nel campo della politica estera lo Zambia ha dovuto tener conto della sua particolare posizione geografica; sebbene abbia sostenuto i movimenti guerriglieri che operavano nella vicina Rhodesia, ha saputo condurre efficaci trattative con i paesi “razzisti” per evitare lo strangolamento economico al quale il paese poteva essere sottoposto e ha cercato i buoni rapporti con la vicina Tanzania. Con quest'ultimo paese alla fine degli Sessanta venne realizzata una importante ferrovia la Tanzam, realizzata da tecnici cinesi (è la maggiore opera del governo comunista cinese all'estero) che ha consentito di assicurare uno sbocco al mare del paese senza dipendere dai paesi colonialistici.
Il Portogallo dissanguò le sue non floride finanze per mantenere i suoi diritti in Angola e Mozambico, sottoponendo le popolazioni locali ad uno dei peggiori regimi colonialistici. La crisi economica conseguente agli eccessivi impegni militari in Africa portò nel 1975 non solo al distacco delle due colonie ma anche alla dissoluzione del vecchio regime totalitario portoghese. La lotta del popolo angolano secondo Agosthino Neto non costituiva una guerra razziale “Il nostro obbiettivo” sostenne in un suo discorso a Radio Tanzania nel giugno del 1968 “non è di combattere l'uomo bianco solo perché bianco. Il nostro obbiettivo è combattere contro coloro che appoggiano il regime coloniale... La nostra lotta non è isolata nel mondo, essa fa parte di una lotta globale dell'umanità perché finisca lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo” .
In Angola le tre principali formazioni anticolonialiste, l'MPLA di Agostinho Neto, l'FNLA di Holden Roberto (esponente politico legato a vincoli di parentela con Mobutu), l'UNITA di Savimbi (che nel corso degli anni ha assunto diverse connotazioni politiche) non furono in grado di raggiungere un accordo per l'amministrazione del paese, e la prima delle tre organizzazioni con il sostegno finanziario e militare di Unione Sovietica e Cuba cercò di dare vita ad un regime autoritario - non riconosciuto dall'OUA - senza comunque avere ragione degli avversari. L'esperienza politica di Agostinho Neto ricordava da questo punto di vista quella di Patrice Lumumba, moderato per un certo periodo di tempo, fino alla conquista del potere, e successivamente contrario alla condivisione del potere con altre forze politiche e gruppi etnici.
Il paese sebbene ricchissimo di materie prime divenne uno degli stati più poveri del continente; la fuga di tecnici e di capitali stranieri, e la nazionalizzazione condotta con metodi autoritari delle terre, fu all'origine della gravissima situazione economica che ancora attanaglia il paese. Solo dopo la morte di Neto e il ritiro dei sovietici venne tentato un accordo fra le parti che diede l'avvio ad un regime più moderato.
Il Mozambico più povero e arretrato non ha conosciuto un migliore destino. La fuga di quadri amministrativi e dei tecnici stranieri provocata dal regime marxista di Samora Machel, e lo stato di continua tensione con la Rhodesia, aggravarono le condizioni del paese. Gli aiuti sovietici non furono in grado di migliorare la situazione economica né di sconfiggere la guerriglia sorretta dal governo di Salisbury e successivamente dal Sud Africa. Anche qui il venire meno dell'aiuto di Mosca ha favorito l'accordo fra le fazioni e una politica più equilibrata nel paese.
Nella Guinea Bissau il movimento di opposizione al governo portoghese è stato portato avanti da un leader socialista non estremista, Amilcar Cabral, un esponente politico non privo di qualità politiche. Morto il prestigioso leader, che aveva ottenuto diversi riconoscimenti internazionali, si ebbe il tentativo di instaurare nel paese un regime più accentuatamente marxista ma senza successo.
Nel 1965 la Rhodesia proclamava unilateralmente l'indipendenza dalla Gran Bretagna dando origine ad un grave contrasto fra il governo britannico e quello della neo-nata repubblica. Il governo di Jan Smith, espressione della comunità bianca della Rhodesia, era arrivato alla grave decisione timoroso che l'avvio di negoziati per l'indipendenza avrebbe significato l'allargamento del potere ai neri, largamente mag-gioritari nel paese. Le sanzioni richieste dal governo di Londra non riuscirono a piegare la colonia ribelle, e solo anni di intensa guerriglia condotta dalle organizzazioni marxiste del ZAPU e del ZANU (legate rispettivamente all'Unione Sovietica e alla Cina) costrinsero gli europei alla apertura di negoziati che portarono alla creazione del Zimbabwe. Negli anni successivi tuttavia il governo africano stemperava notevolmente i suoi contenuti dottrinari, e ricercava una maggiore collaborazione internazionale.
Una situazione molto più grave rispetto alla Rhodesia si aveva in Sudafrica, dove la maggioranza nera veniva privata dei suoi diritti civili e politici. La legislazione razzista nei confronti di neri, asiatici e meticci, era stata già preparata in parte sotto l'amministrazione britannica, secondo il giornalista inglese Paul Johnson dopo la vittoria del partito degli afrikaner nel 1948 “I nazionalisti trasformarono la segregazione in una dottrina filosofica, quasi religiosa... Sotto la superficie l'apartheid era un miscuglio confuso, poiché combinava insieme elementi incompatibili tra loro. Come razzismo pseudo-scientifico derivava, come l'hitlerismo e il leninismo, dal darwinismo sociale; come razzismo religioso derivava dalle credenze fondamentaliste, che negavano qualsiasi forma di darwinismo” . Il caso del Sudafrica rappresentava non solo una forma di razzismo ma anche una sorta di “ingegneria sociale” come è stata definita, con numerosi spostamenti di popolazioni, in genere a sfavore delle comunità negre, basata su principi antiumanistici.
Le leggi razziste non erano finalizzate solo al mantenimento del potere dei bianchi (come nel caso della vicina Rhodesia), ma prevedevano il divieto di matrimoni e rapporti sessuali fra individui appartenenti a razze diverse, una eccessiva discrezionalità dei poteri di polizia, e notevoli limitazioni nelle attività politiche (norma questa applicabile sia ai bianchi che ai neri), e negli spostamenti delle persone. Negli anni successivi la legislazione segregazionista venne ulteriormente aggravata con la creazione dei Bantustans, territori semi-indipendenti che costituivano il 13% del territorio, e che avrebbero dovuto ospitare oltre la metà della numerosa popolazione negra.
La reazione dei negri ha assunto forme diverse; nel 1912 venne creata l'African National Congress, associazione che ha assunto con Nelson Mandela un largo seguito nel paese. L'organizzazione, che si ispirava al partito del Congresso indiano, aveva finalità moderate; nel Manifesto della Lega della Gioventù dell'ANC del 1944 si affermava che l'africano “...non era stato condotto nelle zone urbane per civiliz-zarlo aprendogli le strade del lavoro qualificato. Era stato condotto là, affinché potesse far parte di una riserva di manodopera vicina, a buon mercato e non qualificata. Ciò è stato alla fine stabilito dalla legge delle barriere di colore” pertanto gli autori del documento ritenevano che per l'uomo di colore “L'autodeterminazione è la filosofia di vita che lo salverà da quel disastro che vede chiaramente davanti a sé... combattiamo la disgregazione morale tra gli africani mantenendo e rafforzando in noi stessi degli alti criteri morali. Crediamo nell'unità di tutti gli africani, dal Mar Mediterraneo a nord sino all'Oceano Indiano e all'Oceano Atlantico a sud - e crediamo che gli africani debbano parlare con una sola voce” . Anche nei programmi politici degli anni successivi venne scartato l'estremismo e i progetti di cacciare gli europei dal paese e nel Documento di politica di base redatto personal-mente da Nelson Mandela si leggeva che “La sola forza che può dare alle masse nere la fiducia in sé e il dinamismo necessari al successo della lotta è la fede nel nazionalismo africano così come viene difeso dalla Lega della Gioventù” .
Nel 1960 in seguito agli scontri di Shaperville l'ANC venne dichiarato illegale e molti dei suoi dirigenti furono arrestati. Il duro provvedimento costrinse all'azione clandestina i leader neri, e lo stesso Mandela si espresse per un certo periodo di tempo a favore della lotta armata. In un successivo processo che costituì una sorta di condanna morale dell'apartheid il leader africano asserì. “Nel corso della mia vita, io mi sono interamente consacrato alla lotta del popolo africano. Ho lottato contro la dominazione bianca e ho lottato contro la dominazione nera. Il mio ideale più caro è stato quello di una società libera e democratica in cui tutti vivessero in armonia e con eguali opportunità” .
Nonostante il boicottaggio dei paesi dell'OUA, dell'ONU, e degli stessi paesi europei, il Sudafrica conobbe una notevole espansione economica che solo in anni recenti ha iniziato ad entrare in crisi. Accanto alla crisi economica si è avuta l'intensificazione delle manifestazioni popolari contro l'apartheid; nel '76 si è avuta la prima grande sollevazione del ghetto nero di Soweto che si concluse tragicamente con la morte di centinaia di neri. Nel 1985 le manifestazioni e le violenze ripresero, e portarono alla proclamazione dello stato d'emergenza da parte del governo. Negli anni successivi il partito nazionalista fu costretto ad abolire la legislazione razziale e pur cercando di favorire i contrasti all'interno delle etnie nere, si trovò costretto ad aprire negoziati con l'opposizione, che si conclusero nel 1994 con l'instaurazione di uno stato democratico a maggioranza nera.