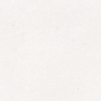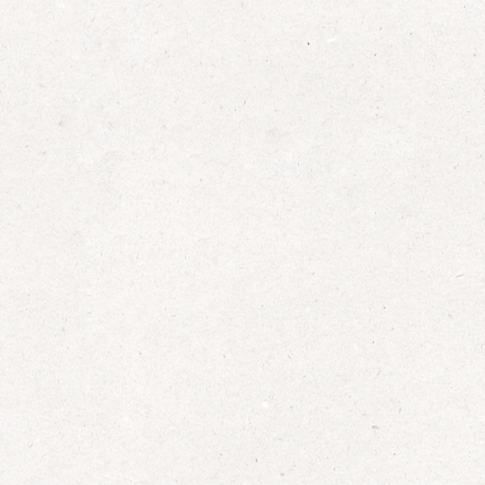INTRODUZIONE
Scrivere una storia del Terzo Mondo non è una impresa facile sia perché molto materiale utile non è facilmente accessibile, sia perché i paesi in via di sviluppo non costituiscono una unità culturale, ma costituiscono piuttosto la “periferia” del mondo. I paesi del Terzo Mondo comprendono infatti una grande varietà di nazioni con caratteristiche così diverse che difficilmente si possono considerare come appartenenti ad un'unica entità; esistono paesi poveri e paesi potenzialmente molto ricchi, paesi semidisabitati e paesi dove la concentrazione demografica e urbana raggiunge livelli patologici, vi sono paesi multietnici e paesi omogenei, alcuni dei quali - come i paesi della parte meridionale dell'America Latina - abitati da popolazioni per nulla diverse dal punto di vista etnico da quelle europee. Vi sono poi paesi retti da governi se non democratici almeno tolleranti, e paesi che hanno conosciuti regimi che forse non è eccessivo definire dispotici, paesi pacifici e paesi dove la guerra appare endemica. Tuttavia il problema del Terzo Mondo, con il suo notevole sviluppo demografico, rappresenta una questione troppo importante per non essere affrontata, e molto probabilmente nel prossimo futuro il problema del rapporto fra Nord e Sud è destinato a divenire uno dei principali problemi dell'umanità.
Dalla decolonizzazione fino agli anni Ottanta il Terzo Mondo ha dato prova di una pessima gestione della sua libertà. I nuovi paesi afroasiatici una volta raggiunta l’indipendenza dalle antiche potenze colonizzatrici caddero in mano di uomini politici privi di senso dello stato. Nel giro di pochi anni la maggior parte di questi si avviarono verso la dittatura e lo scontro fra gruppi etnici diversi, in contrasto con quei principi che gli stessi si erano dati alla conferenza di Bandung. I dittatori e le classi dirigenti locali si diedero alla corruzione e alla dilapidazione delle finanze pubbliche, si lanciarono in ambizioni smodate, spesso in aperta sfida alla comunità internazionale, inseguendo progetti economici dissennati e talvolta autodistruttivi. Il risultato di questa politica fu il sensibile peggioramento delle condizioni economiche di molti paesi, la fuga dei capitali stranieri, l’isolamento.
Un relativo miglioramento si è avuto invece nel corso dell’ultimo ventennio. La democrazia ha registrato progressi significativi, i leader politici hanno compreso la necessità di allargare le loro basi di consenso, e una certa moderazione è subentrata nelle relazioni fra gruppi etnici diversi. L’Asia presenta una maggiore stabilità politica, l’Africa appare invece in ritardo, e a sud del Sahara non mancano scontri tribali e religiosi che distruggono stati e risorse.
Molte delle opere scritte negli anni Sessanta e Settanta risentono eccessivamente del clima di fiducia creato dalla comparsa di movimenti terzomondisti, e diversi avvenimenti sono stati interpretati in maniera eccessivamente ideologizzata e poco corrispondente alla realtà. Non pochi regimi autoritari hanno tentato infatti di darsi una immagine credibile attraverso l'adesione a ideologie che trovavano largo consenso in Occidente, e che nascondevano in realtà ambizioni dittatoriali tradottesi in diversi casi in episodi di gravissima violenza. Come vedremo nelle prossime pagine, pochi governi hanno scelto di privilegiare il benessere economico delle popolazioni agli interessi immediati dei gruppi politici di varia natura, che con metodi diversi, ma spesso poco chiari, gestiscono il potere di quei paesi.
parte 1°
la prima generazione di rivoluzionari
Il comunismo è stato il grande protagonista dell'Est asiatico negli anni successivi alla seconda guerra mondiale. Una delle caratteristiche fondamentali dei regimi sorti da tale dottrina non è stata, come si è ritenuto nel passato, la realizzazione di grandi riforme socio-economiche (che in alcuni casi non sono mancate), finalizzate alla creazione di una società più giusta, ma il controllo sistematico della collettività da parte dello stato e il sacrificio degli interessi della popolazione, urbana e rurale, alle esigenze della industria pesante e dell'apparato militare. Così in anni recenti, nonostante le difficoltà economiche, la Repubblica Democratica del Vietnam e la Corea del nord destinavano circa il 20% del proprio reddito alle spese militari, (contro una media del 5% dei paesi asiatici) mentre ben cinque paesi comunisti rientravano nella classifica mondiale delle prime dodici nazioni per rapporto spese militari-reddito nazionale .
Il maoismo - che costituisce sicuramente il movimento più originale del comunismo asiatico - richiedeva una sottomissione al potere non solo formale ma totale dell'individuo, e ogni atto della vita anche privata della persona veniva sottoposta a rigido controllo da parte dello stato; nel nuovo regime instauratosi in Cina in quegli anni non erano ammesse posizioni “neutrali” e tutto ciò che era ritenuto contrario agli interessi dello stato veniva combattuto con veemenza. Secondo l'ex cancelliere tedesco Helmut Schmidt “La monotonia che accompagnava il trionfo del «pensiero di Mao» era opprimente, anzi lo sfrenato inneggiamento al capo carismatico della Cina comunista faceva istantaneamente insorgere domande del tipo: perché è necessaria tanta esaltazione?” . Nel corso degli anni in Cina si sono avuti numerosi episodi di violenza; le repressioni attuate a più riprese dal regime non potevano trovare giustificazione con i problemi connessi con la vastità del paese da governare come talvolta è stato affermato, l'India che come popolazione è quasi altrettanto numerosa e comprende una non minore eterogeneità di razze, ha conosciuto nello stesso periodo un destino molto diverso nel quale non hanno trovato posto a differenza dell'esperienza cinese le persecuzioni di massa.
Le riforme promosse dai regimi comunisti, ed in particolare la riforma agraria, non hanno consentito un miglioramento della produzione agricola né il miglioramento delle condizioni dei contadini, tali riforme sono risultate finalizzate sostanzialmente alla eliminazione di quelle categorie che venivano ritenute contrarie allo stato. Ad uno sguardo retrospettivo, nel sud-est asiatico i governi ritenuti conservatori: Thailandia, Filippine, Malaysia (particolarmente quest'ultimo) sono stati quelli che hanno conosciuto un maggiore sviluppo economico e hanno realizzato istituzioni pluripartitiche, che se non hanno dato vita ad una democrazia come viene intesa in Occidente, hanno evitato comunque le violenze e le forme di autoritarismo peggiori tipiche dei regimi rivoluzionari.
Un'altra caratteristica dei regimi comunisti asiatici scarsamente messa in rilievo è stata la tendenza al fanatismo al limite dell'idolatria: Mao, Ho Chi Minh, Kim Il Sung, divennero oggetto di un culto della personalità superiore a quello avutosi negli anni precedenti in Unione Sovietica; nella Corea del nord in particolare il grande leader si fece erigere monumenti e templi in proprio onore; mentre in Cina e in Vietnam Mao e Ho furono in vita e dopo la loro morte posti in una posizione superiore a quella degli altri compagni di partito e considerati guide insindacabili dei loro popoli.
Si è parlato talvolta nel mondo comunista asiatico della diversa posizione della donna nella società, tuttavia occorre ricordare che se le donne hanno conosciuto una migliore situazione rispetto al passato, queste non sono mai arrivate ad avere una significativa presenza all'interno della classe dirigente di quei paesi, e che l'emancipazione dell'altro sesso ha consentito sostanzialmente di disporre di una maggiore forza lavoro.
LA CINA DI MAO TZE TUNG
Nel corso dell'Ottocento la Cina aveva attraversato un periodo di grande decadenza politica ed economica causata dalle attività delle potenze occidentali e del Giappone nel paese, ma ancor più dalla crisi profonda delle dottrine confuciane che avevano costituito la base etico-politica dello stato. La dottrina di Confucio per secoli aveva regolato la vita delle istituzioni del paese, ma incontrava sempre maggiori difficoltà in un mondo sconvolto da nuovi fermenti. Secondo il confucianesimo la realtà umana costituiva qualcosa di profondamente statico che doveva essere retta da norme certe e inamovibili; al vertice della società era l'imperatore - il Figlio del Cielo - e al di sotto una piramide di funzionari scelti secondo criteri particolarmente rigorosi. Nel corso dell’Ottocento sorsero numerose sette con finalità politico-religiose diverse, che riprendevano da dottrine eterogenee e alquanto singolari; molte di esse sostenevano principi intransigenti e xenofobi che in genere non hanno lasciato traccia nei successivi periodi storici, alcune tuttavia hanno contribuito alla formazione di successivi movimenti contrari al potere imperiale dei Manciù.
Nel 1901 il governo e la corte imperiale accettavano di dare vita ad una diversa organizzazione dello stato di stampo occidentale, ma le riforme tardive non consentirono come in altri casi in quel periodo storico, la conservazione delle istituzioni, e la monarchia non poté sopravvivere alla morte della sovrana avvenuta alcuni anni più tardi. Nella Cina precipitata nel mondo moderno si vennero a formare così due poteri contrapposti, il governo di Pechino retto dal pragmatico e autoritario Yuan Shih Kai e il governo di Canton retto da Sun Yat Sen padre del Kuomintang e fondatore della Cina moderna. Alla morte del primo, che per un breve periodo aveva tentato la restaurazione di un potere imperiale, la Cina si disgregò in un vasto numero di regioni rette da capi militari, i signori della guerra, in perenne stato di discordia, molti dei quali si reggevano sul sostegno di governi stranieri.
Sun Yat Sen, costituì una eccellente figura di capo rivoluzionario e di teorico; formatosi culturalmente nel mondo occidentale attraverso lo studio di numerosi autori classici dell'Ottocento (fra i quali anche i grandi pensatori socialisti), nel 1898 aveva enunciato i tre principi del popolo che avrebbero costituito la base del nuovo movimento politico, e che potrebbero essere tradotti come nazionalismo, potere popolare e giustizia sociale. Sun si fece sostenitore inoltre di una riforma agraria che avrebbe dovuto consentire la formazione di vaste proprietà statali e l'attribuzione a ciascuna famiglia di contadini di un piccolo appezzamento di terra; tuttavia non meno importante della questione sociale fu per il pensatore cinese l'impegno perché la Cina si affrancasse dalla tutela giapponese e dai numerosi trattati ineguali imposti negli anni precedenti dalle potenze occidentali, che limitavano notevolmente la sovranità cinese. L'esponente nazionalista si fece promotore comunque di alcuni principi politici inconsueti; riteneva infatti che una volta affermatasi la democrazia in Cina la costituzione del nuovo stato avrebbe compreso accanto ai tre poteri, esecutivo, legislativo e giudiziario, tipici del mondo occidentale, anche un potere di controllo sull'accesso ai pubblici poteri e di censura sui comportamenti dei cittadini e degli uomini dell'apparato statale, istituzioni che forse mal si concilierebbero con quelle di uno stato democratico.
Il Kuomintang (= partito nazionale del popolo) sorto in quegli anni ad opera di Sun ebbe l'appoggio dell'Unione Sovietica e per un certo periodo sembrò orientarsi verso il modello sovietico, sebbene nel 1924 il governo bolscevico si fosse dimostrato scarsamente accondiscendente nella rinuncia delle concessioni e privilegi appartenenti al passato regime zarista. Nonostante alcuni successi i nazionalisti non riuscirono a portare a termine la riunificazione del paese a causa della presenza dei rissosi signori della guerra, che specialmente al nord imperversavano, e a causa della sempre più evidente politica espansionista giapponese nel paese.
Anche se il governo di Sun costantemente impegnato nel contrasto con le altre forze politiche e militari del paese non fu in grado di dare vita ad una grande riforma dello stato, tuttavia negli anni Venti si ebbero alcune importanti innovazioni nei costumi della società cinese e l'abbandono di quelle istituzioni più antiquate (come l'usanza terribile della fasciatura dei piedi delle donne), inconcepibili con una società evoluta. Si ebbe inoltre una sempre maggiore partecipazione popolare alla vita politica del paese soprattutto da parte delle aggregazioni studentesche e della popolazione urbana di Shanghai dove in quegli anni era sorto il partito comunista cinese.
Nel 1926 succeduto a Sun il più pragmatico Chiang Kay Shek, venne intrapresa con il sostegno sovietico la marcia verso il nord che doveva condurre il governo nazionalista alla riunificazione del paese. Nei primi anni vi era stata piena collaborazione con i comunisti, ma nel 1927 a causa delle tendenze estremistiche di quel partito, dei suoi non celati legami con Mosca, e forse anche per evitare la reazione delle nazioni occidentali timorose di violenti tumulti, Chiang represse con grande durezza le agitazioni operaie di Shanghai e iniziava una violenta lotta contro il partito comunista. Conseguenza della nuova politica fu il deciso peggioramento delle relazioni con l'Unione Sovietica, che aveva trattenuto fino allora con una certa dose di doppiezza buoni rapporti con i nazionalisti e i comunisti, e la rottura con l'ala del Kuomintang favorevole alla politica di amicizia con il PCC presieduta da Wang Ching Wei, che anni più tardi divenne il principale collaboratore degli invasori giapponesi.
Nel 1928 si ristabilì sulla Cina il più forte governo degli ultimi decenni (anche se in alcune province più remote sopravvivevano alcuni dei precedenti signori della guerra), gli interessi stranieri vennero ampiamente ridimensionati, e il paese si avviò verso un discreto sviluppo. Il successo del Kuomintang in Cina rappresentò un evento notevole e una delle prime affermazioni dei movimenti indipendentistici asiatici nei confronti dei colonizzatori europei, che aprì la strada a nuovi importanti sviluppi in tutto il continente asiatico.
Negli anni Trenta la Cina conobbe un periodo di relativa prosperità economica caratterizzata dalla eliminazione del sistema delle corporazioni economiche, e l'introduzione di una economia di mercato. Anche nel campo dell'istruzione si registrava un miglioramento attraverso l'innovazione dei programmi e un aumento del numero delle scuole, tuttavia la produzione agricola difficilmente riusciva a tenere il passo con l'aumento demografico della popolazione e l'industria disponeva di capitali insufficienti per il suo sviluppo. Nel 1930 si ebbe l'intervento dell'esercito sovietico in Manciuria per il ristabilimento dei diritti russi sulle ferrovie della regione, tuttavia la crisi fu di breve durata, e il paese conobbe un periodo di relativa pacificazione. Nel campo politico il defunto Sun Yat Sen divenne l'eroe e il simbolo della nazione, ma la struttura totalitaria dello stato non venne meno anche negli anni successivi, e misure repressive vennero adottate anche contro l'opposizione non comunista.
La dura sconfitta subita dai comunisti nel 1927 diede luogo ad una trasformazione radicale del PCC che divenne un organismo nuovo e profondamente diverso da quello degli anni precedenti. Molti dei simpatizzanti trovarono rifugio in Unione Sovietica dove il governo di Mosca impose uomini di propria fiducia al vertice dell'organizzazione, ma nello stesso periodo Mao, che aveva avuto un ruolo minimo negli avvenimenti precedenti, diede inizio a una nuova politica favorevole alla ricerca del consenso fra le vaste popolazioni delle campagne, diversamente dal periodo precedente durante il quale il partito si era basato sull'azione del proletariato urbano.
Nel 1932 il Giappone, anche a causa della sempre più massiccia presenza di generali e di esponenti militaristi al governo, iniziò su vasta scala l'opera di penetrazione in Cina. La Manciuria che i giapponesi chiamavano Manciukuò, sulla quale il governo di Tokyo deteneva già una notevole influenza, venne trasformata in una entità statale di fatto sottomessa all'impero nipponico, e progressivamente la presenza del Giappone si estese alle regioni centrali del paese. La politica giappone-se ebbe successo, l'Unione Sovietica venne tacitata con alcune offerte compensative, mentre gli Stati Uniti e le altre potenze europee colpite dalla crisi del '29 risultarono impotenti a intervenire a favore delle forze di Chiang Kay Shek, che risultavano del tutto insufficienti per opporre resistenza all'avanzata nipponica. Durante il lungo periodo dell'occupazione straniera la Cina si divise in tre parti: la vasta e popolosa regione controllata dall'esercito nipponico, il territorio della Cina libera ridotto al territorio di Chungking, e quello comunista di Yenan dove gli uomini di Mao trovarono sempre maggiore adesione fra i contadini e gli strati più poveri della popolazione. Secondo la descrizione fatta dal giornalista americano Edgar Snow (le notizie sul comunismo di Yenan non sono particolarmente numerose), il governo maoista si presentava ben disciplinato, instancabile nella sua opera di proselitismo e seppe attuare con moderazione la riforma agraria senza danneggiare eccessivamente i proprietari non latifondisti. Al contrario il governo nazionalista si mostrò incapace di combattere l'inflazione e i problemi economici ad essa connessa, alienandosi le simpatie di una parte della popolazione. Lo stesso generale Stilwell, inviato dal governo degli Stati Uniti per studiare la situazione del paese nel '45, concluse che il generale Chiang aveva male utilizzato molte delle sue risorse, e che a causa del dilagare della corruzione, le forze nazionaliste avevano perso la possibilità di condurre una efficace politica per la ricostruzione del paese.
Negli anni di Yenan il governo comunista lanciò il cosiddetto programma di rettifica contro “il soggettivismo, il settarismo, lo stile stereotipato del partito” con il quale si poneva l'accento su un tema che divenne ricorrente nel maoismo e che doveva portare al futuro contrasto con il mondo della cultura: la rinuncia dell'individuo alle sue aspirazioni e alla sua personalità per le esigenze del centro politico. Già a Yenan vennero messi in atto alcuni meccanismi di pressione psicologica fondati sulla pubblica umiliazione degli individui ritenuti responsabili di comportamenti scarsamente conformistici. Secondo lo storico John Fairbank, uno dei maggiori studiosi del fenomeno maoista, la dottrina della “linea di massa” si presentava fortemente ambigua e “mentre affermava la necessità di consultare le masse e di farle partecipare in qualche modo all'esercizio del governo, ribadiva anche la necessità del controllo e della direzione da parte del centro” .
La guerra fra il Giappone e la Cina, che si sovrappose successivamente alla seconda guerra mondiale, risultò particolarmente dura, si concluse con il dissanguamento economico dello stato cinese, e favorì notevolmente l'Unione Sovietica, nonostante che il governo di Mosca avesse contribuito pochissimo alla lunga guerra. In base agli accordi di Yalta, successivamente confermati dal trattato del 14 agosto 1945 fra il governo cinese e quello sovietico, la Russia vide confermate le sue posizioni in Mongolia, riacquisì le vecchie concessioni sulle ferrovie della Manciuria e sulle basi navali che si affacciano sul Mar Giallo, nonostante che da molto tempo la politica delle concessioni e delle zone d'influenza fosse tramontata.
Alla fine della guerra diversi fattori facevano ritenere che i maoisti non fossero in buoni rapporti con l'Unione Sovietica e quindi con lungimiranza il presidente americano Truman si sforzò di arrivare ad una mediazione fra KMT e PCC, opera che doveva risultare impossibile, nonostante la presenza di un forte movimento a favore della fine della guerra civile. Fallita la offensiva nazionalista nel 1948, i comunisti iniziarono ad espandersi nel paese incontrando comunque notevoli resistenze nel sud del paese dove anche nelle campagne esisteva una società più evoluta e condizioni economiche migliori per i contadini. Al termine della guerra civile durata quattro anni i comunisti prendevano il potere a Pechino mentre i nazionalisti trovavano rifugio nella piccola isola di Formosa.
I primi anni della Repubblica Popolare Cinese furono caratterizzati da un programma economico e politico relativamente moderato: l'industria venne solo parzialmente nazionalizzata, mentre il governo sia a livello centrale che periferico, data la carenza di quadri, comprendeva anche esponenti non comunisti. Particolare attenzione venne data alla lotta contro alcuni mali che venivano considerati gravi per la società (la prostituzione, il gioco d'azzardo, l'accattonaggio, il traffico dell'oppio), e a favore dell'emancipazione della donna attraverso una nuova legge sul matrimonio. In breve venne realizzato un regime fortemente accentrato con vasti poteri, superiori a quelli del precedente regime che aveva dovuto ricercare il consenso o un modus vivendi con molti dei precedenti capi locali.
Nelle campagne venne invece organizzato il terrore con l'eliminazione fisica di gran parte dei proprietari terrieri al termine di processi sommari dinanzi alle folle. Il numero delle vittime varia da un milione e mezzo a tre milioni secondo le fonti, una cifra notevolmente superiore a quella dei grandi proprietari latifondisti che in alcuni scritti precedenti di Mao ammontavano a non più dell'uno per cento della popolazione, circa 320.000 individui. Vittime delle persecuzioni furono anche gli appartenenti alle vecchie sette, gli “stranieri”, missionari cattolici e protestanti, la borghesia non sottomessa. Le persecuzioni proseguirono negli anni successivi e colpirono non solo gli esponenti legati alla struttura amministrativa del passato regime, ma anche gli esponenti comunisti giudicati non allineati. Le due campagne dei Tre Anti e dei Cinque Anti del 1951 contro “la corruzione, lo spreco e lo spirito burocratico” furono dirette soprattutto verso gli intellettuali e le categorie ritenute scarsamente controllabili. Secondo lo storico italiano Annibale Vasile l'obbiettivo dei rivoluzionari era non solo l'eliminazione dei “vecchi avversari del comunismo”, ma la soppressione di qualsiasi forma di dissenso aperto o larvato. L'organizzazione del partito risentì profondamente di tale situazione; gli organi rappresentativi privati di gran parte dei loro poteri, vennero convocati solo saltuariamente, e nel periodo compreso fra la proclamazione della repubblica popolare e la morte di Mao si tennero soltanto due congressi a livello nazionale. Un nuovo pesante giro di vite contro l'opposizione intellettuale si ebbe infine nel 1957 al termine della cosiddetta Campagna dei cento fiori che si concluse con l'invio di oltre mezzo milione di intellettuali al lavoro nei campi, relegati ai lavori più degradanti.
Negli anni successivi l'economia venne uniformata a quella sovietica con l'introduzione della pianificazione centralizzata e grandi investimenti nel settore dell'industria pesante. L'aiuto concesso dall'Unione Sovietica fu relativamente modesto, circa 300 milioni di dollari contro i 13 miliardi di dollari previsti dal Piano Marshall a favore dei paesi europei (con una popolazione nettamente inferiore a quella cinese), tuttavia in alcuni settori vennero riportati dei successi.
Una delle maggiori opere del comunismo in Cina di quel periodo fu la realizzazione di un sistema di dighe e di argini per imbrigliare il corso dei fiumi che nel corso dei secoli precedenti avevano devastato le pianure cinesi. I lavori vennero eseguiti con tecniche rudimentali, spesso spostando la terra con il ricorso alla sola forza umana, comunque la grande opera consentì lo sfruttamento di terre che prima non potevano essere adeguatamente coltivate e l'allontanamento della minaccia di calamità naturali per milioni di cinesi.
Le condizioni economiche dei contadini non avevano conosciuto significativi miglioramenti nel periodo della Cina nazionalista. In Cina era diffuso il latifondo, ma ancora di più il sistema dell'affitto delle terre che prevedeva la consegna di circa il 50-60% dei raccolti ai proprietari, condizioni non molto diverse da quelle della mezzadria diffusa nei paesi europei. Il problema delle campagne era tuttavia aggravato da fattori oggettivi, le ricorrenti inondazioni dei grandi fiumi, e l'eccessiva concentrazione della popolazione sulle terre coltivabili, superiore di una decina di volte a quella delle campagne russe. La riforma agraria del 1950 aveva provveduto ad assegnare le terre ai contadini, ma venne ben presto superata da altri provvedimenti anche per evitare i problemi dell'eccessivo frazionamento dei fondi. Le prime cooperative erano associazioni libere di contadini formate da non più di qualche decina o centinaio di famiglie, sostituite successivamente da cooperative agricole di grado superiore dove i contadini non avevano più la possibilità di vendere o affittare le terre. A dispetto delle numerose proclamazioni di egualitarismo il sistema economico cinese presentava delle sperequazioni notevoli. Secondo lo studioso Jean Deleyne la retribuzione di un agricoltore era circa la quarta parte di un operaio comune dell'industria (in parte compensata dal diverso costo della vita), il quale a sua volta percepiva un salario di tre volte inferiore a quello di un operaio qualificato.
I risultati di questa trasformazione economica furono modesti, la produzione agricola pro capite rimase bassa, e nel 1977 la Cina nonostante i notevoli sforzi degli anni precedenti si trovava nelle condizioni di importare cereali da Stati Uniti e da altri paesi del continente americano per oltre sei milioni di tonnellate.
Anche nel campo industriale i risultati non furono eccezionali; le statistiche come per l'Unione Sovietica nel periodo staliniano, parlavano di incrementi vertiginosi di alcune produzioni, come quella dell'acciaio e del carbone, ma le statistiche riflettevano solo l'aspetto quantitativo del problema, in realtà molti prodotti non risultavano di alcun interesse per il mercato e il tenore di vita rimase basso nelle città come nelle campagne. Secondo lo storico americano John Fairbank la politica maoista riguardo lo sviluppo industriale si poteva sintetizzare in una semplice asserzione “investire il più possibile e nel consumare il meno possibile”, il che significava tenere basso il tenore di vita delle popolazioni e realizzare una industria priva di mercato che costituiva più un peso che un beneficio per l'economia del paese. Molti degli ambiziosi obbiettivi previsti dalla pianificazione non vennero raggiunti come confermerebbero le statistiche contrastanti e le omissioni raccolte da Delayne. Come nell'Unione Sovietica si attribuiva grande importanza alle quantità fisiche di prodotti realizzati, trascurando il problema della utilità di ciò che si produceva e delle esigenze reali della società, oltre alla preparazione dei quadri dirigenti.
Le nostre conoscenze della Cina maoista sono molte frammentarie e diversi studiosi che hanno soggiornato in quel paese hanno riportato impressioni diverse. Per una corretta valutazione di queste dobbiamo infatti ricordare che le visite in Cina erano rigorosamente controllate dal governo, e come ha messo in luce lo scrittore italiano Goffredo Parise gli incontri con la popolazione si basavano su domande e risposte precedentemente stabilite dai dirigenti cinesi .
In Cina come negli anni dello stalinismo in Russia, si ebbe un grande ricorso al lavoro coatto; una legge del 1957 assimilava agli “oziosi” chiunque non disponeva dei mezzi di sussistenza, ovvero tutti coloro che “non si conformano alle disposizioni prese per il loro lavoro, e per la destinazione ad un altro compito... oppure che non migliorano a dispetto degli sforzi ripetuti che vengono fatti per rieducarli” tali individui andavano assoggettati ad “un regime a pieno tempo di formazione attraverso il lavoro” .
Nel campo dell'istruzione il tasso d'analfabetismo scese al 35% della popolazione, una media più bassa rispetto a quella degli altri paesi asiatici, ma non inferiore a quella di molti paesi dell'area sud-est come la Malesia, la Thailandia, le Filippine, la Birmania. Il problema maggiore era costituito dalle università, dove l'esigenza di creare giovani indottrinati prevaleva sulla preparazione professionale, che raggiungeva livelli incredibilmente bassi; secondo alcune testimonianze i testi su cui si preparavano le nuove generazioni di studiosi corrispondevano approssimativamente al livello dei libri delle scuole medie nei paesi europei . Le direttive di Mao emanate nell'estate del 1968 prevedevano infatti che fossero gli operai e i “contadini poveri” nelle campagne a gestire le scuole, con grave nocumento dell'insegnamento.
Il problema demografico ha costituito per la Cina forse il più grande problema economico; le campagne cinesi risultavano a tal punto sovraffollate che in anni precedenti alla instaurazione della repubblica popolare una commissione per l'agricoltura aveva ritenuto che il maggiore freno alla meccanizzazione del lavoro agricolo fosse causato dalla sovrabbondanza della manodopera. Il governo maoista ignorò il problema dell'eccessivo incremento demografico (ed anzi per un certo periodo di tempo venne ritenuto espressamente non dannoso) e solo nella prima metà degli anni Settanta venne decisa una politica di contenimento dell'aumento della popolazione attraverso il controllo delle nascite. Le idee di Mao sulla questione demografica e sulle campagne furono fra le cause del mancato sviluppo del paese. Nonostante l'eccessiva presenza di mano d'opera agricola il Grande Timoniere riteneva che “Tutti quelli che possiedono una qualche istruzione dovrebbero essere contenti di lavorare in campagna” e che occorreva favorire il trasferimento per periodi più o meno lunghi degli intellettuali nelle regioni agricole sebbene ovviamente sarebbe stato più redditizio impiegarli in settori più congeniali alla loro preparazione professionale.
Nel 1958 si ebbe uno dei più singolari esperimenti nel campo economico con la creazione delle Comuni Popolari che avrebbero dovuto consentire il “Grande balzo in avanti” e il superamento della Gran Bretagna nel campo della produzione siderurgica. Le nuove istituzioni risultavano costituite da circa 30-40.000 individui che dovevano garantire la produzione di beni e servizi in ogni settore. I componenti di questi raggruppamenti dovettero abbandonare i propri villaggi e in alcuni casi le stesse famiglie, e vennero avviati in nuove unità produttive con dormitori e refettori comuni. Anche le donne erano sottoposte alla nuova disciplina, ed anzi vennero creati asili nido collettivi per consentire il loro impiego nel lavoro dei campi. I nuovi lavoratori vennero inquadrati in squadre e brigate del lavoro per uno sfruttamento più razionale delle terre ma anche per garantire la produzione dell'acciaio attraverso piccoli altiforni. Nello stesso periodo venne lanciata contro ogni logica economica la campagna contro il passero distruttore di raccolti nella quale vennero impegnati un grandissimo numero di lavoratori; l'iniziativa si concluse con un danno ecologico gravissimo (la distruzione degli uccelli provocò il proliferare di insetti ed altri parassiti) e la conseguente perdita dei raccolti. Il fallimento fu duplice, l'incompetenza e l'inadeguatezza delle strutture siderurgiche portò alla realizzazione di prodotti inutilizzabili, mentre il minore impegno nel campo agricolo provocò una carestia che fra il '59 e il '61 provocò la morte di alcune decine di milioni di persone (intorno ai 20-30 secondo le fonti).
Il disastro provocato dal Balzo in avanti ebbe conseguenze importanti nel campo politico, Mao massimo sostenitore dell'iniziativa dovette rinunciare alla carica di presidente della repubblica (mantenendo comunque la più importante carica di segretario), e il paese si avviò verso posizioni più moderate. La Cina ebbe modo di riprendersi, ma anni più tardi si arrivò al conflitto violento fra i maoisti e i sostenitori di Liu Shao Chi che ritenevano si dovesse lasciare un certo grado di autonomia del mondo economico dal controllo politico. Dopo aver ottenuto l'allontanamento di Peng Te Huai, che come ministro della difesa aveva sostenuto la necessità di misure per la modernizzazione dell'esercito, nel 1965 i maoisti iniziarono ad attaccare il sindaco di Pechino Peng Zhen e un gruppo di intellettuali ritenuti vicini al presidente della repubblica, dando inizio ad un grande movimento di massa passato alla storia come la Rivoluzione Culturale.
La Rivoluzione Culturale, o per meglio dire la “rivoluzione totale per l'instaurazione della cultura della classe lavoratrice”, ha costituito una grande tappa del maoismo e ha suscitato grandi passioni anche nella gioventù europea degli anni Settanta che riteneva il fenomeno un interessante tentativo di superare il comunismo “burocratico” sovietico e dare spazio alla “autorganizzazione” delle masse. Il movimento comunista degli anni '66-'67 fu invece un fenomeno scarsamente spontaneo, gestito in larga parte dall'esercito, che nell'ultimo periodo divenne il vero protagonista della scena politica.
Egualitarismo e sottomissione dell'individuo alla collettività e allo stato, oltre che il disprezzo della cultura furono le principali caratteristiche della rivoluzione culturale. Uno degli obbiettivi del nuovo movimento era la lotta ai burocrati, ma si deve ricordare che Peng Te Huai e Liu Shao Chi, principali vittime degli estremisti, non appartenevano a tale categoria ma furono esponenti di spicco, insieme a Deng Tsiao Ping, della rivoluzione negli anni precedenti alla istituzione della repubblica popolare. Secondo Lin Piao, giustamente considerato il massimo esponente del movimento politico di quegli anni, “La grande rivoluzione culturale proletaria mira ad eliminare l'ideologia borghese, a radicare l'ideologia proletaria, a rimodellare l'anima del popolo, ad estirpare le radici del revisionismo, a consolidare e sviluppare il socialismo” , l'obbiettivo reale dei nuovi rivoluzionari era sostanzialmente un appiattimento della libertà e della coscienza umana, già fortemente limitata dalle iniziative degli anni precedenti, finalizzata alla creazione di una società disciplinata e conformista. Il regime maoista si impegnava notevolmente per presentare una immagine accettabile della sua politica, ma con successi limitati; l'ex cancelliere tedesco Helmut Schmidt al termine della sua visita in Cina concluse che la vita sociale e politica cinese risultava essenzialmente anonima e che “Molte altre cose [oltre alle rappre-sentazioni teatrali] non mi sono piaciute: i rapporti interumani fra le diecimila persone che vivevano nella comune popolare Stella Rossa, gli altoparlanti che per tutto il giorno frastornavano con i loro slogan politici i passanti nelle vie principali di Urumqi, l'uniformità dell'abbigliamento; e mi ha letteralmente scandalizzato la sfrontatezza con cui l'individualità veniva soffocata” .
Vittime principali della grande mobilitazione furono nuovamente gli intellettuali; scuole, università, centri culturali e librerie vennero chiuse e gran parte del personale docente e degli studenti vennero inviati al lavoro agricolo nelle province più remote. Secondo la testimonianza del diplomatico francese Alain Peyrefitte i corsi di indottrinamento e le discussioni sui luoghi di lavoro che dovevano sostituire l'insegnamento “neutro” costituirono la ripetizione meccanica e acritica di slogan politici e la condanna dei comportamenti ritenuti “asociali” o in contrasto con le direttive superiori. Per i capi della nuova rivoluzione le discipline scientifiche e le capacità professionali dell'individuo non avevano alcuna importanza né dal punto di vista speculativo né da quello pratico o economico; così secondo Radio Pechino l'agricoltura necessitava più di uomini indottrinati che di esperti, “I raccolti abbondanti” sosteneva l’emittente “non vengono né dal cielo né dalla terra, ma dal pensiero di Mao Tse Tung” . Tale concezione ebbe effetti fortemente negativi sull'economia del paese, e favorì una serie di altri fenomeni come la distruzione del patrimonio storico-artistico e la chiusura totale verso qualsiasi influsso culturale straniero.
Una descrizione dettagliata della rivoluzione culturale, dell'attività del movimento delle Guardie Rosse, del loro puritanesimo e della loro xenofobia, è stata lasciata dal giornalista inglese Paul Johnson: “Le bande di scalmanati che infestavano le strade afferravano le ragazze con i capelli lunghi, avvolti in trecce, e li tagliavano; ai ragazzi venivano strappati i pantaloni di foggia straniera. Ai parrucchieri venne intimato di non tagliare i capelli a coda d'anatra, ai ristoranti di semplificare i menù, ai negozi di non vendere più cosmetici, vestiti con gonne a spacco, occhiali da sole, pellicce ed altri articoli di lusso. Le insegne al neon vennero spaccate. Nelle strade bruciavano grandi falò di merce proibite... Le Guardie Rosse fecero chiudere sale da tè, caffè, teatri indipendenti e tutti i ristoranti privati; interruppero l'attività di suonatori ambulanti, acrobati e attori girovaghi; vietarono matrimoni e funerali, le passeggiate mano nella mano, e il gioco degli aquiloni”. Tale situazione è confermata in un comunicato del Quartiere Generale delle Guardie Rosse, in base al quale venivano proibiti esplicitamente gli articoli da regalo, il commercio di fiori e pesci rossi, le merci straniere, l'affitto di libri, l'uso delle bare, e gli studi medici privati; venne combattuta in altri termini “la decadenza e l'oscenità che avvelenano e corrompono le menti” come affermò Chiang Ching, la moglie di Mao, che per un certo periodo di tempo volle dirigere la vita culturale del paese. Le testimonianze di efferatezze compiute in quel periodo sono numerose; molti accusati erano costretti a percorrere le strade del paese con cartelli sui quali era scritto frasi tipo “elemento controrivoluzionario”, “rifiuto umano”, “figlio di cane”, venivano percossi e in alcuni casi ammazzati, oppure inviati al lavoro forzato. Secondo l'agenzia France Press, 400.000 furono le persone uccise deliberatamente o in seguito ai maltrattamenti subiti.
Molte delle vicende politiche del paese e della dirigenza politica risentivano delle ambizioni personali di Mao come messo in luce recentemente dalla grande biografia scritta dal medico personale del Grande Timoniere, e una conferma la si può trovare nella involuzione degli scritti di Mao che se nel periodo di Yenan insisteva sulla umiltà del militante comunista e sul suo legame con il resto della popolazione, negli scritti successivi prevale il senso di subordinazione dell'individuo alla collettività e allo stato. Come molte altre dittature del nostro secolo le restrizioni politiche non colpivano solo la società ma anche lo stesso partito al potere che cessò nel corso degli anni di essere luogo di dibattito politico.
Verso l'autunno del '67 il movimento delle Guardie Rosse si divise in diverse formazioni, portando il paese sull'orlo del caos e della guerra civile; la dirigenza politica ritenne allora di utilizzare le forze armate per riportare l'ordine nel paese e lo stesso Mao giustifico l'azione militare ricordando che “I soldati non sono altro che operai e contadini che indossano l'uniforme”. Lin Piao, ritenuto il numero due del regime, venne accusato di complotto e trovato morto in un misterioso incidente aereo, mentre molti dei giovani militanti che non intendevano ubbidire alle nuove direttive vennero inviati, come in precedenza le loro vittime, al lavoro agricolo nelle province interne del paese. Progressivamente l'ordine venne ristabilito nel paese.
Nel campo della politica estera la Cina di Mao si fece promotrice della Conferenza di Bandung con la quale i paesi afroasiatici di nuova formazione ribadivano alcuni importanti principi in materia di parità fra le nazioni, relazioni pacifiche, lotta al colonialismo, tuttavia la politica di Pechino fu tutt'altro che improntata a principi di pacifica convivenza: Corea, India, Bangladesh, Birmania, Vietnam come le regioni semiautonome del Tibet e del Turkestan fecero in vario modo le spese della politica di potenza cinese.
Nel 1962 dopo aver represso con energia la rivolta del Tibet, Mao rivolse la sua attenzione verso l'India nonostante la politica moderata da essa sostenuta riguardo alla questione tibetana. La Cina riteneva la linea di confine che separava l'ex regno buddista dal subcontinente indiano come iniqua, e dopo una lunga serie di incidenti di confine nell'ottobre di quell'anno, le truppe cinesi attaccavano in massa le forze indiane riportando notevoli successi. La guerra, che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime a livello internazionale, ebbe termine con l'intervento di Kennedy a favore della Repubblica Indiana, e mise in luce l'ambiguità dei propositi maoisti.
Il rifiuto sovietico di fornire alla Cina gli strumenti per la produzione della bomba atomica e il mancato sostegno alle rivendicazioni nei confronti dell'India, portarono alla rottura fra l'Unione Sovietica e la Cina, nonostante che i numerosi incontri fra i massimi rappresentanti delle due potenze avessero portato a dei nuovi rapporti (rinuncia alle basi navali di Port Arthur e Dairen e scioglimento delle società cino-sovietiche), che avevano riconosciuto una maggiore autonomia di Pechino nei confronti di Mosca. La polemica da ideologica, difesa del culto della personalità, attacco al revisionismo e alla politica di coesistenza pacifica di Kruscev, divenne negli anni successivi una disputa su questioni territoriali che provocò numerosi scontri di confine e per un certo periodo, la minaccia di un conflitto aperto fra le due nazioni. I comunisti cinesi arrivarono a difendere non solo il principio del culto della personalità, ma anche la stessa figura di Stalin che nel 1950 aveva imposto al paese qualcosa di simile ai trattati ineguali dei decenni precedenti. Il fatto è meno paradossale di quello che potrebbe sembrare, Kruscev e il nuovo Politburo stavano cedendo sul principio della subordinazione della base rispetto al centro, e sul controllo della società da parte del potere politico, che per Mao costituiva qualcosa di inammissibile.
La controversia cino sovietica si estese dal campo politico a quello culturale, i dirigenti cinesi contestavano la purezza leninista o marxista leninista dei compagni russi, e la disputa suscitò un ampio dibattito culturale anche in Occidente fra ruolo del partito e delle masse, fra cultura europea e quella emergente afroasiatica, fra rapporto città e campagna, spesso confondendo l'uso delle masse analfabete contro esponenti politici emergenti come forme di democrazia diretta dove tutto doveva essere messo in discussione.
Nella Conferenza dei partiti comunisti tenuta a Mosca nel 1957, Mao si espresse sullo scontro con l'imperialismo e la coesistenza pacifica; non si doveva temere la “tigre di carta”, secondo l'esponente cinese “in caso di guerra atomica... sarebbe stata annientata la metà della popolazione del globo, ma l'altra metà sarebbe sopravvissuta. In tal caso l'imperialismo sarebbe stato liquidato ed il mondo sarebbe diventato socialista” . I principi maoisti riguardo alla lotta fra le nazioni deboli e oppresse contro l'imperialismo e l'accerchiamento delle città (i paesi progrediti) da parte delle campagne (i paesi poveri), non hanno impedito le pessime relazioni con i paesi asiatici vicini, una attività ambigua nei confronti di un paese alleato come l'Indonesia, e la approvazione dell'intervento sovietico in Ungheria nel 1956.
Nel 1976 la morte a pochi mesi di distanza di Mao Tze Tung e Chu En Lai provocò un grande rivolgimento in Cina. La cosiddetta Banda dei Quattro capeggiata dalla moglie di Mao favorevole alle istanze più estremiste venne sconfitta, e progressivamente si affermò come figura emergente Deng Tsiao Ping che negli anni della rivoluzione culturale era stato emarginato da ogni incarico politico.
Il nuovo governo ha introdotto notevoli novità nel campo economico. Nel settore agricolo pur mantenendo il controllo dello stato sulla produzione agro-alimentare ha stabilito maggiori incentivi alle singole famiglie, e ha messo da parte i grandi obbiettivi nel settore cerealicolo tipici della politica maoista. La coltivazione dei cereali infatti, richiedeva scarsa manodopera e abbondanza di terre, situazione presente nei paesi del Nuovo Mondo (Australia, Argentina, Stati Unti, ecc.) ma diversissima da quella cinese. Pertanto il nuovo governo ha abbandonato la politica degli anni precedenti e si è orientato verso produzioni più adatte alle sovraffollate campagne cinesi.
Nel campo industriale le innovazioni introdotte da Deng furono anche superiori, abbandonando la politica di autarchia impostata nel precedente periodo. Venne decisa la chiusura delle aziende improduttive, la riduzione degli investimenti nell’industria pesante e incoraggiata la produzione di beni di consumo da destinare alle famiglie. Sebbene il settore statale rimase predominante, si curò la preparazione tecnica e l'incentivazione del personale. La maggiore autonomia dei dirigenti di imprese statali ha però favorito il diffondersi della corruzione già presente nel precedente regime ma oggi più apertamente tollerata, fenomeno che ha creato vivo malcontento nel paese specie all'interno della popolazione studentesca. Le esigenze del maggiore dinamismo economico ha favorito la formazione di un più solido bagaglio giuridico e tecnico, e ciò ha favorito il risorgere di quella borghesia colta che per decenni era stata duramente confinata ai margini della società. Nel campo politico le novità sono però poche, non esistono né libertà né garanzie a tutela dei diritti dell'individuo, soggetto ancora a numerosi controlli. Per protestare contro tale situazione nel 1989 si ebbe la gigantesca protesta studentesca in piazza Tien Ammen conclusa tragicamente con l'uccisione di circa duemila manifestanti e innumerevoli arresti. Il governo ha dimostrato una notevole energia, e negli anni successivi, diversamente da quanto alcuni avevano previsto, non ha dato segni di cedimento.
La Corea del nord con la sua chiusura verso il mondo esterno, il suo ferreo totalitarismo e le manie di grandezza del suo leader che si è fatto erigere monumenti e templi in suo onore, conferma la realtà dei regimi comunisti in Asia che hanno avuto come obbiettivo fondamentale non lo sviluppo economico o la democrazia, ma il controllo capillare della collettività, la distruzione del mondo della cultura, la rigida chiusura verso il mondo esterno.
Il comunismo nordcoreano presenta molti caratteri in comune con quello cinese. Nel 1946 venne lanciato un movimento di rivoluzione ideologica che ricordava il movimento di rettifica lanciato da Mao a Yenan. La campagna aveva per oggetto la lotta all'egoismo individuale, la pigrizia, la corruzione, il burocraticismo, la mancanza di senso di responsabilità, il servilismo nel lavoro. Per Kim Il Sung occorreva rinforzare il partito, “rinsaldare i suoi legami con le masse popolari, lottare ostinatamente contro lo stile di lavoro burocratico e formalista che allontana le masse, e impiantare uno stile di lavoro rivoluzionario” . Secondo il complesso linguaggio comunista si intendeva con questi termini combattere il senso di autonomia dei quadri intermedi i quali dovevano adeguarsi alle direttive delle masse la cui volontà era rappresentata ovviamente dal potere centrale.
Anche nel campo economico la politica del regime coreano appariva simile al modello cinese; venne data la priorità allo sviluppo dell'industria pesante e al settore siderurgico rispetto all'agricoltura e alla produzione dei beni di consumo, privilegiando in tal modo la politica di potenza della nazione sulle esigenze della popolazione. A integrazione del dirigismo economico già attuato nel periodo precedente, nel 1962 il governo lanciò il cosiddetto sistema di lavoro di Taean in base al quale venne ridimensionato il ruolo dei dirigenti e dei tecnici di azienda a favore del comitato politico di fabbrica, fattore che produsse un ulteriore peggioramento dell'economia. Per coloro che non garantivano risultati adeguati, o che non si conformavano alle direttive superiori, il regime aveva previsto infine il ricorso al lavoro forzato all'interno dei campi di rieducazione, alcuni dei quali in territorio sovietico come documentato di recente.
Le eccessive spese militari e le scelte di politica economica hanno provocato il collasso economico dello stato, sebbene anche in anni recenti per la stampa ufficiale la Corea del nord fosse “allo zenith della prosperità economica”. Nel corso degli anni passati una grande massa di profughi ha abbandonato la Corea del nord; nonostante la maggiore ricchezze di risorse naturali rispetto al sud, lo stato comunista si è progressivamente impoverito, e si presenta oggi con un reddito pro capite di almeno quattro volte inferiore a quello della vicina repubblica di Seul.
Nel campo della politica estera la Corea del nord sebbene sembrasse appoggiare la causa cinese contro il “revisionismo” di Mosca, nel corso degli anni della rivoluzione culturale non risparmiò critiche al dogmatismo cinese di cui temeva la eccessiva invadenza, e si isolò progressivamente dalla comunità mondiale degli stati.
La vicina Corea del sud, paese inserito nel mondo occidentale, ha conosciuto un regime militare, che se ha consentito lo sviluppo economico del paese, che costituisce oggi una delle maggiori potenze industriali dell'Asia, ha prodotto malcontento da parte dei movimenti studenteschi e solo in anni successivi la giunta militare ha lasciato il passo a governi eletti democraticamente.
il Sud-Est asiatico in fiamme
Il periodo fra le due guerre fu un periodo importante per la regione, dove all’opposizione contro il dominio europeo costituito da gruppi etnici o religiosi, si sostituirono partiti di tipo moderno basati su organizzazioni di massa e programmi politici democratici. Tale situazione favorì il sorgere negli anni compresi fra il '46 e il '48 nell'Indocina francese, la Birmania, l'Indonesia, la Malesia e le Filippine di una serie di rivolte e di guerre dalle quali solo la Thailandia incredibilmente riuscì a non essere coinvolta. Il processo di decolonizzazione ebbe comunque in questa regione caratteristiche profondamente diverse; in Birmania e nelle Filippine l'indipendenza avvenne in forma pacifica e consensuale attraverso negoziati, mentre in Indonesia e soprattutto in Vietnam, si ebbero contrasti gravissimi con le potenze colonizzatrici che ebbero notevoli conseguenze sul futuro di quella parte del continente.
Tutta l'area del sud-est asiatico venne investita nel corso della seconda guerra mondiale dall'occupazione giapponese che diede vita ad una forma di dominio sulle popolazioni locali notevolmente più dura di quella imposta dagli europei negli anni precedenti. Tuttavia nel '44-'45 prima di ritirarsi dai territori occupati i giapponesi ottennero la collaborazione di numerosi esponenti locali come Roxas, Sukarno, U Nu, Aung San, Bao Dai, che negli anni successivi divennero leader di primo piano della scena politica internazionale. La sconfitta degli europei segnò in maniera determinante il futuro della regione, e terminata la guerra le potenze coloniali incontrarono gravi difficoltà nel restaurare la propria autorità su quelle regioni. Sorsero così il movimento del Vietminh di tendenze nazionaliste ma diretto da esponenti comunisti, il movimento degli Huk contrario al potere dei latifondisti nelle Filippine, il Partito Nazionale Indonesiano diretto da Sukarno, l'Esercito Popolare Malese di tendenze comuniste in Malesia, che misero in difficoltà francesi, olandesi e britannici, mentre gli americani, che avevano concesso l'indipendenza alle Filippine nel '46, lasciarono che il nuovo governo si impegnasse nella lotta alla guerriglia.
Protagonista di numerosi movimenti di guerriglia furono i contadini più poveri che vivevano in condizioni di grave indigenza. Come in Cina, non era molto diffuso, ad eccezione delle Filippine, il latifondo, e i contratti agrari che legavano i proprietari terrieri ai contadini fittavoli non erano particolarmente gravosi, tuttavia i lavoratori si trovavano esposti per svolgere il proprio lavoro agli interessi usurari praticati dallo stesso proprietario o da uomini d'affari cinesi, i quali pretendevano una parte cospicua del successivo raccolto. Il problema principale era costituito comunque dalla eccessiva concentrazione della popolazione - particolarmente a Giava e nelle Filippine - rispetto alle terre coltivabili, che come in Cina impediva lo sviluppo della regione.
Uno sviluppo molto diverso conobbero i paesi “conservatori”, Malaysia, Thailandia, Filippine, rispetto a quelli “rivoluzionari”, Indonesia, Birmania, Vietnam, Laos e Cambogia. Quest'ultimi vennero tormentati da instabilità politica e contrasti etnici, mentre la politica economica chiusa e fortemente socialista ha aggravato le condizioni economiche dei rispettivi paesi. Come negli altri paesi asiatici non esisteva una classe politica preparata e responsabile, mentre la popolazione non era in grado di condizionare le scelte politiche ed economiche dei rispettivi governi. Nonostante la proclamata politica socialista, tutta l'economia era finalizzata ad una politica di potenza, mentre nessun tentativo venne realizzato per la diffusione del benessere o il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori.
Il Vietnam fu uno dei paesi dove maggiori furono le spinte per l'indipendenza. L'amministrazione francese non era amata dalla popolazione locale, e non aveva contribuito al progresso economico del paese. Nel periodo fra le due guerre la produzione di riso era notevolmente aumentata, ma buona parte di questo prodotto era destinato al mercato estero con scarso beneficio per la popolazione. La rivolta contro il potere degli europei si espresse inizialmente con una serie di atti terroristici compiuti da piccoli gruppi politici, e attraverso le agitazioni di una società segreta, il movimento caodaista, che univa in maniera singolare richieste politiche e religiose, riprendendo elementi di varie culture, da quella illuminista a quella esoterica. Successivamente sorse il partito di Ho Chi Minh sostenitore della costituzione di un movimento rivoluzionario di massa e dell'unione delle richieste indipendentistiche con quelle di una maggiore giustizia sociale, movimento che diede vita alla grande rivolta scoppiata negli anni 1930-1931 nelle regioni centrosettentrionali del paese; l'azione rivoluzionaria venne repressa con molta energia dalle autorità francesi, ma i gruppi rivoluzionari continuarono ad agire anche negli anni successivi mantenendo il paese in uno stato di costante tensione.
Dopo la fine del conflitto mondiale la Francia riconobbe l'indipendenza di Laos, Cambogia e Vietnam come paesi membri dell'Unione francese, ma in seguito alla questione della Cocincina si arrivò alla rottura fra il governo francese e il Vietminh. I numerosi governi di centro destra e centro sinistra che si alternarono in Francia furono totalmente incapaci di gestire la situazione, e fino al '49, anno in cui i francesi offrirono maggiori garanzie di indipendenza ai tre paesi indocinesi, non ottennero l'appoggio delle altre potenze occidentali.
L'ostinazione francese in Vietnam ebbe come maggiore risultato la perdita di credibilità delle forze nazionaliste moderate, e l'ascesa del partito comunista diretto da Ho Chi Minh, il cui programma politico conteneva una serie di obbiettivi “democratico-borghesi” e più strettamente rivoluzionari, talvolta difficilmente distinguibili; così si parlava di riforma agraria a favore dei contadini, nazionalizzazione delle industrie e delle proprietà straniere, imposta progressiva sui redditi, parità di trattamento fra uomini e donne, giornata lavorativa di otto ore e, ovviamente di piena indipendenza del paese, ma anche di governo ed esercito di “operai e contadini”, e di stretti legami con il mondo comunista e l'Unione Sovietica. Negli anni successivi i comunisti si misero alla testa del movimento del Vietminh, e nel '45 terminata la guerra proclamarono la repubblica, riconosciuta ma poco dopo osteggiata dai francesi. Si ebbero vari tentativi per trovare una soluzione al conflitto, ma ciò non impedì il precipitare del paese in un lungo conflitto che costò la vita di un numero elevato di persone.
Conclusa la “sporca guerra” che aveva visto un impegno gravemente dispendioso dei francesi, ma anche la violazione della sovranità degli stati laotiano e cambogiano da parte delle truppe Vietminh, si arrivò agli Accordi di Ginevra del 1954 che prevedevano la temporanea creazione di due stati, uno sotto il governo dei nazionalisti comunisti al nord e uno sotto l'autorità dell'imperatore Bao Dai e del suo energico primo ministro Ngo Dinh Diem al sud. La parte di accordi sulla riunificazione attraverso libere elezioni rimasero lettera morta, i due stati si avviarono su strade diverse, e alcuni anni dopo ripresero i combattimenti.
La pace non portò il benessere nella regione. Il Vietnam del nord conobbe al momento del ritiro delle truppe francesi dal paese la fuga di circa un milione di abitanti - in prevalenza cattolici - verso il sud e negli anni successivi una riforma agraria contraria agli interessi dei piccoli proprietari, che provocò una sollevazione contadina repressa dal governo con migliaia di morti e l'internamento nei campi di concentramento anche di numerosi ex esponenti Vietminh. Nel 1960 venne emanata una nuova costituzione che prevedeva il godimento dei diritti dell'individuo subordinati “agli interessi dello stato e del popolo”, venne decisa la costituzione di “comitati popolari” per la capillare organizzazione della società, e nel campo dell'organizzazione del lavoro un sistema simile al modello cinese, nonostante che i rapporti con Pechino fossero caratterizzati da una certa diffidenza e rivalità. Attraverso crediti concessi dall'Unione Sovietica e la Cina, il Vietnam del nord poté dare attuazione ad un programma di industrializzazione, più moderato di quello di altri paesi comunisti, che tuttavia non migliorò le condizioni economiche del paese, e in diversi campi il governo dovette ricorrere al lavoro coatto. Nel sud il governo del cattolico Diem incontrò l'opposizione dei buddisti che vedevano i loro diritti limitati, anche a causa dell'arrivo della grande ondata di profughi. L'introduzione di riforme politiche e sociali, nonostante le pressioni americane, vennero concesse solo parzialmente negli anni successivi, dopo la tragica caduta di Diem.
Nel 1960 iniziarono a organizzarsi nel Vietnam del sud gruppi di guerriglieri appoggiati da Hanoi che diedero vita ad una campagna di attacchi contro capi di villaggio ritenuti filogovernativi e funzionari di stato. Le autorità sud vietnamite con il sostegno americano attuarono pertanto un trasferimento delle popolazioni rurali in zone ritenute più sicure come avevano fatto negli anni precedenti le autorità malesiane per sconfiggere la guerriglia nel loro paese. Il piano non ebbe successo e creò un certo malcontento nel paese; contemporaneamente alcuni attacchi contro unità terrestri e navali statunitensi nel '64 diedero il via ai bombardamenti americani sul Vietnam del nord coinvolgendo sempre più l'amministrazione americana in un conflitto con conseguenze superiori a quelle che il governo di Washington aveva previsto.
Nel '68 la guerra raggiunse il culmine; gli americani avevano portato a mezzo milione gli effettivi del proprio contingente nello stato asiatico, impegnandosi in un gravoso sforzo umano e finanziario senza ottenere risultati adeguati. In quello stesso anno Vietcong e unità regolari nord vietnamite si impegnarono in due grandi offensive contro le grandi città (l'offensiva del Thet) e la base militare americana di Khe San. Entrambe le azioni non ebbero successo, e misero in luce che i Vietcong non godevano di quel largo seguito fra la popolazione che alcuni ritenevano.
Sebbene i comunisti avessero subito enormi perdite umane, le due offensive suscitarono emozione in America, dando inizio a quel vasto movimento d'opposizione alla guerra che doveva mettere in crisi il governo americano e portare alla progressiva riduzione del contingente americano. Negli anni successivi comunque il movimento Vietcong si ridusse notevolmente, e per un certo periodo sembrò che l'esercito sud vietnamita avesse ripreso l'iniziativa. Nel '73 gli americani si ritirarono definitivamente dal conflitto, ma due anni dopo l'attacco nordvietnamita pose fine definitivamente al tragico conflitto. La spettacolare vittoria nord vietnamita consentì la creazione successivamente di una sua vasta zona d'influenza nella regione.
Si è molto discusso se le formazioni guerrigliere che operavano nel sud fossero un fenomeno spontaneo e locale, ovvero se si trattasse di gruppi creati dal governo di Hanoi, tuttavia nel '75 quando si concluse definitivamente la guerra fra i due Vietnam le forze Vietcong si volatilizzarono, e il sud conobbe gli effetti di una dura guerra di conquista. Nelle sue recenti memorie Mc Namara, ex segretario alla difesa negli anni Sessanta individuava nella “Illusione che la libertà e la democrazia fossero le maggiori aspirazioni dei vietnamiti” uno dei maggiori errori della politica americana in Vietnam.
Lo stato cambogiano nonostante il suo modesto interesse geopolitico nel grande continente asiatico ha avuto anch'esso una vita politica travagliata. Ottenuta l'indipendenza piena attraverso accordi successivi fra il '46 e il '54, nel 1955 il re Sihanouk con un gesto singolare abdicò a favore del padre e costituì una formazione politica nazionalista di sinistra, la Comunità socialista del popolo, che ottenne un vasto consenso nel paese. Negli anni successivi si deteriorarono i rapporti con gli Stati Uniti, e il paese si legò maggiormente con la Cina Popolare, ma anche con la Francia gollista con le quali stabilì proficui rapporti di collaborazione.
Nell'autunno del 1969 Sihanouk consentì l'ingresso delle truppe nord vietnamite nel paese nonostante l'opposizione del suo stesso governo; non molto tempo dopo venne quindi rovesciato dal generale Lon Nol e costretto a rifugiarsi in Cina. Nonostante il consistente sostegno americano il nuovo governo non riuscì a porre freno alla guerriglia, e nel '75 le formazioni comuniste presero il potere, senza comunque reintegrare Sihanouk alla guida del paese.
Il piccolo e scarsamente popolato regno del Laos fu anch'esso coinvolto nella guerra del Vietnam. Alla fine degli anni Cinquanta la vita del paese venne turbata da una complessa guerra civile fra il Pathet Lao diretto dal principe Souphanuvong, i gruppi politici neutralisti che facevano capo al fratellastro Souvanna Phuma, e gruppi filoamericani guidati da personalità diverse. Lo scontro fu aggravato dall'intervento dell'esercito nord vietnamita che a più riprese si schierò a favore dei combattenti comunisti del Pathet Lao. Nel '62 la Conferenza internazionale di Ginevra formata da americani, sovietici e britannici favorì un accordo fra le parti al fine di arrivare alla pacificazione e neutralizzazione del piccolo stato, ma il tentativo non ebbe successo e pochi mesi dopo ripresero i combattimenti fra le diverse fazioni.
Come la Francia, anche l'Olanda tentò di ritardare il distacco delle colonie in Asia attraverso l'uso della forza e il sostegno alle forze locali che si opponevano ai nuovi regimi in Oriente, ma non disponendo del sostegno degli altri paesi occidentali e degli Stati Uniti, che vedevano con favore la nascita di uno stato indonesiano non comunista, dovette rinunciare a tale proposito. Negli anni dell'occupazione giapponese era sorto a Giava e Sumatra infatti un governo indipendente diretto dal leader nazionalista Sukarno che nel 1948 si oppose ad una rivolta comunista diretta da esponenti filosovietici e impedì il ritorno dell'amministrazione olandese nell'arcipelago. Nel '49 sotto la pressione di una parte dell'opinione pubblica nazionale ed internazionale, e di un pronunciamento dell'ONU avvenuto su richiesta di una conferenza di paesi asiatici promossa da Nehru, venne accordata la piena indipendenza al popoloso arcipelago, anche se una larga parte delle isole minori non accettava di buon grado il predominio di Giava sulla vasta federazione di stati.
Il programma politico del Partito Nazionale Indonesiano fondato nel 1927 da Sukarno si rifaceva ad una sorta di socialismo eclettico. Nel Pantja Sila, il programma politico lanciato nel 1945 dal grande leader nazionalista, venne espresso il proposito di costituire uno stato unitario “dall'estrema punta settentrionale di Sumatra alla Papuasia” e l'idea di “fare di tutte le nazioni una famiglia”, anche se negli anni successivi lo stato indonesiano instaurò pessimi rapporti con la maggior parte dei paesi vicini. Secondo l'autore del programma “la democrazia che noi cerchiamo non è quella occidentale... ma un mondo conforme ai principi di Ratu Adil [dio della giustizia]” e prevedeva nel campo sociale la creazione di “uno stato di tutti per tutti, uno per tutti, tutti per uno e non uno stato per un gruppo, per i ricchi”. Venne ribadita l'importanza della fede, evitando comunque implicitamente gli eccessi, e ammettendo la tolleranza nei confronti degli altri culti. I cinque principi esposti: nazionalismo, internazionalismo, democrazia, giustizia sociale e fede in dio vennero sintetizzati in uno solo, gotong rojong (= mutua cooperazione), che fu alla base del futuro stato socialista. Il partito di Sukarno costituiva un gruppo politico moderno, che si rivolgeva all'intera nazione e non alle singole etnie (l'idea di una nazione indonesiana sorse in quegli anni), ma a fianco di esso vi erano altri partiti da quello islamico a quello comunista che nel 1926 aveva dato vita ad una cruenta rivolta. Vicino alle posizioni di Sukarno, Mohamed Hatta diede vita ad una organizzazione studentesca socialista contraria all'uso del terrorismo e favorevole alla modernizzazione del paese e della sua classe dirigente. Per molti anni fra i due leader nazionalisti vi fu piena collaborazione ma alla fine degli anni Cinquanta di fronte all'involuzione autoritaria del paese, Hatta prese rigorosamente le distanze dal vecchio amico di lotta, senza comunque poter impedire il peggioramento della situazione.
L'anno successivo alla proclamazione dello stato indonesiano venne rivista la forma costituzionale con l'abolizione del federalismo; non molto tempo dopo ripresero quindi a Sumatra, nella cristiana Celebes, e nelle altre isole minori, le ribellioni verso il potere centrale. Il fenomeno dell'incremento demografico, particolarmente grave in diverse isole dell'arcipelago, nell'isola di Giava raggiungeva una delle situazioni più drammatiche a livello mondiale, problema che il governo lasciò senza soluzione. Il programma economico lanciato da Sukarno si rivelò altrettanto infruttuoso. Vennero imposte pesanti limitazioni al commercio con l'estero che ebbero gravi conseguenze anche nel campo della produzione agricola; la produzione di caffè, tabacco, zucchero e chinino crollarono a livelli inferiori a quelli del periodo anteguerra, ma anche la produzione del riso, elemento base dell'economia del paese, stentava ad adeguarsi a quello dell'aumento della popolazione. La riforma agraria, lo sviluppo del sistema delle cooperative in agricoltura, e le nazionalizzazioni nel campo dell'industria, non contribuirono a risanare l'economia del paese, e nel '53 si ebbero disordini nel paese a seguito di tale politica. La sottrazione di capitali agli investimenti produttivi impediva lo sfruttamento delle abbondanti risorse naturali del paese, e la produzione dello stagno, di cui lo stato indonesiano era stato uno dei massimi produttori mondiali, si dimezzò nel corso di un decennio. L'inflazione, la caduta del potere d’acquisto dei salari, e il deficit dello stato infine, causati dalle spese dissennate in opere celebrative e grandiosi progetti rimasti irrealizzati, completavano la situazione del paese negli anni Cinquanta, dove l'unico elemento positivo fu l'incremento dell'istruzione fra le nuove generazioni. La personalità di Sukarno, con le sue stravaganze e le sue ricchezze, continuava comunque ad affascinare le folle, e attraverso una abile mediazione fra i comunisti e l'esercito, e sul piano internazionale fra le potenze comuniste e gli Stati Uniti, il governo fu in grado di superare le diverse crisi. Per il giornalista americano Carl Mydans, Sukarno era considerato dalla popolazione come un’essere soprannaturale, e riporta un singolare comportamento del dittatore che donava l’acqua del suo bagno ai contadini affinché la bevessero e ottenessero i poteri magici di cui era dotato. Sukarno “gioiva di questa fama, dicendo: «gli indonesiani mangerebbero i sassi se chiedessi loro di farlo»”[2].
Verso la fine degli anni Cinquanta il governo adottò alcune misure che non influirono positivamente sulla vita del paese. Il debito estero con l'Olanda non venne riconosciuto, venne deciso il sequestro dei beni e delle aziende straniere, l'espulsione dei cittadini olandesi, e si ebbe una grave controversia con il governo cinese per le limitazioni imposte ai cittadini di quel paese.
Negli anni successivi il paese conosceva una ulteriore involuzione, venivano sciolti i partiti mussulmani, attribuita la presidenza a vita a Sukarno, e in base al nuovo programma di “democrazia guidata” si aveva una pesante restrizione delle libertà politiche, la costituzione di un'assemblea legislativa di nomina governativa in sostituzione del parlamento, ed un accentramento dei poteri a favore del governo. Il riavvicinamento con i comunisti e la Cina, portavano ad una politica internazionale più aggressiva, arrivando allo scontro con la Malesia per alcuni territori nel Borneo, con l'Olanda per la questione della Nuova Guinea, e nel '63 si aveva una serie di disordini e l'assalto della ambasciata britannica a Giakarta. La politica di Sukarno verso le minoranze etniche e i paesi vicini mentre il paese era sull'orlo del collasso economico ha messo in luce quella tendenza all'accentramento politico che ha costituito uno dei più gravi limiti per molti leader del Terzo Mondo.
Nel 1965 un colpo di stato da parte di gruppi comunisti, forse ispirato dallo stesso Sukarno, provocava la durissima reazione dell'esercito che si concluse con l'eliminazione di oltre mezzo milione di comunisti o presunti tali. Al massacro presero parte anche bande di contadini, i quali ritenevano i comunisti responsabili degli abusi commessi in precedenza nella redistribuzione delle terre. Progressivamente Sukarno venne allontanato dal potere, e negli anni successivi il governo militare si impose sul paese.
Con il nuovo governo presieduto dal generale Suharto, si ebbe il riavvicinamento con l'Occidente e un netto miglioramento della situazione politica della regione. Venne raggiunto un accordo fra il nuovo governo indonesiano e quello malese per i territori del Borneo, e nel '67 venne costituito fra Malaysia, Singapore, Thailandia, Filippine e l'Indonesia l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) finalizzata alla collaborazione economica ma anche ad una politica di contenimento della politica espansionistica cinese. Anche sul piano economico si ebbero dei miglioramenti attraverso una maggiore liberalizzazione delle attività produttive, tuttavia non si ebbe alcuna evoluzione per quanto riguardava la democratizzazione del paese, e anche negli anni successivi non sono mancati episodi di sangue. Nel 1975 l'ex colonia portoghese di Timor est venne invasa dalle truppe di Giacarta alcuni giorni dopo la proclamazione dell'indipendenza. Si ritiene che 200.000 persone, circa il 30% della popolazione venne passata per le armi in quanto contrari all'annessione indonesiana. Il governo di Giacarta è stato condannato dal Congresso americano e dall'ONU, ma come molte altre condanne sul piano morale cadeva nel vuoto senza conseguenze.
Una situazione non molto diversa da quella dell'Indonesia si ebbe in Birmania dove il potere venne preso da forze nazionaliste neutraliste che incapaci di gestire i processi economici del paese, provocarono una situazione di grave incertezza che favorì la successiva ascesa dei militari.
La Birmania per lungo tempo aveva fatto parte della colonia britannica dell'India nonostante la notevole diversità etnica e linguistica con quel paese. Nell’Ottocento lo stato birmano conobbe pertanto una massiccia immigrazione di indiani, che nel giro di breve tempo avevano occupato posizioni di rilievo nella società birmana, creando seri problemi di convivenza fra le due comunità.
L'amministrazione britannica comunque ebbe un impatto non negativo nel paese, e nel dopoguerra l'avvio alla indipendenza avvenne in maniera rapida e senza eccessivi problemi nonostante l'assassinio nel '47 del prestigioso leader Aung San, capo della Lega popolare antifascista per la libertà, la maggiore formazione politica del paese.
Non appena proclamata la repubblica il governo socialista presieduto da U Nu venne attaccato da gruppi comunisti che scatenarono la rivolta nel paese. Il tentativo insurrezionale era stato neutralizzato anche se non completamente represso, quando nelle regioni del nord-est insorsero i Karen e altre minoranze etniche, si formarono bande armate legate a personaggi politici di dubbia credibilità, e non molto tempo dopo si ebbe la penetrazione nel nord di una potente armata di nazionalisti del Kuomintang. Aung San e il suo successore avevano dimostrato un certo grado di disponibilità verso le popolazioni non birmane del paese, tuttavia la proclamazione del buddismo come religione di stato, venne contestata dai gruppi cristiani, e la guerriglia per lungo tempo continuò ad interessare le regioni ai confini con la Cina e la Thailandia.
Nel campo economico la riforma agraria e il controllo dell'economia da parte dello stato, secondo un programma più radicale di quello indiano, non favorirono lo sviluppo del paese, e l'esportazione del riso, che aveva rappresentato una delle principali fonti di reddito del paese, decrebbe notevolmente rispetto al periodo prebellico. Negli anni Cinquanta si ebbe la nazionalizzazione di molte imprese britanniche, e l'avvio di un grande programma di industrializzazione, che ebbe scarso successo e provocò una caduta della produzione mineraria solo in parte compensata negli anni successivi dall'aumento delle esportazioni di petrolio. Il programma di industrializzazione birmano, come quello cinese e indiano, non poteva avere successo a causa della mancanza delle strutture idonee, e produsse un danno al paese sottraendo investimenti al settore agricolo dove le possibilità di realizzazioni utili per il mercato internazionale erano sicuramente superiori.
L'ascendente di U Nu sulle folle e la sua adesione al buddismo non impedirono un certo malumore per il cattivo andamento del paese. Nel campo della politica estera il governo di U Nu, pur rifuggendo dall'estremismo di Sukarno, scelse di non aderire al Commonwealth e dimostrò scarso interesse per gli aiuti americani; negli anni successivi si fece promotore di diverse iniziative a carattere internazionale, in particolare contro l'organizzazione militare della SEATO, e insieme all'India e all'Indonesia si fece promotore di una politica neutralista attiva. La politica estera della Birmania negli anni successivi venne caratterizzata tuttavia da frequenti crisi con la Cina per questioni di confine, che portarono all'ingresso delle truppe cinesi nelle zone contestate nel '56, e ad una successiva crisi nel '67.
Anche se il fenomeno delle ribellioni delle minoranze etniche andò riducendosi negli anni successivi, non si ebbe né un miglioramento della situazione economica, né una maggiore stabilità politica; l'AFPFL, il partito di governo, si spaccò in due correnti (l'AFPFL “pulita” e l'AFPFL “stabile”), e tale crisi politica aprì la strada all'intervento dei militari al potere. Nel 1958 il generale Ne Win assunse il potere e, a parte un breve periodo fra il 1960 e il '62, le alte gerarchie militari hanno governato il paese ininterrottamente negli anni successivi. L'indirizzo socialista del nuovo governo - la cosiddetta “via birmana al socialismo” - venne rafforzata, e il paese conobbe negli anni successivi una grave involuzione con la restrizione degli scambi con l'estero, la chiusura culturale verso il mondo occidentale, e gravi atti di violenza.
Una delle principali cause del fallimento economico di paesi come la Birmania e l'Indonesia negli anni Cinquanta fu la grave carenza di quadri qualificati e la corruzione a tutti i livelli della pubblica amministrazione, che costituì uno dei maggiori problemi del sud-est asiatico e forse di tutto il continente; secondo la testimonianza di Stanley Karnow, esperto americano di problemi asiatici, la situazione di questi paesi era tale da impedire un corretto sviluppo economico e la nascita di un saldo sistema politico.
Le vicende della Birmania sono state al centro delle cronache anche in anni recenti, a causa delle feroci repressioni che sono costate la vita a 130.000 persone e hanno provocato la fuga di oltre 200.000 birmani nel vicino Bangla Desh. Contro la politica dispotica del governo e del generale Saw Maung, ritenuto da alcune fonti uno squilibrato, si sono avute le dure prese di posizione del clero buddista e numerose manifestazioni studentesche, ma solo nel 1992 dopo anni di sanguinosa dittatura la situazione è ritornata ad una relativa normalità.
Nella vasta e selvaggia regione montuosa a cavallo di Birmania, Thailandia e Laos si è creato negli anni passati una sorta di stato autonomo che viveva sulla produzione e il commercio dell'oppio. La zona, conosciuta come il Triangolo d'Oro, riforniva gran parte dei mercati mondiali di eroina e risultava controllata da gruppi cinesi, operatori economici di Hong Kong, ex generali dell'armata del Kuomintang, e da guerriglieri del PC birmano, avvalendosi dell'opera di tribù locali. Sia il governo di Pechino che quello americano si sono impegnati per l'eliminazione di questa situazione ma con risultati non definitivi.
Il processo di decolonizzazione nelle Filippine avvenne in forma abbastanza rapida e senza provocare eccessive difficoltà. Non appena cessata la guerra gli Stati Uniti accordarono l'indipendenza alla piccola nazione asiatica conservando comunque per alcuni anni limitati privilegi per i propri prodotti nel campo commerciale. Luzon ed altre importanti isole rimanevano però sotto il controllo del movimento guerrigliero Huk contro il quale il governo di Roxas adottò una strategia di tipo militare e una di tipo politico, con alcuni provvedimenti a favore dei contadini che lavoravano nei latifondi. Tali provvedimenti rimasero tuttavia in larga parte inattuati e la struttura economica del paese rimase dominata da una ristretta oligarchia in cui meno dell'uno per cento della popolazione deteneva circa un terzo delle terre coltivabili e disponeva di vasti poteri all'interno della società.
Nonostante i considerevoli aiuti economici degli Stati Uniti il paese stentava a riprendersi dalle distruzioni della guerra, dall’instabilità politica, e a procedere nel campo delle riforme. Nixon ricorda nelle sue memorie che il generale Mac Arthur riteneva comprensibile che a causa delle gravi sperequazioni economiche esistenti nel paese molti filippini aderissero al movimento guerrigliero, e che “se fosse stato un contadino filippino, probabilmente anche lui sarebbe diventato comunista”. Alle elezioni del 1953 si affermò il partito nazionalista diretto da Magsaysay, che con il sostegno degli Stati Uniti riuscì a combattere la corruzione, fenomeno particolarmente grave nel paese, a contenere l'attività dei guerriglieri, e a portare avanti diverse misure per il miglioramento delle condizioni della popolazione rurale. In particolare il leader filippino si impegnò nella distribuzione di terre ai contadini, provvedimento di cui ne beneficiarono anche i guerriglieri che avevano deposto le armi. Le Filippine conobbero un periodo di ripresa, ma l'ascendente del nuovo leader sulle masse non fu in grado tuttavia di superare tutti i problemi del paese, e alla sua morte nel '57 le Filippine conobbero un nuovo peggioramento e la cessazione della distribuzione di terre. Tale situazione favorì la ripresa della guerriglia, comunista filomaoista nella parte nord dell'arcipelago, e di tendenze islamiche nel sud.
Anni più tardi le Filippine conobbero una nuova grave crisi con l'ascesa al potere dei coniugi Marcos, che presentatisi con un programma politico di sinistra, imposero la legge marziale e si impadronirono di una larga parte delle riserve della banca centrale. Aspramente combattuti dalla chiesa cattolica e dai gruppi politici democratici, nel 1986 i coniugi Marcos furono costretti a lasciare il paese, che ritornò alla normalità sotto la direzione della Corazon Aquino, vedova di un illustre dirigente politico democratico.
Il problema più grave della Malesia negli anni del dopoguerra fu dato dalla presenza di un elevato numero di immigrati, soprattutto cinesi e indiani, che costituivano il 60% circa della popolazione. La comunità cinese fu quella oggetto di maggiori persecuzioni nonostante la incessante opera di mediazione delle autorità britanniche; sorse così nel '48 all'interno della stessa un movimento comunista che scatenò la guerriglia e mise in grave difficoltà il governo. Negli anni successivi i guerriglieri furono costretti a ritirarsi nella giungla e gli ultimi focolai di resistenza vennero eliminati una decina di anni dopo, la Malesia poté quindi costituirsi come federazione di sultanati e procedere nel 1957 attraverso negoziati su basi pacifiche e consensuali verso l'indipendenza.
Attraverso l'opera del primo ministro Abdul Rahman vennero poste le basi per una pacifica convivenza fra i diversi gruppi etnici, ampliato lo stato attraverso l'integrazione dei territori del Borneo, mantenuti legami politici ed economici con la Gran Bretagna e il mondo occidentale (anche se il paese non aderì alla SEATO), e diversificata l'economia del paese non più incentrata esclusivamente sulla produzione di stagno e caucciù; tale politica ha consentito negli ultimi anni risultati notevoli rispetto al resto del continente, e per molti aspetti il paese presenta una situazione nettamente diversa da quella della maggior parte dei paesi del Terzo Mondo.
la Thailandia, unico paese della regione a non aver conosciuto il dominio coloniale, è stata interessata negli ultimi decenni da numerosi colpi di stato, che non hanno determinato tuttavia significativi mutamenti politici. Il piccolo regno, nonostante l'instabilità politica ha goduto di un discreto sviluppo economico, non ha conosciuto violenze e con l'altra monarchia, la Malaysia, costituisce il paese più ricco dell'area sud orientale dell'Asia. Un relativo benessere, e una equa distribuzione delle terre ha consentito il miglioramento delle condizioni economiche della popolazione, e negli ultimi tempi una maggiore democratizzazione della vita politica.
Nel 1955 i paesi afroasiatici che da poco avevano raggiunto l'indipendenza tennero una conferenza a Bandung in Indonesia per ribadire alcune delle loro richieste nei confronti delle altre nazioni. La conferenza venne salutata come un grande evento e un segno della maturità politica raggiunta dai paesi di nuova formazione. In un suo intervento il presidente Sukarno affermò che il consesso costituiva “la prima conferenza internazionale dei popoli di colore nella storia dell'umanità... Noi gente dell'Asia e dell'Africa... siamo più della metà della popolazione del mondo, e possiamo mobilitare quella che io chiamo la violenza morale delle nazioni in favore della pace”. L'incontro, tenutosi per iniziativa di India, Indonesia e Birmania, stabilì alcuni importanti principi in materia di lotta al razzismo, alla segregazione razziale (con esplicito riferimento alla situazione del Sudafrica), e al colonialismo in tutte le sue forme. La politica colonialista oltre a violare i diritti fondamentali dell'uomo costituiva secondo i convenuti un grave impedimento allo sviluppo del Terzo Mondo. L'affrancamento dei popoli di colore dal dominio coloniale europeo doveva quindi essere integrato dalla cooperazione in campo economico e politico all'interno del Terzo Mondo e a livello mondiale, da realizzarsi attraverso una maggiore stabilizzazione dei prezzi dei beni strategici e un maggiore impegno della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo nei confronti dei paesi poveri. Una parte significativa del documento finale venne dedicata al sostegno della causa della pace e al problema della guerra fredda, che investiva sempre più le aree povere del mondo. A tal fine si ritenne che “tutti i paesi dovrebbero cooperare, soprattutto con la mediazione delle Nazioni Unite, per giungere a una riduzione degli armamenti e all'eliminazione delle armi nucleari” in quanto secondo i delegati “Libertà e pace sono interdipendenti” e contribuiscono al benessere generale dell'umanità. Molti dei principi espressi alla conferenza tuttavia vennero disattesi proprio dai paesi che avevano maggiormente contribuito alla riuscita. Come gli accordi di Parigi del '73 sul rispetto delle libertà in Indocina e i Pantja Sila in Indonesia, la carta di Bandung non ha trovato alcuna applicazione e ha messo in luce come la maggior parte dei programmi politici nei paesi del Terzo Mondo costituissero semplice coreografia agli apparati di potere.
I regimi comunisti creatisi in Indocina dopo il 1975 hanno costituito una terribile tragedia per quella regione: deportazioni, lavoro forzato, campi di sterminio dove hanno trovato la morte centinaia di migliaia di persone, trasformarono la ex provincia dell'impero francese in un luogo “al di là di ogni orrore” come è stata definita, ed ha messo in luce con inquietudine i gravi limiti sui quali è caduta larga parte della stampa e della cultura degli anni Settanta. Un certo puritanesimo dei costumi, esteso anche agli aspetti personali della vita dell'individuo, costituirono un punto in comune dei regimi comunisti in Asia. Secondo la testimonianza del gesuita Piero Gheddo che per molti anni è stato in Indocina “Il Vietnam del sud è oggi purificato: non ci sono spogliarelli, né prostituzione, né droga, ne film e riviste pornografiche. Possiamo aggiungere che non si vedono più minigonne, né si sentono canzoni leggere, né per le strade ci sono cortei di protesta, lavoratori in sciopero come una volta, studenti che manifestano... Ma tutto questo è bene o male? E' segno di purezza o di schiavitù?”.
Fra i primi provvedimenti del governo comunista in Vietnam vi fu il trasferimento in massa degli abitanti delle città, circa otto milioni secondo le stesse fonti governative, in terre povere e inospitali. La vita dei cittadini venne posta sotto severo controllo, attraverso il divieto di spostamento da un villaggio all'altro, e attraverso la costituzione di “cellule” formate da gruppi di famiglie sottoposte a sedute d'indottrinamento, dove la delazione divenne ordinario metodo di potere. Per chiunque manifestasse dissenso o non garantiva risultati adeguati nel lavoro, era previsto l'invio ai campi di rieducazione dove un gran numero di persone trovarono la morte. Secondo stime documentate poco meno di un milione furono le persone soggette alla detenzione nei primi due anni della instaurazione della Repubblica Democratica del Vietnam. Vittime principali delle persecuzioni non furono soltanto i funzionari che avevano servito il regime di Thieu, ma analogamente alla Cina della Rivoluzione Culturale, tutti coloro che fossero dotati di un certo grado di cultura o che fossero stati trovati in possesso di libri occidentali. Fine di tali pratiche secondo il governo di Hanoi era la realizzazione di una “società nuova” e di un “uomo nuovo”. Il senso di questa affermazione non stava nel fatto che il regime intendeva favorire il progresso della società e dell'individuo, ma creare un essere umano diverso, privo di radici storiche, conformista e sottomesso alla volontà del regime.
L'economia del paese subì in quegli anni dei danni gravissimi, il sistema produttivo venne sacrificato agli interessi bellici (con una spesa pari a circa il 20-22% del reddito nazionale, nel 1980 l'esercito vietnamita raggiunse l'incredibile cifra di oltre 1.200.000 effettivi, non di molto inferiore a quello dell'India con una popolazione di tredici volte superiore) nonostante le difficoltà economiche del paese.
Negli anni Ottanta le regioni dell'ex Vietnam del sud vennero sottoposte ad un intenso sfruttamento, vennero perseguitate le minoranze cinesi, e il paese cadde in uno stato di carestia come non aveva conosciuto neanche negli anni della guerra. Tale tragedia ha provocato un altissimo numero di profughi. Circa un milione di persone (i cosiddetti Boat People) abbandonò il paese in condizioni disperate trovando rifugio nei paesi vicini o negli Stati Uniti.
Ancora più grave fu la situazione in Cambogia dove nel giro di breve tempo furono chiuse tutte le ambasciate (ad eccezione della rappresentanza cinese), allontanata la stampa e tutti gli stranieri. I provvedimenti adottati dai Khmer Rossi, trasformarono la Cambogia in un unico vasto campo di concentramento, secondo una pratica che non aveva confronti con altri regimi. Tutta la popolazione di Phnom Penh e delle altre città venne privata dei suoi averi e condotta a lavorare nelle campagne dopo lunghe marce forzate nella foresta dove persero la vita centinaia di migliaia di persone. Non solo le opere culturali provenienti dall'Occidente, ma tutte le merci comprese le medicine di provenienza straniera vennero distrutte. Biblioteche e importanti opere d'arte, come nel periodo della Rivoluzione Culturale, vennero date alle fiamme, venne imposto l'uso di un abito particolare, una tuta di colore nero, e la rinuncia ad ogni segno distintivo personale, talvolta anche del nome. Il nuovo governo fece largo ricorso ai bambini e agli adolescenti, orfani o sottratti ai genitori, per intimidire la popolazione ovvero per fare opera di delazione. La folle tragedia, sicuramente una delle peggiori del nostro secolo, che ha provocato quasi due milioni di vittime, ebbe termine solo nel '79 quando il governo di Hanoi invase il paese in quella che poteva essere considerata una autentica guerra di conquista.
Anche nel Laos, sul quale non esistono numerose informazioni, negli anni successivi alla vittoria comunista venne realizzata una dura dittatura che ha portato al progressivo impoverimento della nazione. Diversamente dagli altri due stati indocinesi non risulta che qui vi sia stato il consueto trasferimento coatto delle popolazioni urbana verso le campagne, per il resto la politica è stata la stessa degli altri paesi comunisti della regione: spoliazione dei beni delle famiglie attraverso il ritiro dalla circolazione della moneta, chiusura verso il mondo esterno (ad eccezione del Vietnam che deteneva numerose unità militari nel paese), corsi di indottrinamento e lavoro obbligatorio, requisizioni nel campo agricolo che hanno portato il paese alla carestia ulteriormente aggravata dalla fuga in Thailandia di tecnici e uomini di cultura in genere. Qui tuttavia a differenza degli altri due paesi, data anche la conformazione del territorio, è sorta una attiva guerriglia che si è opposta anche con successo nei confronti del regime.
il subcontinente indiano
fra estremismo e tolleranza
La vasta regione indiana costituiva e costituisce un mosaico di razze, religioni e lingue eterogeneo, tale da rendere estremamente difficile la realizzazione di uno stato unitario. Tale realtà era ulteriormente aggravata dalla presenza di un sistema di caste che costituivano una sorta di micro-stati separati gli uni dagli altri con proprie leggi e istituzioni. Nel 1945 la colonia britannica indiana comprendeva circa 400 milioni di abitanti la metà dei quali induisti, 90 milioni mussulmani, e circa 6 milioni sikh; all'interno della nazione vi era un gran numero di lingue e circa 500 principati che rendevano la situazione estremamente complessa. Secondo Henry Kissinger “Come il Medio Oriente, anche l'India è patria di grandi religioni. Eppure a differenza di quelle mediorientali, queste religioni non predicano l'esaltazione e il fanatismo, bensì la pazienza e la sopportazione”, tuttavia la regione come vedremo fu teatro anch'essa di gravissime violenze e di contrasti pressoché endemici che hanno causato la morte di molte migliaia di civili e di numerosi leader politici di primo piano.
Negli anni della guerra un gruppo di nazionalisti creò un governo dell'India nei territori della vicina Birmania controllata dai giapponesi, ai quali andarono le simpatie di molti indiani emigrati nei paesi vicini e nella stessa colonia britannica, i leader del Congresso, la maggiore organizzazione indipendentista indiana, evitarono comunque di fomentare disordini e in qualche modo offrirono una benevole neutralità allo sforzo della Gran Bretagna nella sua guerra colla Germania e il Giappone.
Il governo Churchill pur affermando che i principi della Carta Atlantica non potevano per il momento applicarsi all'India, aprì diversi negoziati con i massimi rappresentanti del popolo indiano, che tuttavia diedero scarsi risultati. Un passo in avanti venne compiuto successivamente con la pubblicazione da parte del governo britannico del “libro bianco” sulla questione indiana secondo il quale “L'obbiettivo principale della politica coloniale inglese... è quello di guidare i territori coloniali all'auto-governo responsabile all'interno del Commonwealth in condizioni che assicurino alle popolazioni interessate sia un buon tenore di vita che completa libertà dall'oppressione”, ma la questione venne complicata dalla crescente contrapposizione fra mussulmani e induisti. In alcune regioni le differenze di religione corrispondevano con gruppi etnici diversi, ma in altri casi non vi era una precisa separazione, e tale situazione rese più difficile l'opera di mediazione dei britannici. Il Congresso indiano divenne quindi principalmente il rappresentante degli induisti, e la Lega diretta
Le origini del comunismo di Luciano Atticciati (anno 2001)
Diversamente dal passato molti oggi ritengono che il comunismo non nasca con Marx ma abbia origini diverse e più antiche
Karl Marx, il reazionario di Luciano Atticciati (agosto 2006)
Il pensatore tedesco riteneva di superare i mali del capitalismo attraverso una società rigidamente egualitaria simile a quella dei leggendari periodi più antichi
Karl Marx e la dittatura del proletariato di Luciano Atticciati (anno 2001)
Il grande filosofo tedesco insieme all’amico Engels sosteneva l’idea di uno Stato fortemente centralizzato e autoritario per la realizzazione di una nuova società
Il comunismo secondo Dostoevskij e Turgenev di Simone Valtorta (febbraio 2016)
Nella seconda metà dell’Ottocento, due intellettuali russi denunciano gli errori e gli orrori di una élite sempre più orientata verso il socialismo e la rivoluzione; mezzo secolo dopo, ciò che avevano preannunciato diverrà realtà, e sarà la tragedia
Michail Bakunin, l’anarchico poco libertario di Luciano Atticciati (giugno 2013)
Abolizione di ogni istituzione per la creazione di una società idilliaca ma anche nichilista
Lenin, il rivoluzionario anomalo di Luciano Atticciati (anno 2001)
Secondo una parte della storiografia e degli esponenti socialisti del tempo il rivoluzionario russo aveva uno spirito fortemente autoritario, risoluto, ma anche conservatore sotto certi aspetti
La Rivoluzione d'Ottobre fra anarchismo e dispotismo di Luciano Atticciati (aprile 2008)
Nel giro di pochi mesi la Russia passò da una situazione di quasi anarchia ad un regime dittatoriale particolarmente repressivo anche sul piano economico
La Rivoluzione d’Ottobre e gli anarchici italiani di Luciano Atticciati (anno 2001)
Un evento incredibile che suscitò entusiasmo nella parte più emotiva della società, ma anche profondi ripensamenti
1919: la nascita del comunismo di Luciano Atticciati (anno 2001)
I due congressi di fondazione dell’Internazionale comunista contestavano la «democrazia borghese» in nome di una dittatura delle masse diretta da un partito gestito con «disciplina di ferro»
Il terrore rosso in Russia (1918-1923) di Luciano Atticciati (agosto 2014)
La testimonianza dello studioso Sergej Mel’gunov su uno degli eventi più terribili della storia del Novecento
Il socialismo reale di Luciano Atticciati (anno 2001)
La politica di Lenin e del suo successore era rivolta a creare uno stato rigidamente totalitario attraverso l’uso di un nuovo strumento, le persecuzioni di massa
La persecuzione religiosa sotto Stalin di Mattia Ferrari (ottobre 2015)
Storia di una dura repressione contro la religione che, iniziata sotto Lenin e proseguita fino alla caduta dell’Unione Sovietica, ebbe il suo apice durante la dittatura di Stalin
Nikolaj Bucharin, il grande rivoluzionario di Luciano Atticciati (giugno 2014)
Un agitatore «impegnato» che aveva sintetizzato nei suoi scritti utopismo e terrore
Trotzky, il comunista che aveva sfidato Stalin di Luciano Atticciati (luglio 2014)
Un pensatore integralista e ambiguo, nei cui scritti sostenne una organizzazione del lavoro fondata su un sistema centralizzato e fortemente autoritario
La tragedia dei comunisti italiani in Russia di Luciano Atticciati (anno 2002)
Il terribile destino degli antifascisti fuggiti in Russia negli anni Trenta
Il Gulag di Ercolina Milanesi (anno 2004)
Una realtà a lungo dimenticata, ha caratterizzato una parte importante del mondo, ed ha fortemente influenzato le vicende del Novecento
Ucraina, olocausto dimenticato di Ercolina Milanesi (agosto 2013)
Una studiosa russa ha raccolto la «storia orale» di quel massacro che attende ancora di essere riconosciuto dall’Occidente e dall’ONU
Una sconosciuta tragedia dell’epoca staliniana di Alberto Rosselli (anno 2005)
La deportazione dei militari e dei civili polacchi in Iran
Il mondo comunista e il problema dell’omosessualità di Enrico Oliari (anno 2005)
Considerati personaggi insani e non conformisti, gli omosessuali furono oggetto di persecuzioni e di drammatiche vicende
Cristianesimo e Marxismo di Alberto Rosselli (anno 2003)
Tra metafisica e storia, le ragioni di una convergenza impossibile
Intellettuali progressisti e marxismo di Alberto Rosselli (anno 2005)
La posizione di alcuni famosi intellettuali nei confronti delle Rivoluzione d’Ottobre e dei regimi comunisti
Il comunismo, il grande mito di Luciano Atticciati (ottobre 2014)
Lo storico inglese Robert Service affronta la questione dei regimi totalitari violenti e radicali che nel corso del Novecento venivano visti come l’avvento di un nuovo mondo
Il comunismo nella recente storiografia di Luciano Atticciati (anno 2003)
Un movimento contrario all’idea di progresso che ebbe successo a causa della difficile situazione sociale del nostro continente, risulta dagli scritti di Nolte, Furet, Conquest, Pipes. Il comunismo potrebbe essere definito come l’idea di gestire i problemi sociali attraverso un sistema autoritario