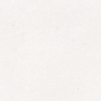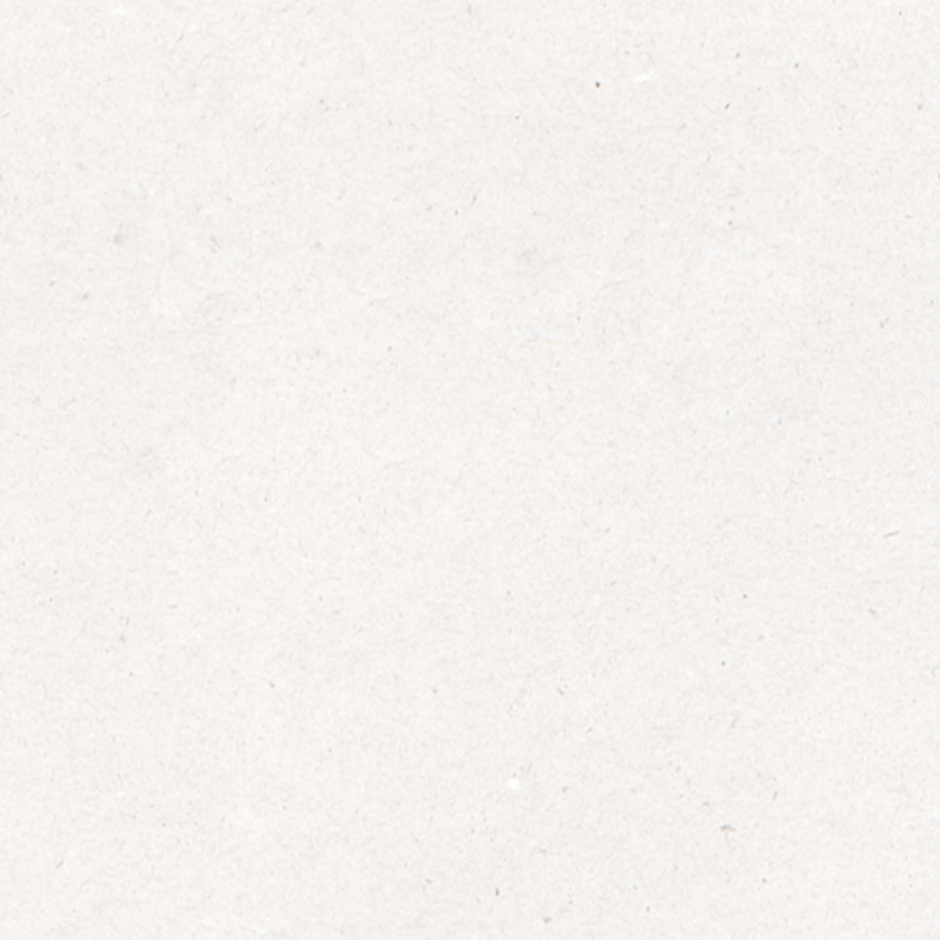Parte 4°
Regimi totalitari e rivoluzione
in America Latina
L'America Latina comprende due realtà sociopolitiche diverse: la regione delle Ande, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, più arretrata, e il resto del continente relativamente più progredito. Entrambe le regioni furono comunque interessate negli anni Trenta, anche come conseguenza alla crisi economica mondiale, dalla ascesa al potere dei militari che diedero vita a regimi totalitari, alcuni dei quali si richiamavano espressamente all'esperienza del fascismo.
Raggiunta l'indipendenza dalla Spagna il continente divenne oggetto d'interesse del capitale europeo e statunitense, ma progressivamente l'influenza nordamericana prevalse su quella del vecchio continente. La dottrina Monroe, all'indomani della proclamazione in Europa della Santa Alleanza, stabiliva infatti che le Americhe non dovessero essere oggetto di contesa da parte dei paesi europei, che dovesse essere favorita la diffusione dei sistemi democratici, e che occorresse porre le basi per una integrazione economica e politica del grande continente.
Nel quadro di queste finalità nel 1890 si tenne la prima Conferenza panamericana che stabilì una forma di cooperazione fra i paesi del continente all'interno della quale tuttavia il peso degli Stati Uniti era destinato a divenire sempre più rilevante. Negli anni Trenta gli Stati Uniti rividero la loro politica, aderirono al principio di non intervento negli affari interni dei paesi, e nel 1948 alla nona conferenza di Bogotà venne stabilita la creazione della Organizzazione degli Stati Americani. Lo scopo della organizzazione era di garantire la sicurezza collettiva del continente, risolvere gli eventuali contrasti sorti fra i paesi membri, provvedere ad una azione comune contro una eventuale aggressione esterna, favorire lo sviluppo economico, sociale e cultura-le.
Il progetto ebbe attuazione tuttavia non fu in grado di risolvere la difficile situazione della America Latina, che presentava problemi sociali ed economici gravissimi. Per porre fine a tale situazione nel 1961 il presidente Kennedy decise il lancio un importante piano per il risollevamento delle nazioni povere del continente, l'Alleanza per il progresso; il programma prevedeva ingenti crediti, riforme nel campo fiscale e una nuova distribuzione delle terre per favorire un maggiore benessere sociale e neutralizzare le spinte eversive comuniste all'interno dei paesi più arretrati. I risultati furono decisamente modesti; i governi latino americani beneficiarono degli aiuti, ma si opposero a iniziative tese a ridurre il predominio delle classi sociali elevate sul resto del paese. Negli anni successivi non mancarono contestazioni degli stati latino americani verso il gigante statunitense, tuttavia l'OSA ha potuto favorire la risoluzione di diverse controversie.
Fra gli anni Sessanta e Settanta l'America Latina conobbe una nuova ondata di governi dittatoriali; Stroessner, Castelo Branco, Pinochet, Videla, in quegli anni diedero vita ad alcune delle peggiori dittature della storia del continente. La caratteristica principale di questi governi non fu quella di garantire l'ordine compromesso dalle precedenti rissose democrazie o di contenere l'ondata comunista ma di imporre un regime contrario ai principi democratici senza riguardo per i diritti umani.
Negli anni successivi l'America Latina ritornò alla democrazia, tuttavia dovette affrontare i problemi dell'inflazione e dell'indebitamento con l'estero, che sono stati risolti con alcune riforme in senso liberista e alcune misure economiche restrittive.
TENSIONI SOCIALI E POLITICHE
IN SUD AMERICA
L'Argentina, l'ultima delle terre del Sud America ad essere colonizzata, per un certo periodo conobbe una situazione di notevole sviluppo economico, che fece del paese il più ricco del continente. A rigore il paese come il vicino Cile, non dovrebbe essere compreso fra i paesi del Terzo Mondo dato il livello di vita relativamente evoluto, tuttavia per la sua vita politica, che presenta collegamenti notevoli con il mondo meno sviluppato, può essere senz'altro oggetto di indagine. Come gli altri paesi sudamericani l'Argentina godette di un relativo benessere durante gli anni dell'ultimo conflitto mondiale per il notevole incremento delle esportazioni, ma negli anni successivi venne travagliata da contrasti economici e sociali che portarono il paese all'instabilità politica e al collasso economico.
Un colpo di stato militare nel 1930 mise fine ad un periodo di relativa stabilità politica e di moderate riforme che era iniziato nel 1916 con la presidenza di Irigoyen. Diversi governi militari conservatori e piuttosto anonimi si alternarono al potere fino al 1943, quando salì al potere un nuovo gruppo di alti ufficiali favorevoli all'Asse che impressero una nuova politica al paese. L'insurrezione militare, condotta all'insegna della parola d'ordine: Gobierno, Orden, Unidad, non aveva destato grande interesse popolare, tuttavia negli anni successivi con l'emergere della figura di Juan Peron il paese venne sconvolto da manifestazioni senza precedenti nella storia della nazione.
La politica del governo Peron ha sicuramente messo in difficoltà numerosi commentatori internazionali per la sua complessa collocazione politica; da una parte si richiamava all'esperienza fascista e accoglieva nel paese numerose personalità compromesse col nazismo e il fascismo, dall'altra inaugurava una politica di scontro con gli Stati Uniti che faceva pensare ad una politica nazionalista non diversa da quella di altri paesi del Terzo Mondo. Il nuovo regime stabiliva buoni rapporti con il clero, intraprendeva numerose nazionalizzazioni di imprese, e prese provvedimenti contro i latifondisti che negli anni precedenti avevano goduto di ampi poteri nel paese; nel complesso tuttavia l'elemento che sembrava prevalere era dato da una sorta di populismo, elemento che ha portato ad una vastissima mobilitazione delle masse. Secondo lo scrittore John De Chancie “Peron vedeva la propria gestione come una via di mezzo - o, come diceva lui stesso, come una «terza posizione» - tra le due opposte concezioni che dividevano il mondo: il comunismo e il capitalismo. Sosteneva che la sola società giusta è quella nella quale i vari gruppi e le classi sociali lavorano di conserva in un'atmosfera di reciproca fiducia e di dedizione al bene comune. La chiave di tutto ciò era nell'unità, il che significava naturalmente unità sotto Peron e il peronismo” . Molto del successo di Peron fu dovuto anche all'attivismo della moglie Evita, che infaticabile si adoperò nell'aiuto ai poveri, ai disoccupati, alle vedove, con iniziative anche molto appariscenti, per le quali venne vista dalle moltitudini fino alla prematura morte, come l'angelo custode della gente umile.
Nel suo discorso con cui assumeva la presidenza nel giugno del 1946, Peron sostenne che “La grande adesione popolare mi autorizzava a chiedere e a sperare nella collaborazione di tutti... Il mio scopo è alto e il mio emblema è chiaro, la mia causa è la causa del popolo, la mia guida, la bandiera nazionale” . Il giustizialismo, la dottrina adottata dal peronismo, secondo la studiosa Lucilla Gallavresi costituiva un ideale social-cristiano abbastanza singolare e non sempre comprensibile, tuttavia profondamente legato ai valori della società argentina.
Peron governò il paese con metodi autoritari, tuttavia come riconosce un suo biografo, Joseph Page, lo statista argentino non amava la violenza e “Anche se Peron aveva ordinato e tollerato molti eccessi ai suoi tempi, una cosa va detto a suo merito che non trasformò mai le carceri in macelli” come invece fecero altri suoi successori negli anni successivi . Nel corso degli anni Peron si avvalse di alleati politici diversi e seguì politiche diverse, ma il fatto non preoccupava i suoi sostenitori, secondo un autorevole esponente peronista gli europei non erano in grado di comprendere il fenomeno Peron “Il solo rivoluzionario che abbia avuto l'Argentina in questi ultimi cento anni. E' l'unico che abbia aiutato il popolo, che ha fatto sentire per la prima volta cittadini di pieno diritto i diseredati, gli umili, i lavoratori” .
Alla politica nazionalista sul piano interno, faceva riscontro un notevole attivismo nel campo delle relazioni internazionali. Venne progettato la creazione di una associazione di stati della parte meridionale del continente latino americano da contrapporre alla potenza economica del Nord America, progetto che tuttavia venne abbandonato non molto tempo dopo a causa di reciproci contrasti e diffidenze fra i governi dei paesi membri.
Sotto il regime di Peron si ebbero consistenti aumenti salariali a favore dei ceti operai , nazionalizzazioni di importanti settori economici, una più efficace legislazione sociale, ma il fallimento del programma di industrializzazione e l'eccessivo aggravio della spesa pubblica provocarono una grave inflazione che danneggiò l'economia del paese. I grandi complessi industriali progettati dal governo argentino si rivelarono inadeguati per una nazione che disponeva di un mercato notevolmente limitato e crearono di fatto scarsi benefici alla nazione.
Nell'ultimo anno di presidenza improvvisamente Peron iniziò ad attaccare la Chiesa, azione che creò sconcerto nelle sue stesse file; contemporaneamente il piano di austerità proposto dal governo diede scarsi risultati, e ciò incoraggiò il malumore all'interno della casta militare. Quando nell'estate del '55 l'esercito si sollevò contro il governo, Peron avrebbe potuto opporre una notevole resistenza appellandosi ai suoi descamisados, il proletariato urbano di Buenos Aires, tuttavia imprevedibile come nel passato, Peron preferì abbandonare il potere senza spargimento di sangue.
Negli anni successivi i militari tornarono al potere appoggiandosi a diverse forze politiche, senza sopprimere formalmente la vita dei partiti, ma senza riuscire a migliorare la situazione economica della nazione che rimase sempre precaria nonostante l'abbondanza di risorse naturali del paese. Negli anni Settanta il paese venne sconvolto dalle rivolte dell'estrema sinistra e dal terrorismo, con un numero notevole di assassinii, rapine e rapimenti. Due gruppi in particolare si distinsero in questa attività, i Montoneros nati dalla corrente di sinistra del peronismo, e l'Esercito Rivoluzionario del Popolo, un gruppo politico che si proclamava di tendenze trozkiste. Dopo un breve ritorno al potere di Peron e della sua nuova moglie, che non pose fine ai duris-simi contrasti e agli scontri fra peronisti di destra e di sinistra, nel '76 si ebbe un nuovo reingresso dei militari nella scena politica che imposero una brutale dittatura con l'eliminazione di alcune migliaia di oppositori politici, i cosiddetti desaparecidos. La tragedia ebbe termine nel 1982 quando l'impopolare regime tentò di riacquistare il consenso della popolazione lanciandosi in una guerra contro la Gran Bretagna per il possesso delle isole Falckland, guerra che si concluse con una disfatta totale per il regime.
Avvenimenti abbastanza simili a quelli argentini si sono avuti in Brasile. Nel 1930, in seguito ad elezioni presidenziali irregolari si ebbe una sollevazione che portò al potere Getulio Vargas, il quale diede vita ad un regime fortemente innovativo rispetto ai precedenti, il cosiddetto Estado Novo. Come il regime di Peron il governo di Vargas si richiamava al fascismo italiano riprendendo soprattutto gli aspetti populistici di quella esperienza politica. I poteri degli stati della federazione vennero notevolmente ridimensionati a favore del potere centrale, venne dato un notevole impulso alla industrializzazione del paese, e favorito l'intervento dello stato nell'economia. Durante il lungo periodo di permanenza al potere Vargas intraprese numerose iniziative a favore dei ceti meno abbienti e dei lavoratori che gli valse l'appellativo di “padre dei poveri”, venne istituita una previdenza sociale particolarmente estesa, e cercò di affrancare il paese dal predominio commerciale statunitense, tuttavia gli ultimi anni del suo governo furono contrassegnati da difficoltà economiche e politiche che provocarono il diffondersi della corruzione e della violenza. Di fronte alla nuova situazione il dittatore abbandonate le velleità totalitarie diede vita ad un partito socialdemocratico aperto all'appoggio dei comunisti, ma la difficile congiuntura e il malumore dei militari spinsero lo statista al suicidio, e nel 1954 il potere passò al socialdemocratico Kubitschek, sotto il quale l'inflazione provocò un peggioramento delle condizioni dei lavoratori nonostante l'apparente crescita economica del paese. Il successore, il conservatore democratico Quadros, cercò di mettere fine alla spesa pubblica dissennata del suo predecessore che con la realizza-zione della nuova capitale a Brasilia aveva largamente dilapidato i fondi statali. Il suo periodo di permanenza al potere fu tuttavia breve, e dopo un tentativo di dare vita ad una associazione di stati latino americani in contrasto con gli Stati Uniti, si ebbe il ritorno delle sinistre.
Le agitazioni dei contadini del Nordeste, la regione più povera del Brasile, le nazionalizzazioni nel campo fondiario e industriale, le scelte autoritarie del nuovo presidente, Joao Goulart, e un ampio maneggio ai vertici militari, fecero pensare che il paese si avviasse verso l'instaurazione di un regime comunista. Il tentativo non ebbe successo a causa di una sollevazione di alti ufficiali, che dopo un breve periodo di transizione instaurarono una delle peggiori dittature del paese . Nel paese fecero la comparsa gli squadroni della morte, come venivano chiamati i gruppi estremisti legati ai poteri locali, che colpirono indifferentemente sindacalisti, oppositori e minoranze Indios. In base alla “Dottrina della sicurezza nazionale”, programma di governo che considerava ogni persona non allineata al regime un nemico dell'ordine, il ricorso alla tortura da parte della polizia divenne un fenomeno comune, mentre sul piano sociale si assistette ad un peggioramento delle condizioni economiche di operai e contadini.
In questi anni sorse in Brasile come in altri stati latino americani movimenti di guerriglia urbana e contadina di tendenze marxiste e castriste, che in alcuni casi ebbero la solidarietà di esponenti della chiesa cattolica. La testimonianza di Helder Camara, vescovo del Nordeste, Premio Nobel per la pace nel 1974, risulta particolarmente significativa. Suscitando lo sdegno della parte più conservatrice della gerarchia ecclesiastica sostenne che “I giovani che in Brasile reagiscono alla violenza con la violenza sono idealisti che ammiro. Purtroppo la loro violenza non conduce a nulla e così devo aggiungere: se vi mettete a giocare con le armi, gli oppressori vi schiacceranno... L'idea che la guerriglia fosse l'unica soluzione per l'America Latina si sviluppò dopo la vittoria di Fidel Castro... No Cuba non può ripetersi e io non credo che l'America Latina abbia «bisogno di molti Vietnam» come diceva Che Guevara” . Il vescovo non risparmiò critiche comunque ai terroristi che si finanziavano con rapine e rapimenti di diplomatici e prese le distanze dal comunismo. Camara si fece sostenitore infatti di un socialismo che conciliasse la giustizia sociale con il rispetto dei diritti umani, e come egli stesso affermò “Il mio è un socialismo speciale, un socialismo che rispetta la persona umana e si rifà agli Evangeli. Il mio socialismo è giustizia... Dio non è ingiusto e vuole che non vi siano privilegiati e oppressi, vuole che ciascuno riceva l'essenziale per vivere... Io non ho soluzioni. Ho solo opinioni che si riassumono in due parole: violenza pacifica. Cioè non la violenza scelta dai giovani con le armi in mano ma la violenza, se vuole già predicata da Gandhi e Martin Luther King. La violenza di Cristo” .
La condanna del governo militare brasiliano venne confermata dalla Conferenza Episcopale del Brasile nell'ottobre 1976. L'assemblea dei vescovi denunciava “L'azione perniciosa e nefasta, anonima o pubblica, di coloro che accusano i vescovi, i preti e i laici di essere sovversivi, agitatori e comunisti, quando prendono le difese dei poveri, degli umili, dei prigionieri e delle vittime delle torture”. Il documento approvato in quella sede non si limitava a chiedere una azione caritatevole verso i poveri ma condannava l'ingiusta distribuzione delle terre causata “dalla speculazione immobiliare sfrenata e dall'apparizione di grandi società le quali forti dei loro mezzi giuridici e finanziari, danno il colpo di grazia ai piccoli proprietari, cacciando dalle loro terre gli indios e i contadini” . L'allontanamento dei contadini poveri dalle tradizionali regioni agricole, provocò in quegli anni gravi problemi sociali e la crescita di quelle baraccopoli alla periferia delle grandi città, che divenne uno dei maggiori mali della società brasiliana.
Il terribile periodo di violenze sulla popolazione ebbe termine progressivamente fra il 1974 e il 1979. Il paese ritornò alla democrazia, stremato tuttavia dall'inflazione e dal debito con l'estero, che divennero in breve il maggiore problema economico del paese.
Anche l'Uruguay conobbe una dittatura negli anni Trenta che ebbe tuttavia conseguenze modeste sulla vita della nazione, e non poté impedire il ritorno, anche se con alcune difficoltà, di una democrazia relativamente stabile. Nella seconda metà degli anni Sessanta il paese venne sconvolto da ondate di scioperi e dall'attività terroristica dei Tupamaros. L'organizzazione che aveva ripreso la sua denominazione da Tupac Amaru, uno degli ultimi capi Indios del Perù, si sviluppò come movimento guerrigliero urbano a differenza di quelli ispirati dal castrismo che avevano come principale terreno d'azione le zone rurali. I Tupamaros non costituivano un gruppo omogeneo dal punto di vista politico, se vi era convergenza nella lotta al capitalismo e all'imperialismo (sottinteso nordamericano), il movimento comprende-va tuttavia gruppi politici diversi, marxisti, anarchici ed anche cattolici. Secondo la testimonianza di un alto dirigente di banca che subì il sequestro da parte dei terroristi, i Tupamaros avevano una estrazione sociale determinata “A parte quelli che militavano nei ranghi rivoluzionari, per odio, per rancore, per essere o sentirsi protetti da delitti comuni commessi, e che erano i peggiori, c'erano gli scontenti, i frustrati, gli sconfitti della vita, gli oppressi o quelli che si sentivano tali. Una componente comune a tutti era il rifiuto di un mondo, di un sistema considerato decrepito e corrotto, il rigetto del liberalcapitalismo, anche perché esso appariva - in Uruguay - di marca soprattutto straniera” . L'organizzazione terroristica per un certo periodo di tempo mise in grave difficoltà le istituzioni, che furono costrette nel 1970 a proclamare lo stato d'emergenza, tuttavia il fenomeno non ebbe lunga vita, e nel 1972 venne definitivamente debellato.
La fragile democrazia venezuelana passata indenne all'ondata di dittature degli anni Trenta venne rovesciata nel corso degli anni Cinquanta. Secondo il giornalista americano Carl Mydans la corruzione rappresentava una grave piaga nel paese dove “i funzionari governativi avevano fatto man bassa dei redditi dei favolosi pozzi di petrolio venezuelani e l’economia si era fatta stagnate. Il 30 per cento del reddito nazionale veniva diviso dal 3 per cento della popolazione ed intorno alla lucente città di Caracas vi erano zone di miseri quartieri poveri” . Nella prima metà del decennio successivo il paese conobbe l'azione di un deciso riformista, Romulo Betancourt, che con il sostegno degli Stati Uniti procedette all'ammodernamento del paese, alla riforma agraria e alla lotta ai movimenti guerriglieri castristi. I movimenti di guerriglia sorti in quegli anni con il sostegno di Cuba infatti non fecero presa sulla popolazione (come appare dall’andamento delle elezioni del 1963 boicottate dai guerriglieri), e non riuscirono a raccogliere consensi né fra il proletariato urbano né fra i ceti rurali più interessati a miglioramenti graduali delle condizioni di vita che non ad azioni di forza.
Un attentato alla vita del presidente della repubblica organizzato dal dittatore della Repubblica Dominicana con l’appoggio dell’estrema destra, creò uno stato di tensione internazionale nell'area. Negli anni successivi il paese ha conosciuto una gestione del potere equilibrata che tuttavia non ha saputo sfruttare le opportunità offerte dalle grandi risorse minerarie del paese.
In controtendenza rispetto agli altri paesi dell'America Latina, il Cile non conobbe negli anni Trenta l'affermarsi della dittatura ed anzi il paese, relativamente evoluto, conobbe una discreta stabilità politica. Le tristi vicende di cui fu teatro negli anni Settanta, e che destarono timori anche nel mondo occidentale, sotto certi aspetti sembravano collegarsi più all'esperienza europea che a quella latino americana.
Nel 1964 il democratico cristiano di sinistra Edoardo Frei aveva inaugurato un periodo di profondi riforme nel campo fondiario, fiscale, nel settore dell'istruzione e in quello dell'industria del rame, che costituiva la maggiore risorsa del paese. La sua politica riformista tesa a migliorare le condizioni di vita delle categorie più deboli e a conferire maggiore autonomia al paese a livello internazionale, scontentò tuttavia l'opposizione di destra e di sinistra.
Alle elezioni del 1970 Unidad Popular, il fronte che raccoglieva le sinistre, ottenne una vittoria di misura con il 36% dei voti sul candidato delle opposizioni. Secondo l'allora ambasciatore americano “Il Cile ha votato senza agitazioni per avere uno stato marxista-leninista; è il primo paese del mondo che operi questa scelta liberamente” , tuttavia il fatto non poteva non destare allarme. Per Henry Kissinger numerose erano le ragioni per le quali questa situazione poteva suscitare apprensione in Occidente: “Ciò che ci preoccupa di Allende era la sua conclamata ostilità nei confronti degli Stati Uniti e la sua evidente intenzione di creare di fatto un'altra Cuba. Suo esplicito programma e sicuramente suo obbiettivo a lungo termine era quello di instaurare una dittatura irreversibile” . Tre anni prima della sua ascesa al potere, ricorda il segretario di stato americano nelle sue memorie, Allende era stato uno dei fondatori dell'Organizzazione per la solidarietà latino americana associazione finalizzata - in contrasto con la politica riformista dei partiti di sinistra del continente - alla “lotta rivoluzionaria armata” contro l'imperialismo nordamericano.
Negli anni passati Allende è stato ritenuto un moderato di sinistra che intendeva rispettare i principi democratici dello stato; Allende invece non nascondeva i suoi progetti rivoluzionari tesi ad uno stravolgimento dello stato. In una celebre intervista con lo scrittore francese Regis Debray, Allende esplicitamente parlava della esigenza di sottoporre il potere giudiziario al controllo politico e di prendere in considerazione il ricorso all'illegalità nel caso di non ben definiti attacchi dell'opposizione . Se i suoi propositi non trovarono attuazione, la ragione è da ricercarsi nella combattività dei partiti di minoranza e nel sostegno americano alla stampa contraria al regime.
Non appena costituito il governo Allende, che non disponeva della maggioranza in Parlamento, si ebbe l'avvio di un duro confronto con gli Stati Uniti. A differenza del governo Frei la nuova amministrazione intendeva procedere alla rilevazione delle imprese straniere con metodi autoritari e l'applicazione di un sistema di tassazione retroattivo che non poteva non produrre l'opposizione delle società nordamericane. In un suo discorso a Santiago poco dopo l'insediamento, il nuovo presidente sostenne che: “Potere popolare significa che la faremo finita con i monopoli, grazie ai quali poche dozzine di famiglie controllano le leve dell'economia; con un sistema finanziario posto al servizio del profitto e che ha concentrato il risparmio nazionale nelle mani dei banchieri e della loro fame di lucro. Nazionalizzeremo il credito per metterlo al servizio della prosperità nazionale e popolare. Elimineremo i latifondi che continuano a condannare migliaia di contadini alla sottomissione, alla miseria, impedendo che il popolo ricavi dalla sua terra tutti gli alimenti che gli necessitano. Questo sarà possibile solo con una autentica riforma agraria. Porremo fine alla denazionalizzazione sempre crescente della nostra industria e delle fonti di lavoro, e che ci sottomette allo sfruttamento straniero; recupereremo al Cile le nostre ricchezze fondamentali; restituiremo al popolo le grandi miniere” .
Parlando delle drammatiche vicende del Cile si è spesso parlato del ruolo delle compagnie straniere, le cosiddette multinazionali, nel contrastare la politica di Allende. Secondo le rivelazioni di un giornalista americano, la ITT, una delle grandi aziende americane minacciata di nazionalizzazione, era disposta a finanziare i gruppi politici contrari al leader comunista, ma occorreva anche ricordare che non esisteva un piano concertato contro l'economia cilena, e che in piena crisi, nonostante le ritorsioni americane, un gruppo di banche statunitensi accettò di rinegoziare il debito del Cile con l'estero, consolidando in tal maniera la posizione del governo social-comunista.
La riforma agraria mal gestita ed eccessiva, gli aumenti salariali privi di copertura finanziaria, e le numerose nazionalizzazioni, provocarono una grave inflazione nel paese che determinò un vasto malcontento. Contro una ondata di scioperi senza precedenti che paralizzò la vita del paese, il governo assunse un atteggiamento intransigente (fra i provvedimenti presi, il sequestro degli automezzi agli autotrasportatori in agitazione) e successivamente chiamò i militari ad assumere incarichi di governo. La situazione politica era già notevolmente deteriorata quando il governo propose una riforma del sistema scolastico finalizzata alla “edificazione di una nuova società socialista”, che provocò la reazione non solo dell'opposizione moderata ma anche della stessa Chiesa che fino allora aveva mantenuto un atteggiamento prudente.
Il governo Allende venne accusato di non intervenire per reprimere le occupazioni di terre e le violenze dell'estrema sinistra nel paese, e di minacciare con provvedimenti diversi la libertà di stampa, tuttavia alle elezioni per il rinnovo delle camere, tenute alcuni mesi prima del golpe la sinistra ottenne una discreta affermazione. Nel corso dei tre anni di governo social-comunista si parlò molto della presenza di armi e agenti cubani nel paese; lo stesso Allende con il suo estremismo verbale sembrava confermarlo, tuttavia la creazione di formazioni paramilitari costituiva probabilmente più una minaccia per piegare l'opposizione che una realtà. Soltanto nell'estate del '73 il governo decise la costituzione su vasta scala di gruppi armati comunisti, e la crisi precipitò quando il leader rivoluzionario volle sostituire al comando delle forze armate il moderato Prats con il più estremista Pinochet, ritenuto in quel periodo più fidato.
L'affidamento della massima carica militare al generale Pinochet (fino allora sconosciuto secondo la CIA), in sostituzione del moderato generale Prats risultò fatale al governo Allende che venne rovesciato nelle settimane successive. La nuova giunta militare venne inizialmente accolta favorevolmente nel paese, si riteneva infatti che i militari, tradizionalmente apolitici nel paese, si limitassero a riportare l'ordine e a indire nuove elezioni. Il generale Pinochet scatenò invece una ondata di arresti contro esponenti della vecchia giunta, sindacalisti, ma anche contro l'opposizione democristiana, che non accennò a diminuire negli anni successivi. Nel corso della seconda metà degli anni Settanta vennero represse le manifestazioni dell'opposizione, organizzata una polizia segreta, e colpiti gli oppositori anche su semplici sospetti. Secondo i calcoli di Amnesty International si ebbero in quegli anni almeno 4.000 vittime (30.000 stimate), alcune delle quali uccise anche fuori dal paese. Il regime militare attraverso una politica di libera-lizzazione riuscì dopo diversi anni a portare il paese fuori dalla crisi economica, ma venne duramente condannato dagli Stati Uniti, dalla Chiesa, e da buona parte della comunità internazionale.
I paesi delle Ande, abitati in prevalenza dalle popolazioni Indios, costituiscono la regione più arretrata del continente sudamericano; nonostante la ricchezza di materie prime, l'area incontra difficoltà notevoli al decollo economico e presenta problemi sociali molto gravi.
In Colombia le brutali dittature di Laurano Gomez e Rojas Pinilla vennero rovesciate nel '57, ma i nuovi governi non portarono il paese alla calma. Nel 1948 si ebbero disordini e saccheggi di gravissima intensità (ma privi di una chiara direzione politica) che portarono alla devastazione della capitale e proseguirono negli anni successivi. La instabilità politica caratterizzò il paese finché non venne sottoscritto un singolare accordo in base al quale i due maggiori partiti politici (che di fatto avevano lo stesso programma), si sarebbero alternati al potere negli anni successivi. La conseguente stagnazione politica ha favorito il diffondersi della corruzione e la nascita di un forte movimento di guerriglia che comprendeva gruppi comunisti, maoisti, cattolici, molti dei quali degenerati in associazioni a delinquere comuni. Negli anni Sessanta operò un gruppo capeggiato da un personaggio di spicco, Don Camilo Torres. L'intraprendente sacerdote riteneva che fosse una missione dei cristiani liberare il paese da quella oligarchia che da lungo tempo governava il paese. In un messaggio ai cristiani sostenne che “La Rivoluzione non è soltanto consentita, ma addirittura obbligatoria per i cristiani, che vedevano in essa l'unica maniera efficace e ampia di realizzare l'amore per tutti” . Secondo la testimonianza di Monsignor Camara “Camilo era un prete sincero ma a un certo punto, pur restando un prete e un cristiano, perse ogni illusione sul sogno che la Chiesa sapesse o volesse realizzare i suoi bellissimi testi. E pensò che il partito comunista fosse il solo in grado di fare qualcosa. Così i comunisti lo presero e lo spedirono subito in combattimento, laddove il pericolo era più grave. Avevano un piano in mente: Camilo sarà ucciso e la Colombia andrà a fuoco. Camilo fu ucciso ma la Colombia non andò a fuoco: né i giovani né i lavoratori si mossero” .
Alla fine degli anni Ottanta si scatenò in Colombia la guerra del narcotraffico che ha provocato numerosi attentati e centinaia di vittime. Il governo sostenuto dagli Stati Uniti ha riportato limitati successi. Contro il Cartello di Medellin, che controllava forse la metà del mercato mondiale della cocaina vennero riportati notevoli risultati, ma di fatto la soluzione del conflitto venne negoziata fra governo e narcotrafficanti, e molti laboratori di raffinazione vennero spostati per tacito accordo oltre la frontiera col Brasile.
Nel Perù operò un attivo partito socialista rivoluzionario, l'APRA, che tuttavia una volta raggiunto il potere alla fine degli anni Cinquanta, moderò notevolmente la sua politica, e incontrò numerose difficoltà a modificare la difficile situazione economica esistente. Nel 1968 un colpo di stato militare impose al paese un governo di sinistra che promosse vaste nazionalizzazioni nel settore industriale ed una riforma agraria che impose un sistema di cooperative contrario agli interessi della popolazione andina. L'impoverimento delle regioni agricole fu la causa di una massiccia immigrazione verso la capitale, dove si concentrava circa un quarto dell'intera popolazione del paese, fenomeno che provocò gravi problemi socioeconomici. Lo stato peruviano venne interessato a partire dal 1964, da movimenti di guerriglia che si insediarono nelle regioni interne più remote del paese, che persero di consistenza tuttavia negli anni successivi. Mentre nel resto del continente i fenomeni di guerriglia cessavano, nel 1980 con il ritorno alla democrazia sorse il gruppo maoista Sendero Luminoso che operò nelle aree rurali e in quelle urbane; il movimento che ha provocato numerose vittime, non ha incontrato il favore della popolazione ed è stato quasi completamente debellato dopo un'intensa azione di polizia nel 1992.
Una vita politica confusa ed estremamente travagliata ha caratterizzato lo stato boliviano, che dalla sua nascita ha conosciuto poco meno di duecento colpi di stato. La maggioranza della popolazione, come nel vicino Perù, era costituita da indios, che per lungo tempo furono soggetti ad uno stato di sudditanza nei confronti della popolazione bianca più evoluta. Tale situazione ebbe termine nel 1952 (a parte un breve tentativo negli anni precedenti) successivamente ad una sollevazione, che portò il socialista Paz Estenssoro al potere. Il governo da lui presieduto procedette alla nazionalizzazione delle società straniere che sfruttavano le notevoli risorse minerarie del paese, e avviò diverse riforme fra le quali una consistente redistribuzione delle terre. Il nuovo governo venne sostenuto dagli Stati Uniti che non fecero mancare il proprio sostegno economico al paese, tuttavia negli anni successivi i gruppi più a sinistra iniziarono a dare vita a scioperi e sommosse che misero in crisi la formazione politica al potere. Nel 1964 un colpo di stato militare mise fine all'esperimento riformista, e si impose negli anni successivi (fatto non raro in America Latina) un governo “rivoluzionario” combattuto da movimenti guerriglieri proclamantisi altrettanto “rivoluzionari”. Nel 1980 infine, si ebbe la cosiddetta “narcodittatura” che provocò dure repressioni con un notevole numero di morti.
L'America centrale in anni recenti presentava una situazione socioeconomica estremamente grave, in alcuni casi anche peggiore rispetto a quella dell'America meridionale. La proprietà delle terre risultava eccessivamente concentrata, le condizioni di vita di Indios e campesinos risultavano gravi, l'instabilità politica e la corruzione regnava incontrastata. In questa situazione si affermarono regimi e movimenti rivoluzionari che trassero origine dal diffuso malcontento, ma che non contribuirono comunque al miglioramento della situazione della regione. Una vasta letteratura negli anni passati ha presentato il mondo latino americano come il continente dove l'unica alternativa al predominio di latifondisti e dei politici corrotti fosse data dalla lotta rivoluzionaria. L'esperienza di Paz Estenssoro e Betancourt in America meridionale, Napoleon Duarte e Figueres in America centrale fa ritenere invece che esistessero movimenti favorevoli all'emancipazione sociale da attuarsi attraverso riforme graduali.
L'isola di Cuba si presentava come la più ricca delle nazioni dell'America centrale, tuttavia una spietata dittatura, che per un certo periodo si avvalse del sostegno esterno del partito comunista, aveva provocato il diffondersi della corruzione e del gangsterismo. L'economia dell'isola, fortemente legata agli Stati Uniti (oltre l'80% delle esportazioni dello zucchero era diretto al paese nordamericano) sembrava ben avviata, tuttavia esisteva una forte opposizione nel paese, e il governo negli ultimi anni non godeva più del sostegno del grande paese americano.
L'opposizione alla dittatura di Batista responsabile della morte di un gran numero di persone, era condotta principalmente da gruppi studenteschi nelle grandi città, e successivamente da un movimento di guerriglieri di diverse tendenze politiche appoggiati dalle popolazioni contadine locali che faceva capo a Fidel Castro. Secondo il giornalista britannico Paul Johnson, Castro in gioventù aveva assunto posizioni ambigue, e la singolare scarcerazione nel '56 da parte di un regime che era solito sopprimere gli oppositori confermerebbe tale ipotesi ; comunque il movimento guerrigliero si attestò saldamente sulle regioni montuose del paese, e da lì nel '59 mosse contro il governo di Batista che si dissolse senza quasi opporre resistenza. Anche negli anni successivi la politica di Castro risultò notevolmente contraddittoria. Nel '59 dopo aver affermato con insistenza la sua estraneità al comunismo - ribadita in una missione negli Stati Uniti - e la sua volontà di rispettare i possedimenti stranieri, decise improvvisamente l'ingresso dei comunisti al governo e la arbitraria nazionalizzazione di piantagioni agricole e raffinerie, che fu all'origine del grave deterioramento dei rapporti con la potenza nordamericana.
Poco tempo dopo il suo insediamento al potere il governo diretto dal coraggioso magistrato Urrutia, che negli anni precedenti si era opposto alle violenze del regime, venne messo nelle condizioni di non poter operare da parte degli uomini di Castro, il quale liquidò i gruppi democratici che avevano condotto l'opposizione alla dittatura, strinse un'alleanza con il partito comunista che era rimasto estraneo alle vicende insurrezionali, e iniziò una vasta opera di repressione. Nei mesi successivi si ebbero oltre ventimila arresti e centinaia di fucilazioni (secondo le stesse fonti governative) che sconvolsero il paese. Molte delle vittime erano ex rivoluzionari che come Hubert Matos avevano criticato il nuovo regime dittatoriale imposto da Castro, mentre il prestigioso combattente della Sierra Maestra, Camilo Cienfuegos, che si era rifiutato di deporre contro l'ex compagno condannato ad una lunga pena detentiva, venne trovato morto in seguito ad un misterioso incidente sul quale il governo si rifiutò di aprire un'inchiesta. Molte delle vittime vennero condannate senza un regolare processo, ma secondo la linea di governo sostenuta da Castro “La giustizia rivoluzionaria non si basa tanto su precetti legali, quanto sulla convinzione morale” .
Il regime di terrore non si attenuò nel corso degli anni. Fra il '65 e il '70 centinaia di migliaia di cittadini (mezzo milione secondo alcune fonti), soprattutto delle classi colte, fuggirono dall'isola, mentre le misure repressive non cessavano di farsi sentire. Nello stesso periodo decine di migliaia di dissidenti vennero arrestati e condannati senza processo (di cui oltre 7.000 fucilati), e un numero superiore costretto al lavoro obbligatorio nel settore agricolo per ottenere il diritto di espatrio. La repressione non risparmiava nemmeno i dirigenti politici della vecchia guardia rivoluzionaria; nel 1968 undici ex capi della rivolta del '59 vennero condannati per tradimento a lunghe pene detentive in seguito a processi che non offrivano garanzie di difesa per gli imputati. Infine nel quadro di una politica moralizzatrice, vennero abolite le case da gioco, colpita la prostituzione, e inviati gli omosessuali nei campi di rieducazione.
Con la riforma agraria vennero espropriate numerose proprietà americane, iniziativa che diede l'avvio ad un progressivo deterioramento dei rapporti con gli Stati Uniti. La reazione del paese nordamericano risultò inizialmente modesta, tuttavia le successive provocazioni e l'instaurarsi di contatti fra Cuba e l'Unione Sovietica, portarono ad uno stato di grave tensione internazionale.
La riforma agraria ebbe notevoli conseguenze economiche; si ebbe negli anni successivi l'allontanamento del personale qualificato di aziende agricole e raffinerie che provocarono una grave crisi economica e di approvvigionamenti, alla quale il governo dovette far fronte con l'introduzione del razionamento. Le riforme successive nel settore agricolo, che prevedevano la trasformazione delle cooperative agricole in aziende di stato sul modello sovietico, provocarono un ulteriore peggioramento della produzione agricola. Verso la fine degli anni Sessanta la politica economica venne inasprita, con restrizioni salariali e l’abolizione di qualsiasi forma di attività economica (compresa quella delle cosiddette piccole bancarelle) non gestita dallo stato. Nel periodo successivo comunque, con il ritorno all’allineamento a Mosca si ebbe una maggiore moderazione, un miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori agricoli, e l’introduzione del cottimo per gli operai.
Contrariamente alla politica degli anni precedenti di diversificazione della produzione agricola, nel 1969 Castro lanciò una campagna, la cosiddetta Zafra gigante, per l'incremento della produzione dello zucchero. Gli obbiettivi non furono raggiunti ed inoltre la sottrazione di risorse umane e materiali per la realizzazione del progetto, aggravò la situazione economica esistente. Gli ambiziosi programmi di industrializzazione e realizzazioni urbanistiche senza maestranze qualificate non ebbero maggiore fortuna e dovettero essere abbandonati abbastanza presto. Di fronte al fallimento economico della Rivoluzione, Castro sosterrà l'importanza delle conquiste morali e che occorreva “trasformare il denaro o la ricchezza in coscienza... e la coscienza in ricchezza” , anche se al di là del nazionalismo non vi è stata chiarezza a quali valori etici la collettività dovesse ispirarsi. Secondo il rappresentante del governo Allende a Cuba nel 1971 in seguito al fallimento economico di quegli anni, il governo cubano decise di affrontare “Il grave problema dell'assenteismo, che provocava l'oziosità e la delinquenza, al punto che al calare della sera, le strade dell'Avana non erano tanto più sicure, con due misure fondamentali: la bruciatura della canna e la cosiddetta ley de vagos”; la bruciatura della canna secondo gli esperti richiedeva una organizzazione del lavoro che il paese non possedeva, mentre la legge contro gli oziosi “stabiliva in pratica”, è sempre il diplomatico cileno che parla, “il lavoro generale e obbligatorio in tutta l'isola, fissando sanzioni che arrivavano fino all'imposizione dei lavori forzati per i recidivi” . Anche il piano di industrializzazione del paese non ebbe migliori risultati; secondo la stampa jugoslava molti macchinari acquistati dall'Unione Sovietica rimasero inutilizzati, e un gran numero di impianti non vennero portati a termine per incapacità dei responsabili L'economia del paese risentì anche delle eccessive spese militari del paese che fecero dell'esercito cubano il più potente dell'America Latina dopo quello brasiliano, spese che provocarono una riduzione degli investimenti nel campo produttivo.
Anche Cuba ebbe la sua Rivoluzione Culturale; Castro nel 1966 sostenne che il rivoluzionario autentico doveva porre “La Rivoluzione sopra ogni cosa, e l'artista rivoluzionario sarà quello pronto a sacrificare perfino la sua vocazione artistica per la Rivoluzione” ; l'apparato culturale del paese venne affidato all'esercito, sebbene le forze armate non avessero i requisiti idonei per una gestione del delicato settore, e venne stabilito per il personale amministrativo - anche qualificato - turni di lavoro nel settore agricolo, iniziativa che creò notevole malcontento.
Per un certo periodo Castro ritenne di poter svolgere una politica autonoma da Mosca e di porsi come guida di un vasto schieramento di paesi e movimenti rivoluzionari del Terzo Mondo. A tal fine venne convocata nel 1967 una conferenza passata alla storia come la Tricontinentale, dove venne stabilito che la lotta all'imperialismo doveva essere condotta con il ricorso alla lotta armata e la “vietnamizzazione” del continente latino americano, tuttavia non molto tempo dopo Castro fu costretto a rinunciare ai suoi ambiziosi progetti; Cuba si allineò a Mosca nella condanna del comunismo cinese, rinunciò a molte delle azioni contro i paesi latino americani, e approvò l'invasione della Cecoslovacchia da parte dell'URSS. Nonostante le precedenti affermazioni sui diritti delle nazioni deboli nei confronti delle superpotenze, Cuba venne sempre più a dipendere economicamente da Mosca, e negli anni Settanta reparti di mercenari cubani vennero inviati a difendere alcuni dei regimi più squalificati dell'Africa.
Una dei massimi personaggi della rivoluzione cubana e sicuramente il maggiore teorico della rivoluzione in America Latina, fu il leggendario Ernesto Che Guevara. Secondo il capo rivoluzionario “Per costruire il comunismo contemporaneamente alla base materiale bisogna fare l'uomo nuovo. Per questo è così importante lo strumento della mobilitazione delle masse... La società nel suo complesso deve diventare una gigantesca scuola”. Al “Che” è legata la figura dell'eroe romantico latino americano, in uno dei suoi scritti ricordava che “Il vero rivoluzionario è guidato da grandi sentimenti d'amore... i nostri rivoluzionari d'avanguardia devono idealizzare questo amore per l'umanità, per le cause più sante, e farlo unico, indivisibile” . Che Guevara sosteneva nei suoi scritti che occorresse creare in America Latina e nell'intero Terzo Mondo “molti Vietnam” per combattere l'imperialismo e lo strapotere degli yankee nordamericani, che vedeva come i responsabili del sottosviluppo del sud del mondo. Pertanto il governo avrebbe dovuto assumere maggiori iniziative nel campo della guerriglia, e provvedimenti più radicali in economia. Tali opinioni lo posero in contrasto con la politica più realistica di Castro, lo spinsero a lasciare Cuba e a riprendere, solitario, la via della guerriglia; nel 1967 trovò la morte in Bolivia dopo un fallito tentativo di dare vita a un gruppo guerrigliero.
Una situazione profondamente diversa da quella degli altri paesi del Centro America si è avuta in Costarica, ritenuta per diverse ragioni la “Svizzera dell'America Latina”. Il piccolo paese ha conosciuto negli ultimi decenni un discreto sviluppo economico, una notevole stabilità politica, ed un sistema democratico che non aveva molto da invidiare a quelli più avanzati. Tale situazione è stata favorita dalla assenza del latifondo e dall'elevato livello socioculturale delle popolazioni, che hanno consentito al paese di superare il sistema delle oligarchie di potere e i contrasti etnico politici.
Il padre del Costarica moderno è stato il socialdemocratico Josè Figueres che sconfitto il più autoritario Calderon, diede il via nel 1953 ad un processo di importanti riforme. Il nuovo capo di stato ispirandosi al modello delle socialdemocrazie del nord Europa decise la nazionalizzazione delle banche e dell'energia elettrica, l'emanazione di provvedimenti a favore della piccola proprietà agricola, e fatto abbastanza singolare, l'abolizione delle forze armate, così come previsto nel suo programma di governo “mas maestros que soldados”. Molte delle caserme vennero trasformate in scuole, e nel campo della istruzione e della sanità vennero raggiunti importanti risultati. Per un lungo periodo di tempo il Partido de la Liberacion National diretto da Figueres conservò il potere, negli anni successivi parte dello stato sociale venne abolito a causa del grave debito pubblico accumulato e delle richieste del Fondo Monetario Internazionale, tuttavia il paese continuò a costituire un valido modello politico ed economico per il resto del continente.
Haiti per la sua composizione etnica costituisce una specie di isola africana all'interno del Mar dei Caraibi, fattore che ha influito notevolmente sulla sua vita politica. Sebbene non privo di risorse naturali, l'isola ha conosciuto una vita politica molto travagliata. Nel 1957 Francois Duvalier impose sulla piccola repubblica una spietata dittatura attraverso il ricorso a bande criminali (i Tontons macoute) e fomentando le aggressioni contro i mulatti da parte della maggioranza nera. Il disordine e la corruzione provocarono la fuga di oltre 800.000 haitiani (su un paese di sei milioni di abitanti) mentre la produzione agricola scese a livelli notevolmente inferiori rispetto a quelli dei secoli precedenti. Morto Papa Doc, come veniva comunemente chiamato il dittatore, gli successe il figlio Baby Doc che continuò l'opera del padre e venne rovesciato dai militari nel 1986. Quattro anni dopo venne eletto presidente della repubblica l'ex sacerdote Jean-Bertrand Aristide, ma per il suo impegno nella lotta ai narcotrafficanti venne allontanato dal potere alcuni mesi dopo. Gli Stati Uniti si impegnarono per il ritorno del paese alla democrazia, ma solo nel 1994 dopo un duro braccio di ferro con i militari al potere, il legittimo presidente poté fare ritorno nel paese.
L'altra metà dell'isola, la Repubblica Dominicana ha conosciuto anch'essa una difficile vita politica. Nel 1930 salì al potere il colonnello della polizia Rafael Trujllo (chiamato dalla stampa al suo servizio el Benefactor) che favorì lo sviluppo economico del paese ma impose una dittatura personalistica facendo ricorso alla corruzione e ad un uso spregiudicato delle forze di polizia. Per decenni il paese venne amministrato come un feudo personale della famiglia del dittatore, che nelle loro stravaganze imposero negli anni precedenti la seconda guerra mondiale il cambiamento della denominazione della capitale San Domingo, che venne ribattezzata in Ciudad Trujllo. Verso la fine degli anni Cinquanta il governo si pose in contrasto con gli altri paesi dell'OSA e gli Stati Uniti, e ritenuto responsabile di un attentato alla vita del capo di governo venezuelano, venne sottoposto ad isolamento internazionale.
Nel 1960 il dittatore venne assassinato (su cospirazione della CIA secondo alcuni), ma l'abbattimento della dittatura non favorì il ritorno alla normalità. Alle elezioni del 1962 venne eletto presidente il socialista Juan Bosch, il cui governo incontrò notevoli difficoltà a gestire la difficile situazione del paese e venne dopo breve tempo rovesciato da un colpo di stato. Nel paese si fronteggiarono gruppi politici e militari favorevoli e contrari al deposto presidente, situazione alla quale pose termine l'intervento militare degli Stati Uniti e di altre truppe dei paesi dell'OSA. L'azione americana, tesa principalmente a prevenire una possibile azione dei comunisti nel paese, favorì l'accordo fra le diverse formazioni politiche, e negli anni successivi il paese conobbe una relativa stabilità.
Rispetto agli altri paesi dell'America centrale il Salvador presentava un grave problema di sovrappopolazione che aveva provocato nel passato una serie di attriti con i paesi vicini. Come riconobbe l'ex segretario di stato americano Alexander Haig, il paese presentava dei problemi sociali molto gravi ed una proprietà fondiaria concentrata nelle mani di una oligarchia che controllava da sempre il potere. La guerriglia che si scatenò nel paese negli anni Ottanta costituiva la conseguenza di questa situazione di malessere, ma anche dell'opera di agitatori estremisti sostenuti da Cuba. Secondo fonti americane infatti operavano nel paese e nel vicino Nicaragua circa duemila istruttori cubani e sovietici per l'addestramento dei guerriglieri del Fronte Farabundo Martì, agenti che di fatto gestivano il movimento rivoluzionario.
Nel 1979 un colpo di stato militare e un progetto di riforme mal gestito furono all'origine di un aggravamento della tensione già presente nel paese. Nel marzo dell'anno successivo si ebbe l'assassinio dell'arcivescovo Oscar Romero che costituì uno dei più gravi delitti di cui fu vittima la Chiesa nel continente. L'alto prelato ucciso da una delle formazioni dell'estrema destra aveva spesso preso le difese della gente più povera del paese e sostenuto la formazione di associazioni fra lavoratori contro quella che venne definita ufficialmente dalla gerarchia ecclesiastica la “minoranza aggrappata alla ricchezza e al potere”. Non molto tempo dopo i militari si ritirarono dal potere, e nelle successive elezioni venne eletto presidente l'esponente della democrazia cristiana Napoleon Duarte, che promosse una vasta riforma agraria, la nazionalizzazione di alcuni settori economici del paese, e la apertura di negoziati con la guerriglia. Contrariamente alle aspettative, l'esponente democristiano sostenuto dagli americani venne battuto alle elezioni successive dal movimento di destra nazionalista di Robert D'Abuisson, che godeva del consenso di quella parte del paese contraria ad una trattativa con i ribelli.
Giunto al potere il leader politico comunque moderò notevolmente la sua politica. Il conflitto ebbe termine nel 1992 con l'intervento dell'Organizzazione degli Stati Americani, attraverso trattative che prevedevano garanzie per gli ex rivoluzionari, che divisi in opposte fazioni avevano difficoltà a concertare un'azione comune.
Dal 1936 il Nicaragua aveva conosciuto la dittatura corrotta e spietata della famiglia Somoza contro la quale si costituì un vasto raggruppamento, il Fronte sandinista di liberazione nazionale comprendente uomini di diversa estrazione sociale, dal mondo imprenditoriale, al sindacato, e al clero. Nel 1979 in seguito al blocco degli aiuti americani e al diffondersi di una sanguinosa guerra civile il dittatore fu costretto a cedere il potere e ad abbandonare il governo del paese alle formazioni politiche antagoniste.
Il governo sandinista al cui interno la fazione comunista filocubana aveva preso il sopravvento, decise la nazionalizzazione di diversi settori economici, un aumento eccezionale delle spese militari, che fecero dell'esercito del Nicaragua il più potente dell'America centrale, e diverse misure per mettere a tacere la stampa e i gruppi politici d'opposizione. Le misure del governo provocarono il collasso economico del paese e portarono alla crescita vertiginosa dell'inflazione che raggiunse in breve tempo il 35.000%. I provvedimenti contro l'opposizione provocarono l'uscita degli esponenti democratici dal governo fra i quali la Violeta Chamorro, la coraggiosa direttrice del più importante quotidiano del paese, e il comandante rivoluzionario Eden Pastora che si unì ai Contras, i gruppi armati contrari alla dittatura (fra i quali già militavano numerosi ex rivoluzionari) che operavano ai confini dell'Honduras.
Negli anni successivi il governo decretò il trasferimento coatto degli indios Misquitos nelle regioni interne del paese, l'incarcerazione di numerosi (circa duemila) oppositori politici, e giunse ad uno stato di tensione con il Costarica e l'Honduras, ma il sostegno americano alle formazioni dell'opposizione impedì il rafforzamento della dittatura.
Su iniziativa del presidente del Costarica Oscar Arias, Premio Nobel per la pace, venne proposto un piano di pacificazione nel 1987 che prevedeva un'amnistia per i detenuti politici, il ripristino della libertà di stampa, e nuove elezioni politiche con la presenza di osservatori internazionali. L'accordo pose fine a undici anni di guerriglia nel corso dei quali si erano avuti 30.000 morti, e consentì la salita la potere della Chamorro che riportò gradualmente il paese alla normalità
Una storia profondamente diversa da quella degli altri paesi del continente latino americano ha interessato il Messico nei primi decenni del nostro secolo dove una rivoluzione con alterne vicende, che ha fatto ritenere possibile per un certo periodo di tempo una svolta comunista, aveva prodotto una serie di importanti riforme che andavano dalla eliminazione del latifondo, alla nazionalizzazione delle società straniere, alla persecuzione della Chiesa, un tempo molto potente nel paese.
Le riforme degli anni Trenta non consentirono tuttavia né lo sviluppo economico del paese, né un miglioramento delle condizioni di vita dei campesinos a causa di una gestione eccessivamente centralizzata dell'economia, che produsse gravi problemi di approvvigionamento alimentare, e portò alcune regioni ad una situazione di carestia. Negli anni successivi il Partido Revolucionario Institucional moderò notevolmente la sua politica, tuttavia la corruzione e l'eccessiva presenza dello stato nell'economia (che raggiunse a controllare il 75 per cento dell’attività economica) e all'interno delle organizzazioni sindacali non ha favorito il progresso del paese, né uno sviluppo armonico delle sue numerose risorse.
La scoperta del petrolio nel paese ha rilanciato la disastrata economia del paese, ma il periodo euforico fu di breve durata, negli anni Ottanta il paese fu sull'orlo della bancarotta, mentre il debito con l'estero e l'inflazione divennero inarrestabili. La crisi causata dall'eccessivo gonfiamento della spesa pubblica, (non diversa da quella di Brasile e Argentina negli stessi anni) ebbe termine con la svolta liberista del 1989. Il presidente Solinas decise la privatizzazione delle più grandi aziende di stato, l'incentivazione degli investimenti stranieri, e un maggiore rispetto dei principi democratici, ma se per un certo periodo sembrava che il paese si avviasse verso il risanamento dell'economia, nel 1994 la crisi si riaffacciava con estrema gravità nonostante gli aiuti americani.